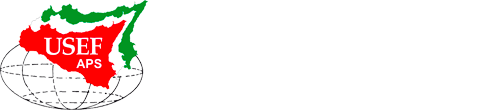GERMANIA - ARRIVA IL COLLETTIVO BAI A WOLFSBURG: ESPRESSIONE DELLA PIU' RAFFINATA RICERCA ARTISTICA DELLA SCUOLA DI COMISO (SICILIA)
GERMANIA - ARRIVA IL COLLETTIVO BAI A WOLFSBURG: ESPRESSIONE DELLA PIU' RAFFINATA RICERCA ARTISTICA DELLA SCUOLA DI COMISO (SICILIA) Arriva a Wolfsburg in Germania dalla natia Comiso il Collettivo BAI che apre la mostra delle opere del collettivo con il vernissage del I° dicembre e l'apertura al pubblico il 2 dicembre fino al 20. alla Galleria creARTE in collaborazione con l'Agenzia Consolare di Wolfsburg,
Del collettivo Bai fanno parte gli artisti Vittorio Balcone, Giovanni di Nicola, Atanasio Giuseppe Elia, Luigi Galofaro, Emanuele Elio Licata, Michele Licata, Rosario Lo Turco, Raffaele Romano, Giuseppe Salafia, Gesualdo Spampinato, che espongono le loro opere contemporaneamente per esaltare la "cultura del luogo" laddove si elevano fortemente la loro individualità nell'unità dei percorsi.
Il collettivo nasce nel 2006 come Bottega d’Arte Ippari (Ippari, il fiume che costeggia il territorio di Comiso, oggi solo un torrente) e riassume il senso dell'iniziativa nell'acronimo BAI.
Il Collettivo, non è un “gruppo” - tengono a precisare gli artisti - poiché non vi è una visione unilaterale del problema, né un’ideologia comune, sia dal punto di vista artistico che intellettuale. Ma non è neppure un manifesto programmatico che ne esalti le finalità teoriche. Semplicemente è un “collegamento” di artisti che tendono a convogliare al centro la “cultura del luogo”. Collettivo d’intenti, quindi, di un programma espositivo, all’interno del quale emergono fortemente le individualità (positive o negative che siano),perché ciò che interessa non è l’assoggettamento al pensiero dominante ma la diversità nell’unità dei percorsi. Ogni artista, infatti, persegue le finalità che hanno motivato l’origine della propria opera all’interno di un pensiero comune,in un momento in cui tutto sembra disgregarsi e perdersi nell’esasperazione dell’economia del mercato internazionale.
La loro - commentano i critici d'arte - è una fresca ventata nel contesto della Scuola d'Arte di Comiso che, più che altro, aveva il compito di valorizzare il tradizionale artigianato ibleo. La situazione è mutata nel 1956 quando l’arrivo di Germano Belletti, chiamato da Perugia a dirigere la scuola, con una squadra di giovani insegnanti che rivedono il progetto didattico della Scuola. Un progetto che ha liberato tutte le potenzialità latenti dei giovani artisti mettendo in campo nuove e forti personalità che costituiranno, poi, la base della ricerca artistica che partendo da Comiso si riverserà con successo in molti ambienti di cultura in Italia e all’Estero
Van Gogh, Modigliani, Carrà, Morandi, De Chirico, Martini, Viani, Marini, e soprattutto Picasso, erano i più gettonati, artisti capaci di far sognare i ragazzi che cercavano con passione e tenacia di emularli. Fra i tanti emerge il gruppo composto da Vittorio Balcone, Giovanni Di Nicola, Atanasio Giuseppe Elia, Luigi GaIofaro, Elio Licata, Michele Licata, Saro Lo Turco, Raffaele Romano, Giuseppe Sala fia, Gesualdo Spampinato. E' con loro che si apre a Comiso una stagione di straordinario interesse e di proficua collaborazione tra i componenti il gruppo che li vede accomunati nella ricerca di strade che portano, pur nel lavoro fianco a fianco, ma senza un programma comune, ad una autonomia di linguaggio per l’affermazione delle singole personalità: lo “Studio”. Le numerose mostre personali e collettive alle quali il gruppo ha partecipato negli anni e continua ancora oggi a tenere, poi, hanno fatto e fanno il resto.
L'arte di Raffaele Romano nizialmente ruota attorno a temi piuttosto familiari, come la ricerca di un lavoro nelle grandi città del nord, con la rappresentazione di uomini scheletrici del sud, schiacciati quasi dall’enorme peso dei loro bagagli all’uscita del treno o delle grandi stazioni affumicate dagli sbuffi delle pesanti macchine a vapore degli anni Sessanta. La sua attività, maturata all’ombra di alcuni grandi personaggi italiani come Melotti, le sue conoscenze di designer e pubblicisti, che gli hanno permesso inizialmente di sopravvivere (anche se poi lo hanno invitato ad allontanarsi da tale attività a causa di una sua precisa cifra “creativa” non consona all’attività “coercitiva” a cui è chiamata la pubblicità), l’illusione causata dalla frequentazione dell’atelier di Fiume ed altre peripezie nell’ambiente milanese, lo hanno portato a sfiorare, percorrendo per lunghi sentieri, un itinerario artistico a partire dai greci ai giorni nostri. Sintomatica l’attività grafica, ricca di riferimenti classici, espressionistici e surreali.
Si deve a questi estesi prolungamenti nel sentiero del pensiero umano se in questi ultimi anni si sia stabilizzato attorno a tematiche dove l’intervento immaginativo trova una sua libera espressione. Si tratta di una visione del mondo stellare ed in particolare di quella vibrazione che giunge a noi attraverso la luce, e più precisamente attraverso il colore. Che tali vibrazioni manifestino un comune denominatore con i Labirinti, è quanto meno il dato più certo. Quanto di questa rappresentazione con-muove l’osservatore, nel senso che lo induce ad iniziare un movimento che lo spinga ad uscire dal labirinto, risponde perfettamente a quella vibrazione che la materia cromatica suscita nell’uomo. E non si tratta semplicemente di una vibrazione fisica, quale quella causata da uno spostamento dovuto ad abbagli luminosi di natura differenziata, ma di uno spostamento dovuto alla lieve percezione delle frequenze emesse dai colori. Vibrazione blu-giallo, 2007, Vibrazione ocra, 2007, ecc. giocano sia sullo iato temporale espaziale dei flussi cromatici (del giallo, del verde e del blu nel caso di Vibrazione blu-giallo), ma anche sulle frequenze degli “interspazi” che questi fermenti materici causano quando si passa da un corpo all’altro, da una macchia all’altra, da un organismo all’altro. E parliamo di organismi per il fatto che ogni punto, ogni macchia, si muove nel campo come un essere vivente, una specie di cellula di cui è fatto il nostro corpo, e perciò il nostro universo. La rete che si determina non solo pone in stretta relazione le varie cellule ma crea un forte tessuto che rende ancor più “vibrante” l’atto percettivo. Ad aumentare il battito cardiaco non è solo la variazione tonale ma anche cromatica. Centro e periferia dell’opera giocano un ruolo importante perché se da una parte si presentano come un vortice aggregante, dove lo sguardo è costretto a muoversi, dall’altra si pongono come vortice centrifugo, capace di catapultare lo sguardo verso i limiti esterni del quadro. Tale alternanza di metodo, centripeto e centrifugo, è la scaturigine di quelle vibrazioni non “cercate” che immettono l’osservatore in uno stato di tensione percettiva in balia delle frequenze stabilite dall’artista. Non è un caso, infatti, se nella ricerca di Romano vi è una necessità di volgere verso l’alto lo sguardo dove gli astri – le stelle e i pianeti, appunto – si impongono sia come “costruzione” parallela a quella del tessuto connettivo cellulare, sia come termini di vibrazione universale. Si deve a tale necessità il percorso ultimo iniziato da Romano come una forma di sintesi tra la parte mitologica e surreale dei primi anni e quella attuale contrassegnata da una maggiore identificazione con la pulsione del creato.
A suo fianco si può situare l’opera di Emanuele Licata. Rispetto a Romano, Licata si muove su un piano storico di perenne stabilità. Il suo trasferimento a Gubbio, nella fervida Umbria, il suo coniugare l’attività artistica con quella educativa, il fatto di vivere in una città dal temperamento forte, legata al passato ed in particolare al mondo etrusco e romano, gli hanno fornito certamente una solidità culturale che gli ha permesso di non allontanarsi più di tanto da certi temi propri della gente eugubina. Mi riferisco alle sue continue immersioni nel mondo della scienza e della letteratura che hanno reso universale il tema delle Tavole eugubine. Il mistero, il desiderio di filtrare alcune delle conoscenze venute alla luce con la decifrazione delle Tavole, la volontà di fornire ad esse una consustanzialità con le forme della scultura, ecc. lo hanno reso consapevole della loro fortunosa pregnanza artistica sul cuore dell’uomo. E’ ovvio che le Tavole eugubine sono solo un modo per inoculare una conoscenza, ovvero una cultura che va oltre la semplice acquisizione conoscitiva del messaggio in esse inciso. Per Licata non si tratta di un’operazione di riproposizione del testo delle Tavole quanto una modalità che a partire dal mistero insito delle Tavole si possa ritrovare in sembianze modificate all’interno di un manufatto artistico. Un mistero che è religioso, è vero, ma è anche psicologico; ed è quello che interessa l’artista, poiché per Licata non è importante il ripercorrimento di una realtà altra, passata o futura che sia, ma la realtà dell’arte, il mistero che la circonda, i presupposti culturali da cui si origina e che riesce a proporre attraverso selezionati sistemi. Licata, difatti, si muove con fare meticoloso, come un religioso che ha nei riguardi della materia una eterna venerazione e la modella in modo che nel perdere la caratteristica di “materia pagana” possa assumerne un’altra, quella di un medium sacro, perciò inviolabile. Chi si accinge a guardare le Tavole eugubine di Licata, sia la n. 11 che la 9 o la 2 – tutte del 2008 -, ecc. si troverà disorientato se si aspetta di trovare il testo delle Tavole decifrato o un altro promosso dall’artista. Ciò che a Licata interessa – ed è la ragione per cui vi ha dedicato molto tempo della sua vita, a conferma dell’importanza che le stesse Tavole hanno nella vita culturale di un popolo -, è il senso del mistero che da queste si eleva quando vengono a contatto con l’osservatore. Se nelle Tavole il mistero è contenuto nell’alfabeto “paleoumbro” e “neoumbro”, nell’opera d’arte è la struttura formale degli elementi materici (acciaio inox, alluminio, rame, ottone, ecc.) che, sostituendosi al segno verbale, assume la connotazione di un linguaggio visivo, plastico, atto ad essere visionato da ogni parte. Ebbene, tale conformazione, seppure non legata ad un messaggio specifico, se non a quello dell’arte, e dunque alle sue diverse declinazioni, si impone proprio come struttura plastica che, seppure non oggettivamente interpretabile, nasconde un senso di mistero che la uniforma ai segni incisi sulle Tavole. Si potrebbe anche dire che ogni opera proposta da Licata è la selezione di alcuni segni trasferiti da un supporto piatto ad uno tridimensionale. E’, in altri termini, il lato nascosto delle lettere dell’alfabeto paleoumbro, e dunque una forma di mistero ancora più sottile perché mette in mostra la struttura dei significanti velati nel testo originale. Il fatto di potervi girare attorno, di scandagliare singolarmente i vari elementi, di percepire le distanze che nel testo risultano appiattite, arricchisce di senso l’opera, la rende più emozionante e voluttuosa.
Ma c’è un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione, e questo riguarda l’aspetto materico della lettera, la sua fisicità. Potendola toccare e percorrerne tutti gli anfratti, la sensazione che si riceve è la sua “penetrabilità” sia di senso che di materia: non, perciò, un mistero legato alla semplice percezione visiva della lettera ma la sua compenetrazione mediante la fruibilità perlustrativa. Entrare in sintonia col mistero equivale anche a risolverlo, accoglierlo nel proprio intimo e sciogliere ogni possibile riserva: il mistero si trasferisce in noi, ci avvolge e ci fa con-partecipi. Allontanandoci siamo certi di portar via parte di quel fascino che in tempi remoti era solo la possibilità di un sogno.
Ma vi è un altro personaggio che merita altrettanta attenzione per il fatto che pur muovendosi nell’ambito del bidimensionale, qual è appunto la pittura, ha registrato sensazioni difficilmente codificabili. Si tratta di Atanasio Giuseppe Elia. Anche Elia, seppure connesso col mondo dell’arte a livello internazionale, ha studiato presso l’Istituto d’Arte di Comiso e si è successivamente trasferito a San Cataldo (CL). Se da una parte la permanenza, come nel caso di Licata, può determinare un attaccamento allo spirito del luogo, per Elia i fatti risultano diversi. Non solo per la natura rigorosa del personaggio ma anche per la sintesi di culture diverse, quella greca (nasce infatti a Patrasso), quella siciliana, rappresentata in particolare dalla commistione di cultura greca e araba, e quella internazionale, rappresentata dal mondo dell’arte. A mettere insieme queste diverse entità culturali è il concetto di movimento offerto dall’acqua del mare. E’ ovvio che quando si parla di mare non si intende essenzialmente la Sicilia, ma quella inevitabile ingerenza che spesso ha la cultura internazionale sull’opera dell’artista. Ed Elia non disdegna che questa diventi un possibile aggancio, senza tuttavia lasciarsi coinvolgere nei processi di adattamento. Non esiste infatti, nell’ambito dell’attività artistica di Elia, alcun bilanciamento con un sistema che non sia la conseguenza di una profonda conoscenza delle possibili vie che l’arte può percorrere. Nella complessità di tale meccanismo, nella valutazione silenziosa del luogo quale musa che ispira e accompagna l’artista, qualsiasi particolare, qualsiasi forma che è resa vitale dal suo divenire, costituisce una porta di accesso alle profondità dell’anima. Se l’acqua, e il suo instancabile movimento, ha rappresentato per molti una fonte di vitalità a cui ricorrere ogni volta che si è invasi dalla solitudine, per Elia costituisce una metafora della vita umana, chiamata a muoversi contro ogni possibile volontà di stasi, ed in questo incessante movimento l’essere sembra inebriarsi e trovare linfa alla propria creatività; un movimento, quello dell’acqua, che è movimento anche della coscienza, la quale permette di trasferirsi da un posto all’altro senza abbandonare il proprio. Un viaggio che perdura nel tempo; un viaggio silenzioso, ma fluttuante, capace di raccogliere da tali trasporti la vera ragione del nostro “esserci”.
Per Elia il viaggio continua; e continua trasferendo le proprie impressioni sul supporto che è il “diario” di tale viaggio: un viaggio del cuore, ma anche un viaggio della mente, cui si accompagna la storia che lo ha visto partecipe. A questo viaggio Elia si abbandona con la consapevolezza che non può che uscirne arricchito. E’ il viaggio che permette di raccogliere nella memoria i movimenti del tempo, le culture di un popolo, le intemperie della vita, gli incontri occasionali, che spesso diventano tanto radicali da non poterne fare a meno.
Ma l’artista non si muove dal suo luogo, non intende abbandonare la sua musa. Il suo è un viaggio onirico, un viaggio che si è sempre pensato di realizzare non appena toccato i piedi su questa terra. E’ il viaggio che ha iniziato in grembo alla mamma. E’ sempre quel “natante” che intende continuare il suo viaggio tra le onde delle acque per perseguire una sua realizzazione di vita. Ed è all’interno di questo “mare” che l’artista continua ad offrire i segni di quel percorso mai interrotto.
E’ vero, il viaggio registra momenti di sconforto, di rotture; eppure nella memoria primeggia il suo fascino. L’opera, che rappresenta la trascrizione “realistica” di tale viaggio, continua a registrare tali perturbamenti mediante accavallamenti e sovrapposizioni di colori e di forme dove il pigmento si pone come segno tangibile delle sensazioni subite. In Viaggio onirico 4 e 16, del 2009, l’artista, tuttavia, non si lascia deviare dal potere del fascino e fa di tutto perché il “racconto” resti quello dai lui vissuto. Certo della sua capacità di narratore, l’artista offre nei particolari le rotture, gli abbandoni, gli strappi che il viaggio inevitabilmente comporta. Strappi sovente non definitivi, considerato che filamenti materici continuano a creare un rapporto tale da costituire nuovi possibili percorsi. Strappi che mettono in chiara visione il profondo baratro su cui si muovono e su cui aleggiano, come sospese per tensione emotiva, le lacerazioni. Ma non solo, l’artista non offre solamente una possibile decodifica “visiva” ma interviene ad offrircene una di tipo “verbale”. Ogni filamento è significante, traccia sensibile di un significato che attende d’essere decifrato. L’artista racconta il suo viaggio, lo descrive come se avesse a sua disposizione una penna piuttosto che un pennello e lascia all’osservatore percepire non solo il piacere del viaggio ma anche la sua pericolosità. Tutto, infatti, può infrangersi ed indurre ad aprire gli occhi alla realtà; ma è un viaggio che attrae e mobilita interiormente. La stessa presenza di pochi colori, il giallo che perde cromia trasformandosi in bianco o facendosi “percuotere” dal profondo blu, su cui galleggia una piccola membrana di rosso, è indicativa del numero ridotto di significanti a disposizione per una migliore accoglienza del senso ultimo dell’opera. Ma anche là, dove sono diverse tonalità cromatiche a dominare, il significato ultimo non cambia a motivo delle diverse stratificazioni dovute alla sovrapposizione dei momenti che lo hanno sostanziato. All’osservatore non resta, perciò, che continuare virtualmente questo onirico viaggio perché non sempre il suo si distanzia così tanto da quello dell’artista da non trovare legami di particolare profondità.
Da Patrasso a Tripoli il passo non è breve ma particolarmente seducente perché Vittorio Balcone lo ha fatto servendosi dell’Istituto d’Arte di Comiso come ponte per giungere a Atanasio Giuseppe Elia. Partecipe dello stesso progetto culturale, quello del Collettivo BAI, Balcone non solo ha attraversato il Mediterraneo ma un secolo di cultura “plastica”, quella, per intenderci, della scultura. L’approdo all’attuale elaborazione della forma ha alle spalle una lunga esperienza artistica che lo ha portato dalla figurazione alla libera espressione plastica. Gli elementi portanti, da cui l’artista ha tratto ispirazione, sono senza dubbio gli espressionisti Rossi e Rodin, ma ciò che nella sua opera domina è il plasticismo di Moore, che si è in seguito trasformato in una sorta di forma sciolta come a calcare l’esempio della fluidità dell’acqua e del suo imprevedibile sviluppo. Già questi semplici cenni permettono di cogliere alcuni aspetti che ruotano attorno al pensiero del movimento, del fluire del tempo, e dunque della vita. Per l’artista il senso di tale movimento non si lascia fruire attraverso la semplice natura del materiale utilizzato, come nel caso del legno, ove il sistema degli anelli permette di stabilire gli anni, ma in particolare dalla scioltezza della forma, dalla sua “classica” levigatezza. Alla sinuosità della linea, che si lascia percorrere con lo sguardo senza causare alcun disturbo visivo o interruzione fisica, si affianca la purezza della forma, la piattezza dei piani su cui gioca la luce. Il fatto degno d’attenzione della poetica di Balcone non è tanto l’idea di abbandonare il figurativo per passare alla fluida forma plastica, ma il percepire in tale “liquidità” una sorta di classicità latente. Voglio dire che se è vero che l’opera di Balcone non mostra evidenti rapporti con il pensiero figurativo o con la Nuova figurazione del primo Novecento, è pur vero che nella sua formale rappresentazione calca tutti i principi della “figura”, ovvero di quella immagine a cui corrisponde la peculiarità rappresentativa di un oggetto o di un particolare della natura. In altri termini, sembra emergere dall’opera un fluidificarsi di emozioni che appartengono alla forma “perfetta”, a quella che un tempo era definita “classica”. E di classicismo vorrei parlare quando mi trovo a contemplare una delle sue opere, che non è tanto Vibrante, del 2007, o Libero pensiero, del 2006, ma soprattutto Danzante, 2010.
Il fatto di individuare in Vibrante (2007), Percorso di una rosa (2006), Danzante, ecc. una sorta di “classicità” mai venuta meno nell’arte di Balcone - ma anche in molti artisti che hanno segnato il Novecento (per es. Viani) -, induce a riflettere sull’inevitabile persistenza di una forma e di un gusto che ha dominato la cultura internazionale e continua a segnare anche quella contemporanea. Parlare di “gusto classico” non vuol dire necessariamente operare secondo i canoni che da Mirone a Canova hanno attraversato la cultura italiana, ma semplicemente che c’è qualcosa nella formazione che continua a dominare i nostri sensi, le nostre scelte. Per Balconi, infatti, se l’opera si origina per l’impulso che la forma nel suo “generarsi” impone all’artista, tanto da dover passare da un titolo ad un altro, è perché l’obiettivo prioritario non è fissare l’idea originaria in una figura predeterminata ma la ricerca di un modello col quale possa omogeneizzarsi. E poiché l’idea si genera a seguito di una serie di movimenti di pensiero, è ovvio che la forma ultima – cioè il “contenitore” entro cui far sostare l’idea - non può che contenere la stessa dinamica che ha portato all’idea. Il movimento, la traslazione del tempo, è tale quale la linea che determina i contorni nelle loro contrapposizioni. Ma può generarsi anche da un’idea specifica, quale quella del flusso dell’acqua, del suo continuo ed imprevedibile trasporto, oppure del movimento che la danza descrive nell’aria e che l’artista immortala nella mente. Ma può essere anche dovuto alla percezione di un suono, alla sua costante vibrazione, tanto da non poterlo adeguatamente fissare se non con un prolungamento virtualmente indefinito del segno che riveste l’idea, e così via; ciò che comunque si rileva è la costante del movimento, la quale non permette di pensare ad alcuna interruzione tra le prime e le ultime opere. N’è conferma, appunto, Danzante, con le sue sinuose forme che sembrano librarsi nello spazio senza limite di chiusura. Ciò che viene offerto all’osservatore è, in fondo, solo la parte di un tutto che continua ad autogenerarsi in funzione all’idea dominante.
Ma Balcone non è il solo a muoversi attorno ad una forma di “sapore” classicheggiante, ovvero dalle forme “perfette”, poiché rovistando tra le opere degli artisti vi è anche Michele Licata, che non si lascia deviare dalla sua formazione culturale e che vede nel passato non un antagonista ma il substrato della propria conoscenza, non un patrimonio di cognizioni da demolire, così come viene sbandierato da una buona parte dei movimenti contemporanei, ma da utilizzare a proprio vantaggio. Il fatto di muoversi su un territorio trasversale, dalla pittura alla scultura, dal restauro (pittorico e plastico) alla realizzazione di grandi vetrate, ecc; il fatto di aver dato vita ad un’Accademia di Belle Arti (Vibo Valentia), di aver diretto alcuni degli Istituti d’Arte (Monreale, San Giovanni in Fiore, Vibo Valentia), sono conferma di un’ampiezza culturale di rara sensibilità. Lo conferma l’impegno profuso nella creazione del manufatto, sia pure di grandi o piccole dimensioni. Licata si abbandona alla formazione dell’opera estraendo dal proprio bagaglio tutta l’esperienza acquisita negli anni. Un'esperienza fatta di erudizione storica ed artistica, è vero, ma soprattutto di umanità e di capacità tecniche invidiabili. Ed è proprio qui che si rivela quello che io definisco “gusto della forma perfetta”, che è proprio della cultura classica. Come, ad esempio, non individuare in Stratificazione del 2008 o in Squarcio e Forma, sempre del 2008, quella connessione visibilmente tangibile di una levigazione dei piani, di una disposizione delle parti del manufatto tipicamente classicheggiante, capace di risvegliare sensazioni sopite, mondi che appartengono al passato ma che sono stati (e sono) una luce sul cammino dell’uomo? L’accanita persistenza di una volontà che a tutti i costi vuole scavalcare l’antico rimuovendolo, perché massicciamente ingombrante, per una libera e neutrale operazione creativa, è causa di devianza più che di sviluppo. Ma ciò che avviene in Licata non è solo il recupero del retaggio culturale (che non è necessariamente di emanazione greca, ma potrebbe essere patrimonio di conoscenze più lontane, quale quella precolombiana o azteca a fare da “modello”, da forma esemplare, perfetta nelle sue valenze strutturali e formali) ma anche conoscenze fornite dalla natura, dalle forme modellate dal vento e dall’acqua, le quali sovente assumono connotazioni diverse. Sono le rocce levigate dalle intemperie, strutturate secondo leggi non stabilite dall’uomo e perciò materia piena di fascino, contenitori di mistero, significanti di un verbo arcano, seppur piacevolmente accolto a livello di subconscio. Quante di queste immagini continuano ad agitare le nostre passioni, il desiderio di sapere, la volontà di portare a livello di comprensione, anche se ritenuta impossibile, il loro senso nascosto? Ecco, ciò che muove le corde dell’anima di Licata è proprio la necessità di portare allo scoperto queste passioni, di offrire loro una forma con le quali possa identificarsi l’osservatore e generare così una forte empatia.
E si potrebbe pensare che le incursioni nel profondo dell’anima risultino d’altra natura quando dalla scultura passiamo alla pittura. Ma non è così, perché è sempre questo strano coinvolgimento che le forze profonde dello spirito fanno nascere quando ci troviamo faccia a faccia con l’arte, ed in particolare con l’opera di Rosario Lo Turco. Artista di ricca sensibilità, deve questa sua caratteristica ad un insieme di fattori originati non solo dall’ambiente siciliano ma anche dalle diverse attività che lo hanno visto scendere in campo: scenografia, pittura, arredamento, oltre, ovviamente, all’apporto delle esperienze registrate attorno ai grandi personaggi del passato come Streller, Ronconi, Pizzi e, non ultimo, Edoardo De Filippo. Ma ciò che in misura maggiore lo caratterizza è la forza spirituale che trasale dai suoi ambienti tunisini. In Tunisia, dove attualmente l’artista vive e lavora, ha colto il profumo, la spiritualità che aleggia nell’aria e si spande profusamente sulla realtà trasformandola in un mondo surreale, in un mondo di sogno. Un sogno concreto, tuttavia, poiché ciò che l’artista rende possibile è solo la conseguenza di una identificazione con lo spirito del luogo, con l’atmosfera che modella la vita e i pensieri che ne derivano. Gli stessi titoli, che Lo Turco dà alle opere, confermano la difficoltà di una diversa legittimazione. Mistero, 1, 2, ecc. opere del 2009, sono rappresentative di una sensibilità senza pari, il coagulo di forme evanescenti, rarefatte, così finemente assottigliate da assumere sembianze spirituali. Non esistono piani ben definiti, non un’immagine che non possa contemporaneamente originarne delle altre. Il colore soffuso, che ingloba ogni sagoma alleggerita dal proprio peso, dal paesaggio urbano ai suoi particolari architettonici, costituisce una modalità costituiva ed essenziale che offre all’artista la possibilità di purificare l’oggetto dal suo peso materico, dalle proprie impurità. Come in un sogno, l’occhio si muove registrando sommariamente i particolari, avvinto solo dal potere unificante del colore, della sua capacità di amalgama e di trasfusione. Ed è proprio questa la caratteristica prioritaria che dà facoltà di cogliere quelle sensazioni mai sopite di un mondo a cui si vorrebbe appartenere, perché qui la vita non ha limiti di espansione, non esistono ostacoli che non siano ridotti a mere apparenze. Un mondo carico di mistero, dal sapore esoterico, ma proprio per questo fortemente motivante e suggestivo.
Riposizionandoci sull’itinerario scultorio di Emanuele Licata, troviamo emergere un’altra eccellente figura che è Luigi Galofaro. Il suo percorso è ricco di esperienze non soltanto per le mostre organizzate nelle diverse città italiane, ma in particolare per quella vena creativa che l’ha portato dal figurativo ad una strutturazione libera, concettualmente astratta, e che in certi casi definirei neoespressionista. Gli anni trascorsi a Perugia, prima sotto il diretto insegnamento di Artemio Giovagnoni, poi di Edgardo Abbozzo - segnati da una ricerca figurativa tipica del momento (mi riferisco agli anni Sessanta: emblematici sono le opere sulla Via Crucis che hanno arricchito molte navate delle chiese del comprensorio perugino) -, sono rappresentativi di un percorso variegato che in parte continua a manifestarsi nelle ultime opere; quanto vi è di diverso tra le ultime e quelle del passato, al di là delle loro peculiarità formali, è difficile dirlo. Se è vero che i temi sembrano essere cambiati (e in campo religioso ogni tema nella realtà si connette a tutti gli altri), alla base resta la medesima origine: il bisogno spirituale insito nell’uomo, che si riflette sulla propria esistenza e ne fa una ragione di ricerca, di riflessione profonda. Scultura n. 1 e 2, del 2008, Metamorfosi del 2008, ecc. sono solo didascalie in aiuto agli storici che si avvalgono di nominalismi per un loro incasellamento. Nella realtà, per l’artista, non avrebbero alcuna necessità, poiché rappresentano un susseguirsi di movimenti interiori dove a determinare lo spostamento è solo l’azione dello spirito: una necessità creativa che affonda le radici nel bisogno di superamento della materia, nella sensibilizzazione delle forze interiori che si stendono nel profondo e che l’artista intende portare allo scoperto come necessità da soddisfare. Solo che, come più volte è stato ribadito, questo bisogno ne genera un altro, e forse anche più profondo, che richiama un nuovo movimento, una nuova rimozione. E’ questa la ragione che permette di individuare nell’opera di Galofaro un continuum, una relazione senza divisione di tempo tra un’opera e l’altra. Rappresentano l’insieme di un processo, di una ricerca che certamente non ha fine. La corrosione della materia è corrosione dell’uomo; è emblema di una società in bilico, in decadimento, in continua frantumazione: ecco la logica del legame tra gli ultimi lavori e i bassorilievi realizzati a Perugia. Nelle ultime opere nulla è venuto meno, se non una trasformazione d’immagine, una perdita d’identità, se si vuole, ma restano sospese allo stesso filo religioso che ha segnato gli anni giovanili.
Certo, nel tempo ogni cosa assume una connotazione differente. In molti casi si può anche determinare un capovolgimento deivalori, ma ciò che permane è quel senso di perdita che nella scultura si sensibilizza in corrosione. E la corrosione non riguarda soltanto la materia ma anche la cultura, spesso piegata a ragioni di profitto. E se nella società tale decadimento è definito come opportunismo, in arte è definito Metamorfosi. Si lascia il vecchio per vestire il nuovo, ma anche si abbandona ciò che era costitutivo per tornare a rivestirsi della vecchia natura. E’ in altri termini, un tornare indietro, o come direbbe Genesi, un tornare alla polvere. Ebbene, quando ci si muove attorno alle opere di Galofaro, non è possibile non rinvenire questo movimento che abbiamo voluto velare artificiosamente pensando di bloccarne il processo; nella realtà Galofaro ci ricorda che la cruda realtà non può essere mascherata perché il germe del tempo non invade invano. La porosità della materia, la sua lacerazione, il colore consunto, ecc. sono forme rappresentative di una realtà che si vorrebbe ottenebrare ma che all’artista appare nella sua essenza.
Si è accennato al colore, un elemento che sembrerebbe costituire una dicotomia all’interno del complesso plastico dove domina per sua natura la materia, il ferro. Eppure per Galofaro la continuità di cui si è parlato sta anche in questa prospettiva, ovvero di intuire nella scultura un suo valore pittorico. Vi è perfetto amalgama tra la scultura e la pittura, tra il piano scultorio e quello pittorico, soprattutto da quando Picasso ha pensato che inserire degli oggetti all’interno di un piano bidimensionale costituisse un modo ineguagliabile per realizzare non una tridimensionalità virtuale ma reale. Ma è anche una costante nel neoespressionismo americano, solo che in Galofaro le motivazioni sono di tutt’altro genere, poiché il suo piano pittorico continua ad offrirsi come il piano di rappresentazione della lacerazione. Un aspetto dominante di cui non si può non prendere coscienza.
Forse occorrerebbe ricominciare da capo, magari con una nuova genesi. E’ il tema che muove l’opera di Giovanni Di Nicola, fine scultore che ha perfezionato i suoi studi a Roma, all’inizio nello studio di Salvatore Meli (scultore e ceramista), successivamente presso i laboratori di esperti artigiani. Ma la genesi di cui parla Di Nicola impone un nuovo inizio che investe l’essere intero, sia nella sua porzione di materia che di spirito. E non è solo necessità di un nuovo processo creativo, ma è soprattutto metodo per la riscoperta della fede. Quanto si è realizzato nella vita dell’uomo è conseguenza di una scelta: scelte arbitrarie, che per libera azione hanno condotto alla perdita del principio di dignità. La storia, infatti, non offre solo esempi – piuttosto sporadici – di fatti positivi, di uomini che hanno scelto di vivere la loro vita secondo valori che si ritenevano assoluti, ma anche di persone che hanno fatto scelte opposte, dove la rispettabilità dell’uomo è stata calpestata ai soli fini speculativi. Ricreare l’uomo è perciò ri-impossessarsi della fede, che è il vero motore della vita. Lo studio che Di Nicola offre a noi tutti, osservatori divoratori di immagini, è proprio uno studio delle religioni. Non si vuole, in questo caso, ridurre tutto a uno, ma di certo nella ricerca di Di Nicola il fondamento dell’umanità rimane lo spirito religioso. In Sì futuro, 2008, ad esempio, non è solo proposto un pensiero che addita il senso della cristianità nella figura del Cristo, ma vi è racchiuso il messaggio, sempre attuale, della creazione come azione congenita dell’uomo. Solo nella creazione, che è conseguenza del processo di vita, inestimabile valore religioso, si può pensare che possa continuare ad esistere ancora un futuro. Per Di Nicola è certo solo nel caso in cui si recuperi il senso del sacro, la dignità dell’uomo. Sì futuro è l’emblema, è certezza di fede, la sola a rendere possibile il sogno di un mondo diverso, capace di identificarci nell’altro perché parte della stessa spiritualità o della stessa “Immagine”. Quando, difatti, l’artista passa a rappresentare Sulle religioni 2, ecco che tutto cambia. Non è il peso dell’imprendibile che si solleva dal piano dell’essere ma la genetica del movimento che caratterizza l’universo dell’uomo. Un movimento che non sempre è ordinato, spesso è invece inclusivo di altre idealità, di altre finalità. Il dinamismo, sovente agitato, non sempre è segno di vita, poiché determina strane conformazioni, sino a rendere il candido e niveo distruggente. L’idea delle religioni, la forma perfetta, la sfera, è un pesante fardello che tenta di schiacciare l’universo “uomo”. E’ un contenitore della cui materia non si ha assoluta certezza. Qui si esalta l’esperienza tecnica e creativa dell’artista, la sua minuziosa capacità di cesellatore ed incastonatore di “perle” dalla vibrante euritmia; ma si esalta anche la visione spirituale dell’uomo, che emerge come un essere in decadimento, in balìa di archetipe forze che non riesce a controllare. Riconquistare la propria libertà, riappropriarsi dei propri valori est-etici è dunque il modo di richiamarsi ad una nuova genesi, ad un recupero del senso ultimo dell’essere.
Termino il percorso, ricco di inferenze, proprio per la peculiarità degli artisti del Collettivo, con Gesualdo Spampinato, pittore che ha attraversato le diatribe dell’arte contemporanea con una forte carica creativa da renderlo in un certo senso unico ed inimitabile. Il fatto di aver studiato all’Accademia di Brera, a Milano, e perciò in un ambiente particolarmente motivato, culturalmente all’avanguardia, considerati gli stretti rapporti con il nord Europa, il fatto di utilizzare il suo impegno sociale in direzione di uno sviluppo culturale dell’uomo, lo hanno portato a cogliere nelle tematiche del repertorio artistico novecentesco la logica del proprio impegno e della propria ricerca. E’ chiaro che difficilmente si riesce a descrivere il presente impegno senza pensare al quadro storico che lo ha segnato sino all’attuale produzione. Nato in un certo senso con una predisposizione al figurativo, si è imposto nel panorama dell’arte nazionale ed internazionale con una serie di opere che hanno come comune dominatore la città di cui si vanta, Comiso, e dalla cui popolazione è stato accolto con grande interesse. Il suo “figurativo surreale”, la sua vena poetica nel descrivere con larghezza d’animo il paesaggio, la sua sapienza nella ricerca dei toni cromatici, lo fa uno dei personaggi graditi anche da quanti hanno scarsa familiarità con l’arte. Ma Spampanato non si è lasciato frenare da tali risultati; al contrario, si è lasciato trasportare dagli eventi che hanno caratterizzato il secolo ed ha attraversato con pari vigore tutti i sistemi di rappresentazione che hanno segnato i diversi momenti, perché dotati di valori e principi assoluti come quelli che hanno distinto il corso della storia dell’arte. Non è difficile, perciò, rinvenire nelle opere aspetti che appartengono ai movimenti ed alle ricerche più impegnative e burrascose, dal neofigurativismo all’arte povera: un bisogno inevitabile, soprattutto quando si opera nel sociale, ma anche quando ci si identifica con i temi culturali che hanno fatto del recupero un’espressione dell’arte.
Si potrebbe pensare che questo nuovo percorso sia un modo per allontanarsi da certe visioni figurative, da un certo culto dell’immagine, nella realtà non mi pare che l’artista si sia distaccato così tanto, perché ciò che emerge è proprio la “continuazione” del figurativo, questa volta un figurativo che si potrebbe definire “realista”: raccogliere, all’interno dello spazio del supporto, della carta, del cartone e altro, vale a dire del materiale eterogeneo e collocarlo secondo un sistema dove ad emergere è il rapporto di contrasto; inserire tale supporto sopra un altro in modo da realizzare un quadro sul quadro, per Spampinato è un metodo come un altro di porre ordine in un sistema di disordine diventato, con l'insulso spargimento dei rifiuti, luogo comune. Raccoglierli è, perciò, come separarli e ridarle una nuova dignità, non quella congenita al rifiuto ma al suo valore di materia, forma e colore: tanti fotogrammi, dunque, che sopportano la riacquisizione della rispettabilità dell’oggetto abbandonato. Questa forma di Arte Povera, in virtù del potere catartico dell’artista, assurge a nuova significazione ed offre all’osservatore un’opportunità di operatività intellettuale diversamente improponibile. Spampinato, in quanto esigente e sensibile comunicatore e educatore, non fa che adoperarsi perché le proprie capacità creative siano indirizzate a realizzare delle opere in grado di determinare una forte emozione, un impatto da indurre l’osservatore ad un’accurata riflessione sulla natura e sul valore d’uso dell’oggetto: se l’arte ha il compito di rappresentare il proprio tempo e di essere portatrice di cultura, questo è quanto Spampinato si prodiga a muovere sul piano dell’essere. Non, perciò, un’arte mercantile della quale si possano tesaurizzare gli investimenti e neppure un’arte i cui valori morali ed etici possano subire la metamorfosi del nulla. Tesaurismosi – Napoli 2008, Tesaurismosi – Travaso 2009 (termine medico con il quale si sintetizzano le malattie da “accumulo” nell’uomo o quelle nelle piante causate dallo smaltimento dei rifiuti), sono il documento di accusa di un atteggiamento generalizzato diventato simbolo “culturale” nazionale. (da http://www.arte-collettivocomisanobai.it). (17/11/2017-ITL/ITNET)