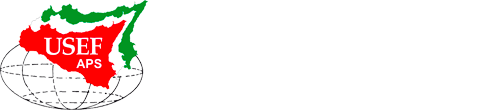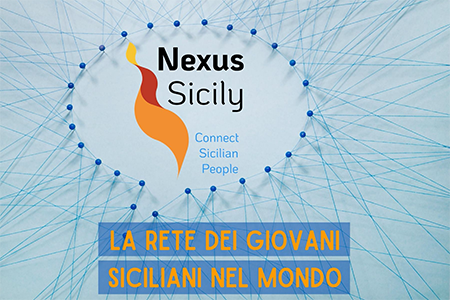Category: Scritture Creato: 05 Aprile 2025 Scritto da Redazione Culturelite Hits: 172
Category: Scritture Creato: 05 Aprile 2025 Scritto da Redazione Culturelite Hits: 172
«L’Isola era stata sempre sequestrata, a causa del mare e della scarsezza dei commerci, da ogni relazione col resto del mondo. Quando nel 1781 ci venne come Vicerè il napoletano Domenico Caracciolo, credeva di giungere, dice uno storico siciliano, fra gl’Irochesi e gli Ottentotti.»
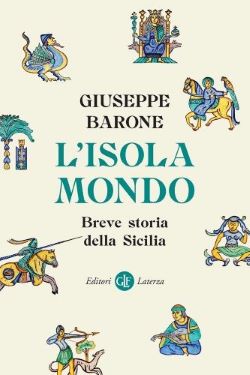 In queste poche righe si sintetizza l’idea della cultura siciliana che Giovanni Gentile, il più importante filosofo italiano del Novecento, diffondeva attraverso “Il tramonto della cultura siciliana” una delle opere più citate della saggistica del secolo scorso. Un’idea che, con il massimo rispetto di un pensatore raffinato e intelligente, come lo è stato il filosofo di Castelvetrano padre del neoidealismo italiano, soffre in questo caso di una evidente superficialità di lettura della complessa storia siciliana. Basta infatti soffermarsi sui vari passaggi di questa stessa storia per rendersi conto che, nonostante limiti fisici e politici, l’isola non solo si è sensibilizzata con la più interessante cultura europea ma si è anche distinta per uno scambio fecondo che l’ha fatta partecipe e protagonista della stessa. Non è questa la sede per ricordare tutti i protagonisti di questo scambio ma per partire da questo assunto per smentire - servendoci, in questo caso, delle pagine de “L’Isola Mondo” il prezioso saggio di Giuseppe Barone recentemente pubblicato dall’editore Laterza – la lamentata assenza di quella esperienza umanistica e rinascimentale che ha costituito una vera rivoluzione culturale rispetto al Medioevo. Proprio a partire dagli inizi del XV si manifestò, infatti, in Sicilia un fenomeno ai più poco noto, e cioè il fatto che giovani particolarmente dotati si rechino a studiare fuori dall’isola spesso agevolati da quelle che, oggi, si chiamano borse di studio elargite da istituzioni pubbliche e private, enti ecclesiastici e mecenati. Un fenomeno dovuto all’assenza di atenei, l’università di Catania è stata infatti fondata nel 1434 e quella di Messina del 1548, mentre per quella di Palermo si sarebbe dovuto attendere addirittura il XIX secolo. Fra i primi ad usufruire di questo beneficio, siamo a metà del marzo 1405 fu un giovane siracusano, Guglielmo Perno o di Perno, che ricevette un sussidio di 6 onze (riconfermato per gli anni successivi) per andare ad apprendere diritto civile presso l'università di Bologna, dove fu allievo del famoso Bartolomeo da Saliceto, un grande giurista che, entrato in conflitto con il vicario papale, era stato, per questo motivo, sollevato dall’insegnamento. Le traversie del maestro costrinsero il giovane Guglielmo a trasferirsi a Padova dove conseguì la laurea cum lode che gli consentì di avviarsi alla carriera giudiziaria e di occupare, dal 1442 al 1444, l’ambita poltrona della Magna Curia di Palermo. Nella sua attività, peraltro spesso segnata da conflitti con i potenti del tempo a causa del suo rigore professionale, Guglielmo ebbe modo di dare esempio di quella raffinatissima preparazione giuridica maturata negli atenei di Bologna e Padova, divenendo un vero e proprio maestro per generazioni di giuristi. Ad usufruire di una di queste borse di studio, elargita dal senato catanese, fu anche Giovanni Battista Platamone, rampollo di una delle famiglie aristocratiche più importanti di Sicilia, che studiò a Bologna dove, nel 1420 conseguì la laurea dottorale utriusque iuris. Il Platamone, tornato in Sicilia, fu giudice fiscale ma anche Presidente del Regno del regno di Sicilia. La città di Caltagirone fu la generosa sostenitrice di Adamo Asmundo, che fu mandato a Padova a studiare civile con Francesco Zabarella, un fine giurista che avrebbe avuto una parte non secondaria nella ricucitura dei contrasti che avevano portato allo Scisma d’Occidente che per quasi quarant’anni lacerò l’unità della Chiesa. Asmundo, rientrato in Sicilia, vi acquistò assai presto fama di valente giurista e per questo motivo fu chiamato a ricoprire cariche importanti nell’amministrazione siciliana fra le quali quella apicale di Presidente del Regno di Sicilia. La storia di Asmundo sarebbe stata segnata da una particolare attenzione ai ceti inferiori, impegno che gli attirò molte inimicizie fra i potenti del tempo che lo costrinsero a ritirarsi dalla vita pubblica. Presso le università di Padova e Bologna si addottorò in diritto Gherardo Alliata, esponente della potente famiglia di finanzieri pisani che sarebbe assurta alla dignità principesca, al quale il Senato palermitano concesse una borsa di studio per consentirgli di seguire i corsi. L’Alliata, tornato a Palermo, assunse fra l’altro la carica di protonotaro del Regno, un'importante carica amministrativa che abilitava alla cura della compilazione e dell’invio dei diplomi regi. Ma non furono solo gli atenei di Padova e Bologna ad essere interessati dalla presenza di giovani siciliani, alla lista si può aggiungere Siena ch’ebbe studente di medicina Giovanni Mastrarrigo di Caltagirone, che sarebbe divenuto medico personale di Alfonso il Magnanimo, e Salerno che ebbe allievo di medicina il catanese Gustavo Branca, anche lui gratificato da quelle che abbiamo definito borse di studio, che praticò per primo la rinoplastica e che, tornato a Catania, fondò uno studio tramandato ai figli. A questi, fra i più famosi, se ne potrebbero aggiungere tanti altri che evidenziano un contesto estremamente vivace, segnato da grande mobilità e da scambi virtuosi che appunto smentisce platealmente la tesi gentiliana di una Sicilia isola e, in quanto tale, chiusa ad ogni influenza esterna.
In queste poche righe si sintetizza l’idea della cultura siciliana che Giovanni Gentile, il più importante filosofo italiano del Novecento, diffondeva attraverso “Il tramonto della cultura siciliana” una delle opere più citate della saggistica del secolo scorso. Un’idea che, con il massimo rispetto di un pensatore raffinato e intelligente, come lo è stato il filosofo di Castelvetrano padre del neoidealismo italiano, soffre in questo caso di una evidente superficialità di lettura della complessa storia siciliana. Basta infatti soffermarsi sui vari passaggi di questa stessa storia per rendersi conto che, nonostante limiti fisici e politici, l’isola non solo si è sensibilizzata con la più interessante cultura europea ma si è anche distinta per uno scambio fecondo che l’ha fatta partecipe e protagonista della stessa. Non è questa la sede per ricordare tutti i protagonisti di questo scambio ma per partire da questo assunto per smentire - servendoci, in questo caso, delle pagine de “L’Isola Mondo” il prezioso saggio di Giuseppe Barone recentemente pubblicato dall’editore Laterza – la lamentata assenza di quella esperienza umanistica e rinascimentale che ha costituito una vera rivoluzione culturale rispetto al Medioevo. Proprio a partire dagli inizi del XV si manifestò, infatti, in Sicilia un fenomeno ai più poco noto, e cioè il fatto che giovani particolarmente dotati si rechino a studiare fuori dall’isola spesso agevolati da quelle che, oggi, si chiamano borse di studio elargite da istituzioni pubbliche e private, enti ecclesiastici e mecenati. Un fenomeno dovuto all’assenza di atenei, l’università di Catania è stata infatti fondata nel 1434 e quella di Messina del 1548, mentre per quella di Palermo si sarebbe dovuto attendere addirittura il XIX secolo. Fra i primi ad usufruire di questo beneficio, siamo a metà del marzo 1405 fu un giovane siracusano, Guglielmo Perno o di Perno, che ricevette un sussidio di 6 onze (riconfermato per gli anni successivi) per andare ad apprendere diritto civile presso l'università di Bologna, dove fu allievo del famoso Bartolomeo da Saliceto, un grande giurista che, entrato in conflitto con il vicario papale, era stato, per questo motivo, sollevato dall’insegnamento. Le traversie del maestro costrinsero il giovane Guglielmo a trasferirsi a Padova dove conseguì la laurea cum lode che gli consentì di avviarsi alla carriera giudiziaria e di occupare, dal 1442 al 1444, l’ambita poltrona della Magna Curia di Palermo. Nella sua attività, peraltro spesso segnata da conflitti con i potenti del tempo a causa del suo rigore professionale, Guglielmo ebbe modo di dare esempio di quella raffinatissima preparazione giuridica maturata negli atenei di Bologna e Padova, divenendo un vero e proprio maestro per generazioni di giuristi. Ad usufruire di una di queste borse di studio, elargita dal senato catanese, fu anche Giovanni Battista Platamone, rampollo di una delle famiglie aristocratiche più importanti di Sicilia, che studiò a Bologna dove, nel 1420 conseguì la laurea dottorale utriusque iuris. Il Platamone, tornato in Sicilia, fu giudice fiscale ma anche Presidente del Regno del regno di Sicilia. La città di Caltagirone fu la generosa sostenitrice di Adamo Asmundo, che fu mandato a Padova a studiare civile con Francesco Zabarella, un fine giurista che avrebbe avuto una parte non secondaria nella ricucitura dei contrasti che avevano portato allo Scisma d’Occidente che per quasi quarant’anni lacerò l’unità della Chiesa. Asmundo, rientrato in Sicilia, vi acquistò assai presto fama di valente giurista e per questo motivo fu chiamato a ricoprire cariche importanti nell’amministrazione siciliana fra le quali quella apicale di Presidente del Regno di Sicilia. La storia di Asmundo sarebbe stata segnata da una particolare attenzione ai ceti inferiori, impegno che gli attirò molte inimicizie fra i potenti del tempo che lo costrinsero a ritirarsi dalla vita pubblica. Presso le università di Padova e Bologna si addottorò in diritto Gherardo Alliata, esponente della potente famiglia di finanzieri pisani che sarebbe assurta alla dignità principesca, al quale il Senato palermitano concesse una borsa di studio per consentirgli di seguire i corsi. L’Alliata, tornato a Palermo, assunse fra l’altro la carica di protonotaro del Regno, un'importante carica amministrativa che abilitava alla cura della compilazione e dell’invio dei diplomi regi. Ma non furono solo gli atenei di Padova e Bologna ad essere interessati dalla presenza di giovani siciliani, alla lista si può aggiungere Siena ch’ebbe studente di medicina Giovanni Mastrarrigo di Caltagirone, che sarebbe divenuto medico personale di Alfonso il Magnanimo, e Salerno che ebbe allievo di medicina il catanese Gustavo Branca, anche lui gratificato da quelle che abbiamo definito borse di studio, che praticò per primo la rinoplastica e che, tornato a Catania, fondò uno studio tramandato ai figli. A questi, fra i più famosi, se ne potrebbero aggiungere tanti altri che evidenziano un contesto estremamente vivace, segnato da grande mobilità e da scambi virtuosi che appunto smentisce platealmente la tesi gentiliana di una Sicilia isola e, in quanto tale, chiusa ad ogni influenza esterna.
Pasquale Hamel