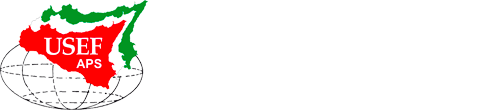(Agostino Spataro) Nel 30° anniversario dell’assassinio di Aldo Moro, Agostino Saviano pubblica, nel suo “Viaggio nella memoriaâ€, una lettera inedita del futuro statista che lascia presagire il suo tragico destino.
(Agostino Spataro) Nel 30° anniversario dell’assassinio di Aldo Moro, Agostino Saviano pubblica, nel suo “Viaggio nella memoriaâ€, una lettera inedita del futuro statista che lascia presagire il suo tragico destino.  Nel libro anche un commento di Agostino Spataro che rievoca quei giorni terribili dall’interno della Camera dei Deputati Nelle avvincenti pagine autobiografiche del suo “Viaggio nella memoria†Agostino Saviano rievoca taluni episodi accadutigli in un particolare momento della sua lunga vita, nel vivo del secondo conflitto mondiale. Un viaggio a ritroso dentro una guerra tremenda ai cui esiti erano affidate da un lato le sorti della dittatura nazi-fascista e dal lato avverso le speranze di dignità dei popoli. Una scommessa risolutiva in cui la posta erano la libertà e il suo contrario. Una vicenda umana, la sua, comune a tantissimi altri commilitoni, a milioni d’europei che vissero la guerra chi al fronte e chi in città e paesi bombardati e annichiliti dalla fame e dalle violenze di ogni tipo. Insomma, un bel tratto di strada nel solco di una grande tragedia che portò Saviano dalla sua Arzano alle aspre montagne d’Albania, dalla Puglia alle sterminate steppe della Russia fra le vittime e i sopravvissuti della disastrosa spedizione militare italiana. Lungo questo tormentato percorso incontrerà tanta gente. Alcuni cadranno sul campo, molti si sperderanno per il mondo, taluni affioreranno dal fantastico gioco dei ricordi. E fra quest’ultimi, il primo della lista è certamente il giovane sergente-allievo Aldo Moro che l’Autore incontrò, casualmente, in terra di Bari. Con Moro, che era già presidente nazionale della Fuci, Saviano spesso parlò delle libertà negate e delle smisurate ambizioni imperialiste del fascismo. Posizioni coraggiose, purtroppo isolate, che attireranno contro Saviano la dura reazione del sistema. Fra i due si stabilì una comunione di sentimenti antifascisti a quel tempo molto rari e rischiosi, soprattutto all’interno delle forze armate. Sentimenti ed umori che, sfidando le occhiute maglie della censura, sono giunti a noi in forma d'epistola che Saviano ha gelosamente conservato e che oggi ci rende come il dono più pregiato di questo suo libro di memorie. Al solo sentir il fratello Franco parlare di una lettera inedita di Aldo Moro ebbi come un sussulto, pensando a ben altre lettere che lo statista scrisse durante quei terribili 55 giorni di prigionia, prima di essere assassinato dalle Brigate rosse. Si tratta, invece, di corrispondenza fra commilitoni che la guerra aveva allontanato. Una lettera del settembre 1942, sincera ed amichevole, dalla quale traspare il disagio, l’avversione contro una guerra assurda e contro la dittatura che l’aveva provocata. “Alla tua anima, sconvolta, smarrita e desolata per aver troppo capito - scrive Moro a Saviano- ho osato avvicinare la mia che conosceva uno stesso dolore…†Un passaggio molto significativo nel quale, oltre al richiamo ad un comune sentire, si può apprezzare il senso di una rara sensibilità politica e morale che quando non è temperata dall’autocensura può sfociare nel dramma. Giacché il “troppo capire†può diventare un azzardo, quando capir non si deve, né troppo né poco, ma solo obbedire ed eseguire! Ieri come oggi. Specie se il troppo capire ti spinge ad osare oltre certi limiti. Forse un giorno sapremo, o sapranno, la verità La verità sul caso Moro è ancora lontana. Un caso o un affaire come lo definì Leonardo Sciascia col quale più volte ebbi a parlare quando veniva a Montecitorio. Lo scrittore aveva ragione: quel tragico evento non poteva essere ridotto ad un “casoâ€, perché caso non era, ma un delitto politico complesso, ideato e programmato in tutti i suoi aspetti militari e politici. Forse, un giorno, sapremo (o sapranno) tutta la verità sull’affaire Moro. Tuttavia, credo si possa senz'altro affermare che Egli è caduto per avere troppo capito e troppo osato. E qui mi fermo, perché desidero aggiungere al ricordo di Agostino Saviano alcune mie impressioni sull’atmosfera che si respirava in Parlamento durante quei 55 giorni e sulla figura e sul ruolo dell’on. Aldo Moro col quale- chiarisco- non ho avuto alcuna relazione diretta, ma solo qualche scambio di saluti. Confesso che io, approdato giovanissimo in Parlamento nel 1976 sull’onda della clamorosa avanzata elettorale del Pci, percepivo il gruppo dirigente della Dc come un blocco dominante composito, talvolta anche rissoso, che, al bisogno, sapeva far quadrato a difesa di un potere gretto, fine a se stesso che si voleva conservare al governo, in eterno. Un punto di vista piuttosto diffuso, giacché un po’ questo era il volto del potere democristiano, soprattutto in Sicilia e nel meridione. Erano quelli i tempi del “governo dell’astensione†(del Pci). Una formula per molti di noi deludente, indigeribile anche perché basata, sostanzialmente, solo su un’intesa riservata, quasi sulla parola, fra Berlinguer e Moro. Quell’accordo, tuttavia, produsse un clima di rasserenamento, di relativa fiducia tra i partiti, soprattutto fra Dc e Pci che insieme disponevano di quasi l’80% della rappresentanza parlamentare. Insieme i due partiti rappresentavano l’anima popolare della società italiana, una vera superpotenza politica capace di riformare finalmente il Paese. E le riforme- si sa- suscitano grandi speranze ma anche grandi paure in chi se ne sente minacciato. Preoccupazioni che si propagarono anche nel cuore dei principali centri decisionali internazionali. Saranno state la sorpresa e/o la paura del cambiamento o altro, fatto sta che taluni settori della classe dirigente italiana si mostrarono poco convinti, quando non ostili, nell’affrontare un passaggio così innovativo. Cercai di capire questo travaglio. Ogni occasione era buona per scandagliare atteggiamenti e comportamenti della classe dirigente. Una mattina, partecipando ad una seduta della commissione esteri della Camera, mi trovai davanti tutti i segretari e i presidenti dei partiti, di governo e d’opposizione: Berlinguer, Craxi, Zaccagnini, Rumor, Piccoli, De Martino, Spinelli, Ugo La Malfa, Pajetta, La Pira, Malagodi, Tanassi, Giolitti, Colombo, Forlani, Aldo Moro… Li scrutai da vicino, ad uno ad uno. Osservai i loro sguardi, i loro tic, i movimenti minimi del viso, delle mani. Volevo capire cosa si nascondesse dietro quei volti formali, impenetrabili. Arroganza, paura, inquietudine, solitudine? Insomma, la prospettiva che s’andava ad aprire come e quanto influenzava i loro comportamenti, le loro stesse personalità ? L’esame fu necessariamente sommario. A parte La Pira, che già poteva considerarsi avviato verso la beatitudine celeste, mi colpirono soprattutto Berlinguer e Moro per la loro espressione sofferta, quasi mesta. Era un po’ il loro carattere, ma – credo- vi influisse la consapevolezza del peso delle responsabilità che s’erano assunte in quel frangente. In quel consesso di capi-partito e di corrente vidi le stimmate di un potere fatto di voti e presidenze. Moro e Berlinguer, invece, m’apparvero spogli di poteri siffatti e perciò leader autentici che fondavano il loro carisma sulla forza delle idee e dell’etica. Un solo esempio. Aldo Moro capeggiava una fra le più piccole correnti democristiane, eppure era stato l’architetto delle grandi svolte politiche della “balena bianca†ed ora stava realizzando la sua ultima, più impegnativa fatica per il completamento del disegno democratico tracciato dalla Costituzione. Glielo hanno impedito ricorrendo alla strage, ad un delitto atroce. Quella mattina alla Camera La notizia della strage e del sequestro giunse veloce e terribile a Montecitorio di prima mattina. Ricordo lo smarrimento di capi e gregari democristiani, il nostro sgomento. Nel “transatlantico†le urla di pochi soverchiavano i silenzi atterriti di tanti. Antonello Trombadori, deputato ed ex gappista romano, correva come un pazzo avanti e indietro gridando “al muro, al muroâ€. Perfino un uomo misurato come Ugo La Malfa giunse ad invocare in Aula la pena di morte. Il giorno non fu scelto a caso: quel 16 marzo 1978 la Camera era stata convocata per votare la fiducia al quarto governo Andreotti. Per la prima volta, dopo trent’anni, il Pci entrava nella maggioranza anche se non rappresentato nel governo. Un altro voto difficile, per noi, ma necessario per realizzare il secondo passaggio dell’intesa strategica fra Moro e Berlinguer. I nemici occulti di tale strategia decisero di fermarla al secondo passaggio, giacché al terzo, che avrebbe visto i comunisti al governo, sarebbe stato altamente rischioso. Un disegno funesto, devastante, ideato da forze potenti, tutt’ora ignote, ben più potenti delle Br che l’hanno eseguito. Almeno così in molti leggemmo la vicenda sulla quale pesano ancora tante stranezze operative e alcuni interrogativi riguardanti la sua gestione politica, per altro molto riservata ed accentrata. Aldo Moro fu colpito in quanto unico leader in grado di traghettare la Dc verso questa svolta decisiva. Salvando lui si sarebbe dovuto salvare anche il progetto politico di cui era co-protagonista, ufficialmente condiviso da circa il 90% delle forze parlamentari. Perché, dunque, non si tentarono tutte le possibili vie di salvezza? La cosiddetta “fermezzaâ€, anche se invocata in buona fede, non era in fondo una condanna a morte del sequestrato? Interrogativi angoscianti che in quei giorni convulsi non trovarono risposte esaurienti. Perciò, mi parve quantomeno illogico respingere la “trattativa†che avrebbe consentito, se non altro, di scoprire le carte dei sequestratori. Se fosse stato un bluff, come molti temevano, le Br avrebbero confermato il diffuso sospetto di essere al servizio di un disegno più grande di loro, mirato soltanto all’eliminazione fisica dell’on. Aldo Moro. Purtroppo, le cose andarono per un altro verso. Moro verrà barbaramente assassinato. Il danno fu grande per la sua famiglia e per la democrazia italiana che, d’allora, appare sempre più contratta, fiacca, vacillante. Concludo con un passaggio illuminante, pedagogico direi, contenuto nella lettera a Saviano, in cui Moro conferisce un senso altissimo al sacrificio umano “mi pare che nella vita per fare qualcosa di grande e di buono, e perciò di duraturo, occorra saper pagare di persona, facendosi attori e veri partecipi poi del grande dramma.†Parole dolenti nelle quali si possono intravedere i segni premonitori del suo tragico destino. Agostino Spataro