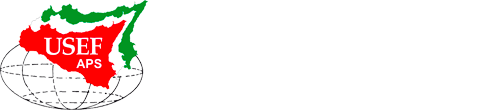L'emigrazione italiana verso la Repubblica federale tedesca. L'accordo bilaterale del 1955, la ricezione sulla stampa, il ruolo dei Centri di emigrazione di Milano e Verona Il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica federale tedesca firmarono, il 20 dicembre 1955,
L'emigrazione italiana verso la Repubblica federale tedesca. L'accordo bilaterale del 1955, la ricezione sulla stampa, il ruolo dei Centri di emigrazione di Milano e Verona Il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica federale tedesca firmarono, il 20 dicembre 1955, l’accordo per il reclutamento e il collocamento di

manodopera italiana nella Germania federale. Le trattative che condussero alla firma di tale accordo furono il frutto sia di esigenze nazionali, sia di istanze internazionali. Il flusso emigratorio che ne scaturì fu influenzato, a sua volta, dalla progressiva entrata in vigore della libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità economica europea, e dall’andamento economico registrato nelle nazioni coinvolte. La prima fase dell’emigrazione diretta verso la Germania federale fu definita “assistita” poiché pianificata a livello istituzionale e organizzata attraverso i Centri di emigrazione. La seconda fase dell’emigrazione fu caratterizzata della libera circolazione dei lavoratori e da forme di reclutamento indipendenti dalla mediazione dei Centri di emigrazione. I lavoratori italiani trovarono lavoro recandosi direttamente all’estero. Quest’articolo si concentra sullo studio dell’emigrazione “assistita” e, partendo dall’analisi del contesto politico-economico in cui l’accordo bilaterale fu sottoscritto, ne analizza la ricezione sulla stampa tedesca e italiana, soffermandosi, infine, sull’analisi dei flussi migratori gestiti dai Centri di emigrazione di Milano e Verona. In particolare, la storia del Centro di emigrazione di Verona e il ruolo giocato da questo nella definizione effettiva dei flussi migratori (provenienza regionale, quantità numerica, qualifiche professionali, e destinazione) rappresentano degli aspetti ancora poco approfonditi dell’emigrazione italiana verso la Germania federale. 1. Le premesse della firma dell’Accordo bilaterale italo-tedesco per il reclutamento e il collocamento della manodopera italiana nella Repubblica federale tedesca Le trattative che condussero alla firma dell’accordo bilaterale italo-tedesco si possono far risalire all’ottobre del 1953, quando il governo italiano chiese al governo tedesco di occupare lavoratori stagionali italiani a causa della diminuzione costante delle importazioni italiane da parte tedesca . La discussione sul saldo negativo dei pagamenti e sul reclutamento della manodopera caratterizzò i rapporti economici italo-tedeschi per tutto il 1954. L’apice si raggiunse a luglio, quando l’Italia, davanti alla reticenza tedesca, minacciò di «tornare ad una politica commerciale restrittiva se gli altri stati non fossero stati disposti ad un’attuazione liberale dell’assunzione di manodopera». Alla richiesta italiana, però, Bernhard Ehmke (dirigente del ministero federale del lavoro) rispose chiaramente che il bisogno di manodopera nella Repubblica federale tedesca poteva «ancora essere soddisfatto con quella locale» e rifiutava i «legami contrattuali» con l’Italia perché li riteneva prematuri. Le forti interdipendenze esistenti tra l’Italia e la Germania federale erano il frutto della ricostruzione economica post-bellica che ponendo le esportazioni al centro della rinascita economica europea, si basava sulla liberalizzazione del commercio estero. Il progetto di un’Europa economicamente integrata, progetto che, come afferma lo storico Charles Maier, era rimasto parzialmente irrealizzato, era stato il progetto degli Stati Uniti di Truman che, con il piano Marshall, aveva proposto alle nazioni europee un piano di crescita economica comune. Gli Stati Uniti pensavano all’Europa come a una “regione”, dove ogni nazione avrebbe dovuto ricoprire ruoli funzionalmente interdipendenti dettati dalla propria storia e dalle proprie risorse. Il compito degli Stati Uniti sarebbe stato quello di attivare un meccanismo «self help adatto a rimettere in moto la spina al recupero di produttività». La crescita economica avrebbe garantito la stabilità politica e la pace sociale dell’Europa e sarebbe stata l’unico antidoto sia contro i partiti comunisti, forti soprattutto in Francia e in Italia, sia contro il pericolo sovietico. Carlo Spagnolo sottolinea il valore principalmente politico assunto dagli aiuti economici americani affermando che «gli aiuti americani furono politicamente decisivi alla ricostruzione europea». Gli Stati Uniti individuavano, nel recupero politico ed economico della Germania occidentale, la condizione necessaria e indispensabile per la rinascita economica europea, e contemporaneamente ne facevano il baluardo della loro politica di contenimento. Se da un lato, infatti, alla Germania federale con il suo carbone e con le sue capacità tecniche veniva riconosciuto il ruolo trainante per la ripresa economica del continente, dall’altro lo scivolamento della Germania occidentale nell’area comunista avrebbe potuto significare la perdita dell’Europa. Nel 1948 gli Stati Uniti crearono l’Organizzazione europea di cooperazione economica (Oece) per ripartire gli aiuti del piano Marshall tra gli stati firmatari. L’Oece ebbe un carattere prevalentemente tecnico e di coordinamento e non soprannazionale, come invece avrebbero voluto gli americani. Nazioni come la Francia e la Gran Bretagna, infatti, vi si erano opposte per il timore di perdere la propria sovranità. Il principio della ricostruzione della Germania federale venne comunque riconosciuto da tutti gli stati firmatari a condizione che esso fosse controllato per evitare conseguenze dannose all’economia e alla finanza degli altri paesi. Da parte sua la Germania occidentale, con sovranità limitata fino al 1955 e soggetta a uno stazionamento di forze d’occupazione, si impegnava in una ricostruzione ed espansione industriale dichiarando esplicitamente il proprio «fervido desiderio di servire la causa europea». Nel settembre del 1949 era nata la Repubblica federale tedesca e Konrad Adenauer, il suo primo Bundeskanzler, seppe leggere le opportunità politiche insite nell’idea di Europa e far riguadagnare alla Repubblica federale tedesca la pari dignità con gli altri paesi rendendola così idonea alla «collaborazione all’interno degli organismi europei». L’Italia nel 1949 aderì all’Oece e intraprese la strada della liberalizzazione progressiva della sua economia. Per l’Italia, infatti, povera di materie prime, lo sviluppo industriale significava, prima di tutto lo sviluppo delle importazioni. Uno sviluppo delle importazioni avrebbe comportato una pari crescita delle esportazioni e avrebbe necessitato di un clima di aperture commerciali. L’Italia nel 1954 aprì, quindi, il proprio mercato alle importazioni dai paesi Oece abolendone fino al 99% le limitazioni quantitative. Per giocare un ruolo nell’intreccio di collaborazioni internazionali, l’Italia aveva puntato sulla stabilità monetaria pagando, però, il costo di «povertà e vulnerabilità interna». Lo sviluppo di un’industria competitiva sul piano internazionale, localizzato principalmente nel triangolo industriale di Milano, Torino e Genova e orientato verso l’aumento della produttività e dell’esportazione lasciava, infatti, irrisolto il problema del riassorbimento della disoccupazione. La domanda proveniente dai paesi europei più industrializzati, infatti, si orientava verso i consumi di massa e di lusso e quindi solo verso specifici settori della produzione italiana come l’industria automobilistica, i prodotti petroliferi, alcuni prodotti tessili, le calzature e la gomma. Secondo Graziani, furono proprio le esportazioni a mettere in moto un «circolo vizioso di squilibri e di disuguaglianze», prime fra tutte le emigrazioni esterne e interne e il sottosviluppo del mezzogiorno. L’Italia di Alcide De Gasperi affrontò il problema della disoccupazione aprendo strade istituzionali all’emigrazione stessa a cui neanche il Sindacato unitario dei lavoratori, «trincerandosi dietro la dura necessità del momento», si era realmente opposto. De Gasperi intendeva trovare sbocchi occupazionali per la manodopera italiana nelle nazioni aderenti all’Oece «in un’ottica di scambi di concessioni commerciali reciproche». Se da un lato gli emigranti avrebbero contribuito a sanare il bilancio statale, dall’altro l’emigrazione indeboliva i contrasti sociali interni permettendo il consolidamento politico della Democrazia cristiana. Che l’emigrazione fosse una voce fondamentale nel capitolo della bilancia dei pagamenti con l’estero, lo dimostra il primo piano per lo sviluppo dell’economia presentato dall’Italia all’Oece per il quadriennio 1948-49/1952-53 dove venne prevista un’emigrazione netta di 823.000 unità, di cui 364.000 dirette verso l’Europa e 468.000 dirette verso gli altri continenti; tutto ciò avrebbe prodotto, in rimesse, una quota di 205 milioni di dollari, pari al 10% delle importazioni. Al temine dello stesso periodo, però, ci si aspettava di registrare ancora 1.188.000 disoccupati, ai quali si sarebbero dovuti aggiungere, secondo la Direzione per l’emigrazione del ministero degli esteri, altri due milioni di sottoccupati. La Germania di Adenauer, invece, per garantire la stabilità sociale e politica interna si era prefissata l’obiettivo della piena occupazione. D’altronde, come osserva Christoph Buchheim, fu proprio «l’impiego della forza lavoro […] di milioni di disoccupati e sottoccupati, tra cui molti profughi e rifugiati», a essere il motore della crescita economica. Non c’era da stupirsi se, ancora all’inizio del 1954, il Ministro del lavoro e i sindacati tedeschi si opponessero alle trattative con l’Italia per il collocamento di lavoratori italiani nella Repubblica Federale Tedesca, richiamando l’attenzione sugli alti tassi di disoccupazione esistenti nel settore agricolo. D’altra parte, però, l’Italia era un’importantissima importatrice di carbone e i maggiori introiti delle esportazioni tedesche erano fatturati nel commercio di prodotti dell’industria meccanica, metallurgica e chimica, proprio con l’Italia. Così, all’inizio del 1955, la Germania federale propose all’Italia un accordo “preventivo” sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani, un accordo che sarebbe entrato in vigore solo nel caso in cui la Germania federale ne avesse avuto bisogno, e cioè solo quando la disoccupazione tedesca fosse stata completamente riassorbita. All’inizio dello stesso anno, l’Italia aveva presentato all’Oece il piano Vanoni in cui per il decennio successivo si prevedeva un’emigrazione di 800.000 lavoratori, ritenuta indispensabile per garantire la crescita economica e riequilibrare il grave divario esistente tra nord e sud.. Nel settembre 1955 la disoccupazione tedesca toccò il 2,7% e a novembre il ministero del lavoro tedesco stimò a 800.000 il «bisogno aggiuntivo di manodopera per il 1956». La firma dell’accordo italo-tedesco divenne imminente e fu firmato a Roma, il 20 dicembre dello stesso anno, dal ministro del lavoro Anton Storch, dal ministro degli esteri Clemens von Brentano e, da parte italiana, dal ministro degli esteri Gaetano Martino. I problemi lasciati fino a quel momento sospesi riguardanti le questioni sul sussidio di disoccupazione per i lavoratori stagionali e il pagamento degli assegni familiari, furono così risolti: «Il sussidio di disoccupazione non sarebbe stato trasferito in Italia, ma la Repubblica federale tedesca si impegnava a pagare gli assegni familiari anche alle famiglie che rimanevano in Italia». 2. La ricezione della firma dell’accordo sulla stampa tedesca e italiana La firma dell’accordo bilaterale italo-tedesco fu riportata su tutti i maggiori giornali italiani e tedeschi, ma la sua trattazione differiva notevolmente. Se a Roma il reclutamento e il collocamento venivano presentati come imminenti e numericamente quantificabili, a Bonn, invece, venivano presentati come provvedimenti precauzionali, la cui applicazione era tutt’altro che incombente. La diversa interpretazione era dovuta al fatto che nell’accordo appena firmato non erano stabilite né la data precisa, né la quota dei lavoratori italiani da occupare nella Repubblica federale tedesca. La polemica sulla stampa tedesca fu innescata dalle affermazioni entusiastiche rilasciate a Roma dal Ministro del lavoro tedesco e riportate sul «Frankfurter Rundschau», giornale indipendente che nel 1955 usciva con 123.000 copie giornaliere. Il ministro del lavoro Storch aveva affermato, infatti, che «nell’accordo non è fissata nessuna quota dei lavoratori italiani perché la Repubblica federale tedesca ne vuole prendere il più possibile», e aveva aggiunto che se nello stesso anno i lavoratori italiani presenti nella Germania federale erano più di 50.000, l’anno seguente sarebbero diventati «molti, molti di più». Da Bonn, però, Maximilian Sauerborn, Staatssekretär vom Bundesarbeitsministerium (sottosegretario al lavoro), rilasciava in conferenza stampa nel pomeriggio dello stesso 20 dicembre una dichiarazione dove affermava che il reclutamento di lavoratori stagionali italiani non si pone fino a quando esista la disponibilità di manodopera idonea tedesca; ed è questo il motivo per cui l’accordo non fissa la quota della manodopera da collocare nella Germania federale. La mole e il tipo del reclutamento saranno stabiliti dai due Governi in base alla natura del bisogno da coprire nella Repubblica federale tedesca. Alle affermazioni fatte dal ministro del lavoro tedesco a Roma avevano fatto immediatamente da contraltare, con l’effetto di ridimensionarle, quelle del suo sottosegretario a Bonn, che, più difensive, andavano a rassicurare quanti temevano un arrivo illimitato di italiani e una perdita di controllo sul proprio mercato del lavoro. Queste paure, infatti, avevano fatto sì che il giornale a maggior tiratura - il «Ruhr-Nachrichten», quotidiano di orientamento cristiano democratico con una tiratura giornaliera di 142.000 copie - riportasse la notizia dell’accordo siglato a Roma sotto il titolo scritto a caratteri cubitali: Keine Italiener für den Bergbau (nessun italiano per le miniere) quasi a voler testimoniare una battaglia vinta. In apertura l’articolo riportava che gli italiani, come fermamente voluto dall’industria estrattiva (tanto dai datori di lavoro, quanto dal sindacato) non sarebbero stati collocati nell’industria mineraria tedesca. L’attenzione, poi, veniva tutta riposta sulla priorità assoluta che i lavoratori tedeschi avrebero continuato a mantenere sul loro mercato del lavoro. L’articolo sottolineava, infatti, che sarebbero stati soprattutto i lavoratori non qualificati a essere assunti nella Germania federale e solo in seguito a una selezione professionale e sanitaria svolta da una commissione tedesca. L’articolo, infine, rassicurava i lavoratori tedeschi che l’assunzione di lavoratori italiani non li avrebbe in alcun modo danneggiati. I lavoratori italiani sarebbero stati equiparati a quelli tedeschi per stipendio e condizioni contrattuali. Neanche nel tanto problematico settore delle abitazioni gli italiani avrebbero costituito, una minaccia per i tedeschi, poichè, dichiarava lo stesso sottosegretario Sauerborn, «noi non vogliamo che i nuovi appartamenti costruiti per i rifugiati e gli sfollati possano essere adesso presi in considerazione per gli italiani e che i tedeschi ne rimangano esclusi». Per questo sarebbero state le imprese a occuparsi degli alloggi per i lavoratori italiani e non lo stato. L’articolo, quindi, metteva bene in evidenza come fosse la Germania federale a modellare l’accordo bilaterale a suo vantaggio nell’interesse della propria produzione e dei propri lavoratori. Il «Frankfurter Rundschau» intitolava Firmato il contratto di lavoro Roma-Bonn e nel sottotitolo scriveva: «Quota della manodopera italiana non limitata». Il giornale si poneva in modo più aperto rispetto all’assunzione dei lavoratori italiani, riportava le affermazioni “romane” del ministro del lavoro e dava una sfumatura diversa alle affermazioni di Sauerborn riportando che il ricorso a manodopera straniera per il 1956 non può più essere evitato. L’anno passato l’occupazione è cresciuta di un milione di unità. In futuro, però, non ci potremo aspettare risultati così positivi perché tra i disoccupati si trovano adesso solo relativamente basse riserve di manodopera. Il «Frankfurter Rundschau», quindi, metteva in evidenza l’inevitabilità della scelta di occupare manodopera straniera per non ostacolare la crescita economica tedesca. Estremamente interessante in relazione alla previsione della quota degli italiani da assumere nella Germania federale è l’articolo del «Tagesspiegel», giornale indipendente stampato a Berlino ovest con tiratura giornaliera di 90.000 copie. L’articolo, dal titolo Lavoratori italiani verso la Germania, dava come imminente l’arrivo degli italiani quantificando il contingente e riportando i settori economici interessati: L’accordo firmato a Roma prevede un’occupazione annuale tra gli 80.000 e i 100.000 italiani. Gli italiani saranno selezionati e impiegati nell’agricoltura, nell’edilizia e nella tecnica. I lavoratori che durante i nove mesi del contratto avranno imparato il tedesco potranno in seguito lavorare anche nelle miniere. [...] I primi italiani dovrebbero arrivare in primavera. L’articolo si rifaceva alle fonti romane dell’agenzia d’informazione statunitense United press, e metteva ulteriormente in evidenza, circa l’imminenza e la quota dei lavoratori da occupare nella Germania federale, la differenza sostanziale tra le notizie provenienti da Roma e quelle provenienti da Bonn. Nell’articolo del «Tagesspiegel» le affermazioni di Sauerborn assumono solo il tono di rassicurazioni marginali: «il ricorso alla manodopera straniera sarà nei prossimi anni inevitabile. Ma anche in futuro saranno prima i tedeschi ad essere assunti». L’«Industriekurier», giornale degli industriali tedeschi, che usciva con una tiratura di 22.000 copie giornaliere, quantificava il fabbisogno di manodopera italiana per il settore agricolo in 10.000 lavoratori e ne sollecitava una immediata assunzione. Lo stesso ministro del lavoro Storch, di ritorno dall’Italia, sottolineò il valore politico ed economico assunto dell’accordo italo-tedesco per la Germania federale: Questo accordo è per la Germania un modello e una prova allo stesso tempo. Se dovesse funzionare, si potrebbe allargare alla Grecia, alla Spagna e alle zone di crisi nel vicino est e ai paesi che si affacciano al Mediterraneo. Per la Germania deve essere motivo di soddisfazione se oggi, nonostante il continuo afflusso dall’Est, può già pensare a un tale allargamento perché solo due o tre anni fa il problema della disoccupazione sembrava irrisolvibile. Al ministro del lavoro faceva eco l’articolo pubblicato sul «Bullettin des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung» (bollettino parlamentare) del gennaio 1956, in cui si leggeva: Nell’estate 1955 la crescita economica nella Repubblica federale tedesca esprimeva un’incredibile alta congiuntura. Essa riguardava non solo l’edilizia, l’industria delle materie prime e i beni d’investimento, ma anche l’industria dei beni di consumo. La crescita è stata così forte che il numero degli occupati è arrivato a 17,8 milioni, 4,2 milioni in più del 1949, e il numero dei disoccupati è diminuito a meno di mezzo milione riuscendo a occupare disoccupati, perseguitati, profughi, reduci, e invalidi Il ministro quindi rispondeva alle critiche mosse dal partito di opposizione Spd (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) che richiamava l’attenzione sulla disoccupazione di lungo periodo presente nelle zone periferiche e sul continuo afflusso dall’est Europa, affermando che l’economia era in una fase di crescita e l’assenza di manodopera straniera, sia semplice e sia specializzata, l’avrebbe potuta mettere in crisi. In Italia gli articoli pubblicati sulla firma dell’accordo italo-tedesco assunsero un tono ben diverso. D’altronde, se la Repubblica federale tedesca aveva posto la piena occupazione al centro delle sue scelte politiche ed economiche, l’Italia vedeva nell’emigrazione la via per rimettere in moto la sua economia. Questa convinzione era condivisa da tutti i partiti politici italiani oltre che dal mondo economico. “Emigrazione” era, per la stampa italiana, l’espressione che riassumeva il senso dell’accordo italo-tedesco, mentre la stessa espressione non trovava spazio sulla stampa tedesca. La Germania federale, infatti, aveva presentato l’occupazione dei lavoratori italiani come un esperimento legato alla positiva congiuntura economica, ma era ben lontana dal presentarla come l’inizio dell’immigrazione italiana nella Germania federale. Il «Corriere della Sera», principale quotidiano nazionale, riportava la notizia della firma dell’accordo avvenuta nel Salone della Vittoria di Palazzo Chigi, intitolando: Firmato a Roma l’accordo per i lavoratori italiani in Germania. Nel sottotitolo si riassumevano le principali informazioni: «I primi scaglioni apparterranno all’agricoltura e all’edilizia. Identità di trattamento, compresi gli assegni familiari, con gli operai tedeschi». L’articolo metteva in risalto l’importanza dell’intesa raggiunta sugli assegni familiari. Se le caratteristiche dell’accordo italo-tedesco erano, infatti, simili a quelle degli «accordi di emigrazione conclusi dall’Italia in questo dopoguerra», la novità principale consisteva «nell’accettazione, da parte tedesca, del pagamento degli assegni familiari anche quando la famiglia rimane in Italia». Gli assegni familiari erano presentati come la prova di un’effettiva uguaglianza di trattamento tra i lavoratori italiani e tedeschi e il «Corriere della Sera» riportava, al riguardo, le affermazioni del ministro del lavoro tedesco: «La maggior preoccupazione dell’accordo è stata quella di poter garantire ai lavoratori italiani che si recheranno in Germania ottime condizioni di lavoro e di sistemazione». Secondo l’accordo italo-tedesco, però, proprio la “sistemazione” dei lavoratori italiani era lasciata alle singole imprese e lo stato tedesco dettava solo delle norme molto generali sulla condizione degli alloggi. Il più delle volte le imprese tedesche misero a disposizione dei lavoratori italiani delle baracche di legno. L’articolo si concludeva riportando il comunicato di Palazzo Chigi sui tempi e le caratteristiche dell’occupazione italiana nella Germania federale: «Si ha motivo di ritenere che con l’inizio della primavera si possa realizzare praticamente una prima emigrazione di lavoratori italiani». I settori produttivi interessati erano quelli dell’agricoltura, dell’edilizia e della meccanica. L’accesso dei lavoratori italiani nelle miniere tedesche rimaneva, per il momento, chiuso e la motivazione apportata era la mancanza della conoscenza della lingua tedesca, «essendo prescritto che tutti i minatori debbano essere in grado di leggere e intendere le ordinanze in lingua tedesca per la sicurezza sul lavoro». «L’Unità», organo del Partito comunista italiano, intitolava: Firmato ieri l’accordo per l’emigrazione in Germania. Nell’articolo si metteva in evidenza il disappunto per la mancanza di una quota prestabilita di lavoratori da inviare all’estero e si affermava che «i termini dell’accordo sono estremamente vaghi». Venivano, così, deluse le aspettative di una corposa assunzione di manodopera italiana da parte tedesca. L’articolo continuava con il comunicato di Palazzo Chigi sui settori maggiormente interessati all’emigrazione e l’accordo sugli assegni familiari. Il «Giornale d’Italia», quotidiano romano d’ispirazione liberale, intitolava: Il significato dell’accordo emigratorio italo-tedesco. Nell’articolo si poneva l’accento sul valore politico dell’accordo bilaterale: Si prevede che a primavera potranno essere chiamati in Germania diecimila lavoratori, una cifra destinata a dilatarsi, se le circostanze aiuteranno. Perché in questo problema tutto è subordinato, connesso, a ragioni di alto interesse politico. Da un lato l’accordo era interpretato come «una prova della solidarietà economica e sociale» che la Germania occidentale offriva all’Italia, dall’altro lato, chiarito che l’accordo era funzionale anche alla crescita industriale tedesca, si sottolineava che era stato firmato in un particolare momento storico in cui «enormi interrogativi si levano nell’orizzonte politico», riferendosi alle questioni relative a «Unione Occidentale Europea, Alleanza atlantica, riunificazione tedesca»[41]. Lo stesso giornale, il giorno seguente, intitolava: Firma dell’accordo emigratorio italo-tedesco a Palazzo Chig. L’articolo informava che la delegazione tedesca aveva incontrato la delegazione italiana, prima della firma dell’accordo, per definire le questioni rimaste sospese relative agli assegni familiari e alla previdenza sociale. Nell’articolo si riportava che la Germania federale aveva accettato di pagare gli assegni familiari, ma non si dava notizia del rifiuto tedesco circa il pagamento della disoccupazione ai lavoratori italiani e ciò, presumibilmente, per non oscurare in alcun modo il successo della politica estera italiana. 3. Le caratteristiche dell’accordo bilaterale italo-tedesco e l’emigrazione “assistita” attraverso i Centri di emigrazione di Milano e Verona L’accordo bilaterale siglato con la Germania federale fu per l’Italia l’ultimo di tal genere mentre per la Germania federale fu il primo. L’Italia, infatti, attraverso la Direzione generale dell’emigrazione facente capo al ministero degli esteri, aveva firmato tra il 1946 e il 1955 accordi bilaterali con quattordici nazioni. La Germania federale, tra il 1955 ed il 1968, avrebbe firmato otto accordi bilaterali per il reclutamento di manodopera straniera. L’accordo bilaterale sottoscritto dall’Italia e dalla Germania federale si apriva con la seguente dichiarazione: Nel desiderio di approfondire e di stringere sempre più, nell’interesse reciproco, le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarietà europea, nonché di consolidare i legami d’amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera e un pieno sfruttamento delle possibilità di produzione, nella convinzione che questi sforzi servano l’interesse comune dei loro popoli e promuovano il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo. Il preambolo serviva a mostrare il comune interesse di entrambe le nazioni all’accordo e a metterne in evidenza il comune sentire europeo. Così il ministro del lavoro tedesco ne sottolineava il carattere di novità e di rottura con il passato: «l’italiano, che in base all’accordo bilaterale, viene in Germania, sa che lui non è un lavoratore dai diritti inferiori. Per lui valgono le stesse condizioni di lavoro e gli stessi diritti dei lavoratori tedeschi». Già nel primo capitolo dell’accordo però erano chiariti i rapporti di forza esistenti tra le due nazioni. Spettava solo al governo della Repubblica federale tedesca, «quando avesse constatato una penuria di manodopera e avesse voluto rimediarvi attraverso l’assunzione di lavoratori italiani», di avviare le trattative con il governo italiano. Spettava, quindi, solo al governo tedesco stabilire e comunicare le professioni e il fabbisogno numerico di manodopera al governo italiano. Responsabili del reclutamento e del collocamento della manodopera erano da parte tedesca, la Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung(Ente federale per il lavoro e l’assicurazione contro la disoccupazione), da parte italiana, il Ministero del lavoro e della providenza Sociale. La Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung nominava una commissione (Deutsche Kommission in Italien) che operava in Italia grazie alla collaborazione del Ministero del lavoro, che le metteva a disposizione i locali necessari e le assicurava assistenza attraverso i suoi uffici provinciali. Il funzionamento del reclutamento era così definito: la Commissione tedesca raccoglieva le richieste dei datori di lavoro tedeschi e le comunicava al ministero del lavoro italiano. Il ministero del lavoro organizzava le preselezioni professionali e sanitarie dei lavoratori italiani nelle diverse province interessate. La Commissione tedesca compiva, invece, la selezione finale a cui i candidati dovevano presentarsi forniti del certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei rispettivi comuni di provenienza. L’esame professionale doveva provare il grado d’istruzione generale posseduto dal candidato (in assenza di documentazione scritta bisognava provarne le capacità di calcolo), la sua formazione professionale ed eventualmente le occupazioni svolte in precedenza all’estero. L’esame medico invece aveva lo scopo di accertare lo stato di salute generale e l’idoneità fisica del candidato in relazione al mestiere da svolgere nella Germania federale. Erano escluse dal reclutamento le persone affette da «malattie e imperfezioni che avrebbero potuto limitare o annullare l’idoneità al mestiere» o che avrebbero potuto «danneggiare la convivenza con altre persone» o, ancora, che avrebbero potuto «richiedere continue cure mediche». Nell’accordo erano elencate la tubercolosi polmonare, le malattie infettive o parassitarie contagiose, i disturbi dell’apparato digestivo «suscettibili di aggravamento per effetto del cambiamento del regime alimentare». Erano anche da escludere i lavoratori con «diminuzioni considerevoli della funzione degli organi della vista e dell’udito, carie e paradentosi necessitanti cure mediche o dentatura con insufficiente capacità di masticazione. Una volta passate le selezioni, i candidati potevano firmare il contratto di lavoro con cui venivano equiparati, per retribuzione e condizioni di lavoro, ai lavoratori tedeschi con pari qualifica. Il primo contingente di 1.389 lavoratori italiani arrivò nella Repubblica federale tedesca nell’aprile 1956. La Commissione tedesca iniziò, il 6 febbraio 1956, la sua attività di reclutamento presso il Centro di emigrazione di Milano, operativo dal 1946, che era con i Centri di emigrazione di Genova, Napoli e Messina, preposto alla convocazione, alla selezione e all’espatrio dei lavoratori e dei loro familiari, diretti all’estero. Le Commissioni straniere presenti nel Centro di emigrazione di Milano si distinguevano tra “permanenti” e “mobili”. Cinque erano le Commissioni permanenti e cioè quella del Belgio, della Francia, della Gran Bretagna, della Repubblica federale tedesca e del Cime (Comitato intergovernativo migrazioni europee, che assisteva i familiari dei lavoratori che emigravano nei paesi oltremare). Le commissioni mobili, invece, erano presenti in numero variabile: tra queste l’Olanda, la Svezia, il Brasile, il Sud-Africa, il Cile, la Colombia, l’Australia e la Rhodesia. Il Centro di emigrazione di Milano curava soprattutto l’emigrazione verso l’Europa e solo in maniera più ridotta le destinazioni extraeuropee. L’afflusso raggiungeva, nei periodi di primavera e autunno, cioè quando le richieste di lavoratori stagionali erano maggiori, i 2.000 arrivi giornalieri. Per la mancanza di spazio, i corridoi del Centro emigrazione si trasformavano in camerate in cui erano dislocati fino a 600 posti letto (la maggior parte dei letti in dotazione al Centro erano triposto). Dal 1946 al 1955 la media annua degli emigranti passati dal centro di Milano era stata di 58.283 persone, mentre nel 1956 l’affluenza era raddoppiata toccando i 105.671 assistiti. Nello stesso anno, la principale meta del flusso migratorio fu rappresentata dalla Franci, dove la principale categoria professionale ricoperta dagli italiani, era quella dei bieticoltori (24.148 lavoratori), che rappresentava anche, in assoluto, la principale occupazione dei lavoratori italiani emigrati. Seguivano i lavoratori edili con 20.263 e quelli appartenenti alla categoria “industria” con 13.483. I lavoratori diretti verso la Francia provenivano principalmente dal Veneto e dalla Puglia. Per il Belgio, dove erano richiesti principalmente minatori, i lavoratori italiani partirono soprattutto dall’Abruzzo e dalla Sicilia; per la Gran Bretagna, dove si richiedevano principalmente fornaciai, i lavoratori partirono dalla Campania. Per la Repubblica federale tedesca, dove la prima categoria a essere richiesta fu quella degli agricoli, si partì dalla Puglia, dal Friuli e dal Veneto. Per l’Olanda, dove si richiedevano soprattutto metalmeccanici, i lavoratori partirono dalla Sardegna. Per la Svizzera, dove erano richiesti principalmente gli agricoli, i lavoratori partirono dalla Basilicata. L’attività della Commissione tedesca presso il Centro di emigrazione di Milano, che si svolse dal 6 febbraio al 31 maggio 1956, permise il reclutamento di 3.545 lavoratori di cui 2.125 furono indirizzati verso l’agricoltura e 1.363 verso i settori dell’industria. Il primo giugno 1956 la Commissione tedesca in Italia si trasferì a Verona, dove fu creato un centro per ospitarla. Una commissione tedesca fu attiva anche presso il Centro di emigrazione di Napoli per il periodo compreso tra il 1960 e il 1966, quando, cioè, nella Germania federale si registrò un lungo periodo di crescita economica. Il Centro di emigrazione di Verona raggiunse nei primi anni ’60 una capacità ricettiva di 900 posti letto, organizzando un flusso migratorio che arrivò a superare le 1.000 persone al giorno.Dal 1956 al 1975 affluirono presso il Centro di Verona 338.147 persone di cui 302.755 furono i lavoratori ritenuti idonei per lavorare nella Germania federale. Il flusso migratorio proveniente principalmente dal Veneto, dalla Puglia e dalla Campania prese le caratteristiche dapprima di un flusso stagionale, diretto verso il settore agricolo e il settore edilizio del Niedersachsen, Baden-Württemberg e Nordrhein-Westfalen, mentre a partire dai primi anni ´60 il settore agricolo fu decisamente superato dal settore edilizio e meccanico. Dalla metà degli anni sessanta fino alla crisi petrolifera del 1973 il flusso emigratorio italiano si diresse verso il settore metalmeccanico assumendo, soprattutto negli stati federali del Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern e Hessen, le caratteristiche di un’emigrazione di lavoro permanente. Le caratteristiche del flusso migratorio furono determinate da un lato dall’andamento economico registrato nella Germania federale, dall’altro dall’entrata in vigore dei regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità economica europea. Nei periodi di alta congiuntura, i lavoratori selezionati dalla commissione tedesca di Verona erano principalmente lavoratori semplici diretti verso le industrie a ciclo permanente. Nei periodi di congiuntura negativa il numero dei lavoratori assunti nella Germania federale si riduceva in modo vertiginoso e si restringeva alle categorie di lavoratori specializzati assunti però con contratti stagionali. A fianco all’andamento economico tedesco, le caratteristiche del flusso migratorio furono determinate anche dalla progressiva entrata in vigore dei regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori nella Cee. Il trattato di Roma che sanciva «l’eliminazione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali», fu firmato nel 1957 ed entrò in vigore con il regolamento comunitario numero1.612 del 1968. La graduale applicazione dei decreti segnò la progressiva perdita d’importanza dei Centri di emigrazione. Il primo regolamento del 1961 sancì la libera circolazione per i lavoratori permanenti; il secondo regolamento del 1964 allargò il diritto di libera circolazione ai lavoratori stagionali ed ai frontalieri; il terzo regolamento del 1968 segnò la fine della priorità tedesca sul mercato della Germania federale e ai lavoratori tedeschi non fu più riservata la priorità di assunzione rispetto agli Italiani. L’emigrazione “assistita” fu progressivamente sostituita dall’emigrazione di lavoratori che, utilizzando sempre più spesso i canali informali offerti da parenti e amici già occupati nella Germania federale, vennero assunti direttamente dai datori di lavoro tedeschi. A fianco all’entrata in vigore dei regolamenti europei sulla libera circolazione, giocarono un ruolo importante nella definizione numerica dei flussi migratori le inefficienze e carenze del sistema di convocazione e selezione dei Centri stessi. Le inefficenze andavano palesandosi con la mancanza di compensazione fra le domande e le offerte di lavoro. Succedeva, infatti, che nel primo semestre di ogni anno, quando gli Uffici provinciali del lavoro segnalavano ai Centri di emigrazione la presenza di migliaia di lavoratori disponibili per l’espatrio, le Commissione tedesche disponevano solo di poche centinaia di contratti di lavoro. Molti lavoratori decidevano, così, di partire autonomamente per la Repubblica federale tedesca o di andare a lavorare in altre nazioni, principalmente la Svizzera. Per contro, nel secondo semestre la Commissione tedesca disponeva di un maggior numero di contratti di lavoro ma il numero dei lavoratori disposti a partire era decisamente ridotto. Nel 1968, per esempio, non trovarono collocamento nel primo semestre, a causa della mancanza di contratti, circa 8.000 lavoratori, mentre nella seconda parte dell’anno non si raggiunse invece il numero di lavoratori richiesto dalla Germania federale. Se i tempi della domanda e dell’offerta fossero coincisi, sarebbero espatriati il doppio dei lavoratori effettivamente partiti (10.489). Nel 1971, anno di alta congiuntura per l’economia tedesca, furono assunti attraverso il Centro di emigrazione di Verona solo 4.332 lavoratori mentre la quota dei lavoratori italiani registrata al 30 settembre nella Germania federale era di 407.900 persone. A partire dai primi anni settanta si andarono stabilizzando, grazie ai ricongiungimenti familiari, le comunità straniere residenti nella Germania federale. I lavoratori italiani erano passati da circa 220.000 del 1961 a circa 450.000 del 1973 e, alla stessa data, la comunità italiana consisteva di circa 620.000 persone. La comunità italiana seguiva quella turca composta da quasi 900.000 persone e quella jugoslava con circa 670.000. Nel 1974 e nel 1975 la crisi economica internazionale fece sentire i suoi effetti negativi soprattutto sul settore automobilistico tedesco e ciò si ripercosse anche sull’emigrazione italiana di lavoro. Nell’anno 1975 espatriarono dal Centro di Verona solo 229 lavoratori, toccando così la punta più bassa dell’emigrazione “assistita”, e circa 1.200 domande di espatrio rimasero insoddisfatte per mancanza di richieste da parte tedesca[. Se il numero dei lavoratori italiani si andò riducendo, quello della comunità italiana rimase con le sue 600.000 unità pressoché stabile dando vita alla comunità italiana più numerosa presente in Europa. (Grazia Prontera)
 L'emigrazione italiana verso la Repubblica federale tedesca. L'accordo bilaterale del 1955, la ricezione sulla stampa, il ruolo dei Centri di emigrazione di Milano e Verona Il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica federale tedesca firmarono, il 20 dicembre 1955, l’accordo per il reclutamento e il collocamento di
L'emigrazione italiana verso la Repubblica federale tedesca. L'accordo bilaterale del 1955, la ricezione sulla stampa, il ruolo dei Centri di emigrazione di Milano e Verona Il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica federale tedesca firmarono, il 20 dicembre 1955, l’accordo per il reclutamento e il collocamento di manodopera italiana nella Germania federale. Le trattative che condussero alla firma di tale accordo furono il frutto sia di esigenze nazionali, sia di istanze internazionali. Il flusso emigratorio che ne scaturì fu influenzato, a sua volta, dalla progressiva entrata in vigore della libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità economica europea, e dall’andamento economico registrato nelle nazioni coinvolte. La prima fase dell’emigrazione diretta verso la Germania federale fu definita “assistita” poiché pianificata a livello istituzionale e organizzata attraverso i Centri di emigrazione. La seconda fase dell’emigrazione fu caratterizzata della libera circolazione dei lavoratori e da forme di reclutamento indipendenti dalla mediazione dei Centri di emigrazione. I lavoratori italiani trovarono lavoro recandosi direttamente all’estero. Quest’articolo si concentra sullo studio dell’emigrazione “assistita” e, partendo dall’analisi del contesto politico-economico in cui l’accordo bilaterale fu sottoscritto, ne analizza la ricezione sulla stampa tedesca e italiana, soffermandosi, infine, sull’analisi dei flussi migratori gestiti dai Centri di emigrazione di Milano e Verona. In particolare, la storia del Centro di emigrazione di Verona e il ruolo giocato da questo nella definizione effettiva dei flussi migratori (provenienza regionale, quantità numerica, qualifiche professionali, e destinazione) rappresentano degli aspetti ancora poco approfonditi dell’emigrazione italiana verso la Germania federale. 1. Le premesse della firma dell’Accordo bilaterale italo-tedesco per il reclutamento e il collocamento della manodopera italiana nella Repubblica federale tedesca Le trattative che condussero alla firma dell’accordo bilaterale italo-tedesco si possono far risalire all’ottobre del 1953, quando il governo italiano chiese al governo tedesco di occupare lavoratori stagionali italiani a causa della diminuzione costante delle importazioni italiane da parte tedesca . La discussione sul saldo negativo dei pagamenti e sul reclutamento della manodopera caratterizzò i rapporti economici italo-tedeschi per tutto il 1954. L’apice si raggiunse a luglio, quando l’Italia, davanti alla reticenza tedesca, minacciò di «tornare ad una politica commerciale restrittiva se gli altri stati non fossero stati disposti ad un’attuazione liberale dell’assunzione di manodopera». Alla richiesta italiana, però, Bernhard Ehmke (dirigente del ministero federale del lavoro) rispose chiaramente che il bisogno di manodopera nella Repubblica federale tedesca poteva «ancora essere soddisfatto con quella locale» e rifiutava i «legami contrattuali» con l’Italia perché li riteneva prematuri. Le forti interdipendenze esistenti tra l’Italia e la Germania federale erano il frutto della ricostruzione economica post-bellica che ponendo le esportazioni al centro della rinascita economica europea, si basava sulla liberalizzazione del commercio estero. Il progetto di un’Europa economicamente integrata, progetto che, come afferma lo storico Charles Maier, era rimasto parzialmente irrealizzato, era stato il progetto degli Stati Uniti di Truman che, con il piano Marshall, aveva proposto alle nazioni europee un piano di crescita economica comune. Gli Stati Uniti pensavano all’Europa come a una “regione”, dove ogni nazione avrebbe dovuto ricoprire ruoli funzionalmente interdipendenti dettati dalla propria storia e dalle proprie risorse. Il compito degli Stati Uniti sarebbe stato quello di attivare un meccanismo «self help adatto a rimettere in moto la spina al recupero di produttività». La crescita economica avrebbe garantito la stabilità politica e la pace sociale dell’Europa e sarebbe stata l’unico antidoto sia contro i partiti comunisti, forti soprattutto in Francia e in Italia, sia contro il pericolo sovietico. Carlo Spagnolo sottolinea il valore principalmente politico assunto dagli aiuti economici americani affermando che «gli aiuti americani furono politicamente decisivi alla ricostruzione europea». Gli Stati Uniti individuavano, nel recupero politico ed economico della Germania occidentale, la condizione necessaria e indispensabile per la rinascita economica europea, e contemporaneamente ne facevano il baluardo della loro politica di contenimento. Se da un lato, infatti, alla Germania federale con il suo carbone e con le sue capacità tecniche veniva riconosciuto il ruolo trainante per la ripresa economica del continente, dall’altro lo scivolamento della Germania occidentale nell’area comunista avrebbe potuto significare la perdita dell’Europa. Nel 1948 gli Stati Uniti crearono l’Organizzazione europea di cooperazione economica (Oece) per ripartire gli aiuti del piano Marshall tra gli stati firmatari. L’Oece ebbe un carattere prevalentemente tecnico e di coordinamento e non soprannazionale, come invece avrebbero voluto gli americani. Nazioni come la Francia e la Gran Bretagna, infatti, vi si erano opposte per il timore di perdere la propria sovranità. Il principio della ricostruzione della Germania federale venne comunque riconosciuto da tutti gli stati firmatari a condizione che esso fosse controllato per evitare conseguenze dannose all’economia e alla finanza degli altri paesi. Da parte sua la Germania occidentale, con sovranità limitata fino al 1955 e soggetta a uno stazionamento di forze d’occupazione, si impegnava in una ricostruzione ed espansione industriale dichiarando esplicitamente il proprio «fervido desiderio di servire la causa europea». Nel settembre del 1949 era nata la Repubblica federale tedesca e Konrad Adenauer, il suo primo Bundeskanzler, seppe leggere le opportunità politiche insite nell’idea di Europa e far riguadagnare alla Repubblica federale tedesca la pari dignità con gli altri paesi rendendola così idonea alla «collaborazione all’interno degli organismi europei». L’Italia nel 1949 aderì all’Oece e intraprese la strada della liberalizzazione progressiva della sua economia. Per l’Italia, infatti, povera di materie prime, lo sviluppo industriale significava, prima di tutto lo sviluppo delle importazioni. Uno sviluppo delle importazioni avrebbe comportato una pari crescita delle esportazioni e avrebbe necessitato di un clima di aperture commerciali. L’Italia nel 1954 aprì, quindi, il proprio mercato alle importazioni dai paesi Oece abolendone fino al 99% le limitazioni quantitative. Per giocare un ruolo nell’intreccio di collaborazioni internazionali, l’Italia aveva puntato sulla stabilità monetaria pagando, però, il costo di «povertà e vulnerabilità interna». Lo sviluppo di un’industria competitiva sul piano internazionale, localizzato principalmente nel triangolo industriale di Milano, Torino e Genova e orientato verso l’aumento della produttività e dell’esportazione lasciava, infatti, irrisolto il problema del riassorbimento della disoccupazione. La domanda proveniente dai paesi europei più industrializzati, infatti, si orientava verso i consumi di massa e di lusso e quindi solo verso specifici settori della produzione italiana come l’industria automobilistica, i prodotti petroliferi, alcuni prodotti tessili, le calzature e la gomma. Secondo Graziani, furono proprio le esportazioni a mettere in moto un «circolo vizioso di squilibri e di disuguaglianze», prime fra tutte le emigrazioni esterne e interne e il sottosviluppo del mezzogiorno. L’Italia di Alcide De Gasperi affrontò il problema della disoccupazione aprendo strade istituzionali all’emigrazione stessa a cui neanche il Sindacato unitario dei lavoratori, «trincerandosi dietro la dura necessità del momento», si era realmente opposto. De Gasperi intendeva trovare sbocchi occupazionali per la manodopera italiana nelle nazioni aderenti all’Oece «in un’ottica di scambi di concessioni commerciali reciproche». Se da un lato gli emigranti avrebbero contribuito a sanare il bilancio statale, dall’altro l’emigrazione indeboliva i contrasti sociali interni permettendo il consolidamento politico della Democrazia cristiana. Che l’emigrazione fosse una voce fondamentale nel capitolo della bilancia dei pagamenti con l’estero, lo dimostra il primo piano per lo sviluppo dell’economia presentato dall’Italia all’Oece per il quadriennio 1948-49/1952-53 dove venne prevista un’emigrazione netta di 823.000 unità, di cui 364.000 dirette verso l’Europa e 468.000 dirette verso gli altri continenti; tutto ciò avrebbe prodotto, in rimesse, una quota di 205 milioni di dollari, pari al 10% delle importazioni. Al temine dello stesso periodo, però, ci si aspettava di registrare ancora 1.188.000 disoccupati, ai quali si sarebbero dovuti aggiungere, secondo la Direzione per l’emigrazione del ministero degli esteri, altri due milioni di sottoccupati. La Germania di Adenauer, invece, per garantire la stabilità sociale e politica interna si era prefissata l’obiettivo della piena occupazione. D’altronde, come osserva Christoph Buchheim, fu proprio «l’impiego della forza lavoro […] di milioni di disoccupati e sottoccupati, tra cui molti profughi e rifugiati», a essere il motore della crescita economica. Non c’era da stupirsi se, ancora all’inizio del 1954, il Ministro del lavoro e i sindacati tedeschi si opponessero alle trattative con l’Italia per il collocamento di lavoratori italiani nella Repubblica Federale Tedesca, richiamando l’attenzione sugli alti tassi di disoccupazione esistenti nel settore agricolo. D’altra parte, però, l’Italia era un’importantissima importatrice di carbone e i maggiori introiti delle esportazioni tedesche erano fatturati nel commercio di prodotti dell’industria meccanica, metallurgica e chimica, proprio con l’Italia. Così, all’inizio del 1955, la Germania federale propose all’Italia un accordo “preventivo” sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani, un accordo che sarebbe entrato in vigore solo nel caso in cui la Germania federale ne avesse avuto bisogno, e cioè solo quando la disoccupazione tedesca fosse stata completamente riassorbita. All’inizio dello stesso anno, l’Italia aveva presentato all’Oece il piano Vanoni in cui per il decennio successivo si prevedeva un’emigrazione di 800.000 lavoratori, ritenuta indispensabile per garantire la crescita economica e riequilibrare il grave divario esistente tra nord e sud.. Nel settembre 1955 la disoccupazione tedesca toccò il 2,7% e a novembre il ministero del lavoro tedesco stimò a 800.000 il «bisogno aggiuntivo di manodopera per il 1956». La firma dell’accordo italo-tedesco divenne imminente e fu firmato a Roma, il 20 dicembre dello stesso anno, dal ministro del lavoro Anton Storch, dal ministro degli esteri Clemens von Brentano e, da parte italiana, dal ministro degli esteri Gaetano Martino. I problemi lasciati fino a quel momento sospesi riguardanti le questioni sul sussidio di disoccupazione per i lavoratori stagionali e il pagamento degli assegni familiari, furono così risolti: «Il sussidio di disoccupazione non sarebbe stato trasferito in Italia, ma la Repubblica federale tedesca si impegnava a pagare gli assegni familiari anche alle famiglie che rimanevano in Italia». 2. La ricezione della firma dell’accordo sulla stampa tedesca e italiana La firma dell’accordo bilaterale italo-tedesco fu riportata su tutti i maggiori giornali italiani e tedeschi, ma la sua trattazione differiva notevolmente. Se a Roma il reclutamento e il collocamento venivano presentati come imminenti e numericamente quantificabili, a Bonn, invece, venivano presentati come provvedimenti precauzionali, la cui applicazione era tutt’altro che incombente. La diversa interpretazione era dovuta al fatto che nell’accordo appena firmato non erano stabilite né la data precisa, né la quota dei lavoratori italiani da occupare nella Repubblica federale tedesca. La polemica sulla stampa tedesca fu innescata dalle affermazioni entusiastiche rilasciate a Roma dal Ministro del lavoro tedesco e riportate sul «Frankfurter Rundschau», giornale indipendente che nel 1955 usciva con 123.000 copie giornaliere. Il ministro del lavoro Storch aveva affermato, infatti, che «nell’accordo non è fissata nessuna quota dei lavoratori italiani perché la Repubblica federale tedesca ne vuole prendere il più possibile», e aveva aggiunto che se nello stesso anno i lavoratori italiani presenti nella Germania federale erano più di 50.000, l’anno seguente sarebbero diventati «molti, molti di più». Da Bonn, però, Maximilian Sauerborn, Staatssekretär vom Bundesarbeitsministerium (sottosegretario al lavoro), rilasciava in conferenza stampa nel pomeriggio dello stesso 20 dicembre una dichiarazione dove affermava che il reclutamento di lavoratori stagionali italiani non si pone fino a quando esista la disponibilità di manodopera idonea tedesca; ed è questo il motivo per cui l’accordo non fissa la quota della manodopera da collocare nella Germania federale. La mole e il tipo del reclutamento saranno stabiliti dai due Governi in base alla natura del bisogno da coprire nella Repubblica federale tedesca. Alle affermazioni fatte dal ministro del lavoro tedesco a Roma avevano fatto immediatamente da contraltare, con l’effetto di ridimensionarle, quelle del suo sottosegretario a Bonn, che, più difensive, andavano a rassicurare quanti temevano un arrivo illimitato di italiani e una perdita di controllo sul proprio mercato del lavoro. Queste paure, infatti, avevano fatto sì che il giornale a maggior tiratura - il «Ruhr-Nachrichten», quotidiano di orientamento cristiano democratico con una tiratura giornaliera di 142.000 copie - riportasse la notizia dell’accordo siglato a Roma sotto il titolo scritto a caratteri cubitali: Keine Italiener für den Bergbau (nessun italiano per le miniere) quasi a voler testimoniare una battaglia vinta. In apertura l’articolo riportava che gli italiani, come fermamente voluto dall’industria estrattiva (tanto dai datori di lavoro, quanto dal sindacato) non sarebbero stati collocati nell’industria mineraria tedesca. L’attenzione, poi, veniva tutta riposta sulla priorità assoluta che i lavoratori tedeschi avrebero continuato a mantenere sul loro mercato del lavoro. L’articolo sottolineava, infatti, che sarebbero stati soprattutto i lavoratori non qualificati a essere assunti nella Germania federale e solo in seguito a una selezione professionale e sanitaria svolta da una commissione tedesca. L’articolo, infine, rassicurava i lavoratori tedeschi che l’assunzione di lavoratori italiani non li avrebbe in alcun modo danneggiati. I lavoratori italiani sarebbero stati equiparati a quelli tedeschi per stipendio e condizioni contrattuali. Neanche nel tanto problematico settore delle abitazioni gli italiani avrebbero costituito, una minaccia per i tedeschi, poichè, dichiarava lo stesso sottosegretario Sauerborn, «noi non vogliamo che i nuovi appartamenti costruiti per i rifugiati e gli sfollati possano essere adesso presi in considerazione per gli italiani e che i tedeschi ne rimangano esclusi». Per questo sarebbero state le imprese a occuparsi degli alloggi per i lavoratori italiani e non lo stato. L’articolo, quindi, metteva bene in evidenza come fosse la Germania federale a modellare l’accordo bilaterale a suo vantaggio nell’interesse della propria produzione e dei propri lavoratori. Il «Frankfurter Rundschau» intitolava Firmato il contratto di lavoro Roma-Bonn e nel sottotitolo scriveva: «Quota della manodopera italiana non limitata». Il giornale si poneva in modo più aperto rispetto all’assunzione dei lavoratori italiani, riportava le affermazioni “romane” del ministro del lavoro e dava una sfumatura diversa alle affermazioni di Sauerborn riportando che il ricorso a manodopera straniera per il 1956 non può più essere evitato. L’anno passato l’occupazione è cresciuta di un milione di unità. In futuro, però, non ci potremo aspettare risultati così positivi perché tra i disoccupati si trovano adesso solo relativamente basse riserve di manodopera. Il «Frankfurter Rundschau», quindi, metteva in evidenza l’inevitabilità della scelta di occupare manodopera straniera per non ostacolare la crescita economica tedesca. Estremamente interessante in relazione alla previsione della quota degli italiani da assumere nella Germania federale è l’articolo del «Tagesspiegel», giornale indipendente stampato a Berlino ovest con tiratura giornaliera di 90.000 copie. L’articolo, dal titolo Lavoratori italiani verso la Germania, dava come imminente l’arrivo degli italiani quantificando il contingente e riportando i settori economici interessati: L’accordo firmato a Roma prevede un’occupazione annuale tra gli 80.000 e i 100.000 italiani. Gli italiani saranno selezionati e impiegati nell’agricoltura, nell’edilizia e nella tecnica. I lavoratori che durante i nove mesi del contratto avranno imparato il tedesco potranno in seguito lavorare anche nelle miniere. [...] I primi italiani dovrebbero arrivare in primavera. L’articolo si rifaceva alle fonti romane dell’agenzia d’informazione statunitense United press, e metteva ulteriormente in evidenza, circa l’imminenza e la quota dei lavoratori da occupare nella Germania federale, la differenza sostanziale tra le notizie provenienti da Roma e quelle provenienti da Bonn. Nell’articolo del «Tagesspiegel» le affermazioni di Sauerborn assumono solo il tono di rassicurazioni marginali: «il ricorso alla manodopera straniera sarà nei prossimi anni inevitabile. Ma anche in futuro saranno prima i tedeschi ad essere assunti». L’«Industriekurier», giornale degli industriali tedeschi, che usciva con una tiratura di 22.000 copie giornaliere, quantificava il fabbisogno di manodopera italiana per il settore agricolo in 10.000 lavoratori e ne sollecitava una immediata assunzione. Lo stesso ministro del lavoro Storch, di ritorno dall’Italia, sottolineò il valore politico ed economico assunto dell’accordo italo-tedesco per la Germania federale: Questo accordo è per la Germania un modello e una prova allo stesso tempo. Se dovesse funzionare, si potrebbe allargare alla Grecia, alla Spagna e alle zone di crisi nel vicino est e ai paesi che si affacciano al Mediterraneo. Per la Germania deve essere motivo di soddisfazione se oggi, nonostante il continuo afflusso dall’Est, può già pensare a un tale allargamento perché solo due o tre anni fa il problema della disoccupazione sembrava irrisolvibile. Al ministro del lavoro faceva eco l’articolo pubblicato sul «Bullettin des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung» (bollettino parlamentare) del gennaio 1956, in cui si leggeva: Nell’estate 1955 la crescita economica nella Repubblica federale tedesca esprimeva un’incredibile alta congiuntura. Essa riguardava non solo l’edilizia, l’industria delle materie prime e i beni d’investimento, ma anche l’industria dei beni di consumo. La crescita è stata così forte che il numero degli occupati è arrivato a 17,8 milioni, 4,2 milioni in più del 1949, e il numero dei disoccupati è diminuito a meno di mezzo milione riuscendo a occupare disoccupati, perseguitati, profughi, reduci, e invalidi Il ministro quindi rispondeva alle critiche mosse dal partito di opposizione Spd (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) che richiamava l’attenzione sulla disoccupazione di lungo periodo presente nelle zone periferiche e sul continuo afflusso dall’est Europa, affermando che l’economia era in una fase di crescita e l’assenza di manodopera straniera, sia semplice e sia specializzata, l’avrebbe potuta mettere in crisi. In Italia gli articoli pubblicati sulla firma dell’accordo italo-tedesco assunsero un tono ben diverso. D’altronde, se la Repubblica federale tedesca aveva posto la piena occupazione al centro delle sue scelte politiche ed economiche, l’Italia vedeva nell’emigrazione la via per rimettere in moto la sua economia. Questa convinzione era condivisa da tutti i partiti politici italiani oltre che dal mondo economico. “Emigrazione” era, per la stampa italiana, l’espressione che riassumeva il senso dell’accordo italo-tedesco, mentre la stessa espressione non trovava spazio sulla stampa tedesca. La Germania federale, infatti, aveva presentato l’occupazione dei lavoratori italiani come un esperimento legato alla positiva congiuntura economica, ma era ben lontana dal presentarla come l’inizio dell’immigrazione italiana nella Germania federale. Il «Corriere della Sera», principale quotidiano nazionale, riportava la notizia della firma dell’accordo avvenuta nel Salone della Vittoria di Palazzo Chigi, intitolando: Firmato a Roma l’accordo per i lavoratori italiani in Germania. Nel sottotitolo si riassumevano le principali informazioni: «I primi scaglioni apparterranno all’agricoltura e all’edilizia. Identità di trattamento, compresi gli assegni familiari, con gli operai tedeschi». L’articolo metteva in risalto l’importanza dell’intesa raggiunta sugli assegni familiari. Se le caratteristiche dell’accordo italo-tedesco erano, infatti, simili a quelle degli «accordi di emigrazione conclusi dall’Italia in questo dopoguerra», la novità principale consisteva «nell’accettazione, da parte tedesca, del pagamento degli assegni familiari anche quando la famiglia rimane in Italia». Gli assegni familiari erano presentati come la prova di un’effettiva uguaglianza di trattamento tra i lavoratori italiani e tedeschi e il «Corriere della Sera» riportava, al riguardo, le affermazioni del ministro del lavoro tedesco: «La maggior preoccupazione dell’accordo è stata quella di poter garantire ai lavoratori italiani che si recheranno in Germania ottime condizioni di lavoro e di sistemazione». Secondo l’accordo italo-tedesco, però, proprio la “sistemazione” dei lavoratori italiani era lasciata alle singole imprese e lo stato tedesco dettava solo delle norme molto generali sulla condizione degli alloggi. Il più delle volte le imprese tedesche misero a disposizione dei lavoratori italiani delle baracche di legno. L’articolo si concludeva riportando il comunicato di Palazzo Chigi sui tempi e le caratteristiche dell’occupazione italiana nella Germania federale: «Si ha motivo di ritenere che con l’inizio della primavera si possa realizzare praticamente una prima emigrazione di lavoratori italiani». I settori produttivi interessati erano quelli dell’agricoltura, dell’edilizia e della meccanica. L’accesso dei lavoratori italiani nelle miniere tedesche rimaneva, per il momento, chiuso e la motivazione apportata era la mancanza della conoscenza della lingua tedesca, «essendo prescritto che tutti i minatori debbano essere in grado di leggere e intendere le ordinanze in lingua tedesca per la sicurezza sul lavoro». «L’Unità», organo del Partito comunista italiano, intitolava: Firmato ieri l’accordo per l’emigrazione in Germania. Nell’articolo si metteva in evidenza il disappunto per la mancanza di una quota prestabilita di lavoratori da inviare all’estero e si affermava che «i termini dell’accordo sono estremamente vaghi». Venivano, così, deluse le aspettative di una corposa assunzione di manodopera italiana da parte tedesca. L’articolo continuava con il comunicato di Palazzo Chigi sui settori maggiormente interessati all’emigrazione e l’accordo sugli assegni familiari. Il «Giornale d’Italia», quotidiano romano d’ispirazione liberale, intitolava: Il significato dell’accordo emigratorio italo-tedesco. Nell’articolo si poneva l’accento sul valore politico dell’accordo bilaterale: Si prevede che a primavera potranno essere chiamati in Germania diecimila lavoratori, una cifra destinata a dilatarsi, se le circostanze aiuteranno. Perché in questo problema tutto è subordinato, connesso, a ragioni di alto interesse politico. Da un lato l’accordo era interpretato come «una prova della solidarietà economica e sociale» che la Germania occidentale offriva all’Italia, dall’altro lato, chiarito che l’accordo era funzionale anche alla crescita industriale tedesca, si sottolineava che era stato firmato in un particolare momento storico in cui «enormi interrogativi si levano nell’orizzonte politico», riferendosi alle questioni relative a «Unione Occidentale Europea, Alleanza atlantica, riunificazione tedesca»[41]. Lo stesso giornale, il giorno seguente, intitolava: Firma dell’accordo emigratorio italo-tedesco a Palazzo Chig. L’articolo informava che la delegazione tedesca aveva incontrato la delegazione italiana, prima della firma dell’accordo, per definire le questioni rimaste sospese relative agli assegni familiari e alla previdenza sociale. Nell’articolo si riportava che la Germania federale aveva accettato di pagare gli assegni familiari, ma non si dava notizia del rifiuto tedesco circa il pagamento della disoccupazione ai lavoratori italiani e ciò, presumibilmente, per non oscurare in alcun modo il successo della politica estera italiana. 3. Le caratteristiche dell’accordo bilaterale italo-tedesco e l’emigrazione “assistita” attraverso i Centri di emigrazione di Milano e Verona L’accordo bilaterale siglato con la Germania federale fu per l’Italia l’ultimo di tal genere mentre per la Germania federale fu il primo. L’Italia, infatti, attraverso la Direzione generale dell’emigrazione facente capo al ministero degli esteri, aveva firmato tra il 1946 e il 1955 accordi bilaterali con quattordici nazioni. La Germania federale, tra il 1955 ed il 1968, avrebbe firmato otto accordi bilaterali per il reclutamento di manodopera straniera. L’accordo bilaterale sottoscritto dall’Italia e dalla Germania federale si apriva con la seguente dichiarazione: Nel desiderio di approfondire e di stringere sempre più, nell’interesse reciproco, le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarietà europea, nonché di consolidare i legami d’amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera e un pieno sfruttamento delle possibilità di produzione, nella convinzione che questi sforzi servano l’interesse comune dei loro popoli e promuovano il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo. Il preambolo serviva a mostrare il comune interesse di entrambe le nazioni all’accordo e a metterne in evidenza il comune sentire europeo. Così il ministro del lavoro tedesco ne sottolineava il carattere di novità e di rottura con il passato: «l’italiano, che in base all’accordo bilaterale, viene in Germania, sa che lui non è un lavoratore dai diritti inferiori. Per lui valgono le stesse condizioni di lavoro e gli stessi diritti dei lavoratori tedeschi». Già nel primo capitolo dell’accordo però erano chiariti i rapporti di forza esistenti tra le due nazioni. Spettava solo al governo della Repubblica federale tedesca, «quando avesse constatato una penuria di manodopera e avesse voluto rimediarvi attraverso l’assunzione di lavoratori italiani», di avviare le trattative con il governo italiano. Spettava, quindi, solo al governo tedesco stabilire e comunicare le professioni e il fabbisogno numerico di manodopera al governo italiano. Responsabili del reclutamento e del collocamento della manodopera erano da parte tedesca, la Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung(Ente federale per il lavoro e l’assicurazione contro la disoccupazione), da parte italiana, il Ministero del lavoro e della providenza Sociale. La Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung nominava una commissione (Deutsche Kommission in Italien) che operava in Italia grazie alla collaborazione del Ministero del lavoro, che le metteva a disposizione i locali necessari e le assicurava assistenza attraverso i suoi uffici provinciali. Il funzionamento del reclutamento era così definito: la Commissione tedesca raccoglieva le richieste dei datori di lavoro tedeschi e le comunicava al ministero del lavoro italiano. Il ministero del lavoro organizzava le preselezioni professionali e sanitarie dei lavoratori italiani nelle diverse province interessate. La Commissione tedesca compiva, invece, la selezione finale a cui i candidati dovevano presentarsi forniti del certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei rispettivi comuni di provenienza. L’esame professionale doveva provare il grado d’istruzione generale posseduto dal candidato (in assenza di documentazione scritta bisognava provarne le capacità di calcolo), la sua formazione professionale ed eventualmente le occupazioni svolte in precedenza all’estero. L’esame medico invece aveva lo scopo di accertare lo stato di salute generale e l’idoneità fisica del candidato in relazione al mestiere da svolgere nella Germania federale. Erano escluse dal reclutamento le persone affette da «malattie e imperfezioni che avrebbero potuto limitare o annullare l’idoneità al mestiere» o che avrebbero potuto «danneggiare la convivenza con altre persone» o, ancora, che avrebbero potuto «richiedere continue cure mediche». Nell’accordo erano elencate la tubercolosi polmonare, le malattie infettive o parassitarie contagiose, i disturbi dell’apparato digestivo «suscettibili di aggravamento per effetto del cambiamento del regime alimentare». Erano anche da escludere i lavoratori con «diminuzioni considerevoli della funzione degli organi della vista e dell’udito, carie e paradentosi necessitanti cure mediche o dentatura con insufficiente capacità di masticazione. Una volta passate le selezioni, i candidati potevano firmare il contratto di lavoro con cui venivano equiparati, per retribuzione e condizioni di lavoro, ai lavoratori tedeschi con pari qualifica. Il primo contingente di 1.389 lavoratori italiani arrivò nella Repubblica federale tedesca nell’aprile 1956. La Commissione tedesca iniziò, il 6 febbraio 1956, la sua attività di reclutamento presso il Centro di emigrazione di Milano, operativo dal 1946, che era con i Centri di emigrazione di Genova, Napoli e Messina, preposto alla convocazione, alla selezione e all’espatrio dei lavoratori e dei loro familiari, diretti all’estero. Le Commissioni straniere presenti nel Centro di emigrazione di Milano si distinguevano tra “permanenti” e “mobili”. Cinque erano le Commissioni permanenti e cioè quella del Belgio, della Francia, della Gran Bretagna, della Repubblica federale tedesca e del Cime (Comitato intergovernativo migrazioni europee, che assisteva i familiari dei lavoratori che emigravano nei paesi oltremare). Le commissioni mobili, invece, erano presenti in numero variabile: tra queste l’Olanda, la Svezia, il Brasile, il Sud-Africa, il Cile, la Colombia, l’Australia e la Rhodesia. Il Centro di emigrazione di Milano curava soprattutto l’emigrazione verso l’Europa e solo in maniera più ridotta le destinazioni extraeuropee. L’afflusso raggiungeva, nei periodi di primavera e autunno, cioè quando le richieste di lavoratori stagionali erano maggiori, i 2.000 arrivi giornalieri. Per la mancanza di spazio, i corridoi del Centro emigrazione si trasformavano in camerate in cui erano dislocati fino a 600 posti letto (la maggior parte dei letti in dotazione al Centro erano triposto). Dal 1946 al 1955 la media annua degli emigranti passati dal centro di Milano era stata di 58.283 persone, mentre nel 1956 l’affluenza era raddoppiata toccando i 105.671 assistiti. Nello stesso anno, la principale meta del flusso migratorio fu rappresentata dalla Franci, dove la principale categoria professionale ricoperta dagli italiani, era quella dei bieticoltori (24.148 lavoratori), che rappresentava anche, in assoluto, la principale occupazione dei lavoratori italiani emigrati. Seguivano i lavoratori edili con 20.263 e quelli appartenenti alla categoria “industria” con 13.483. I lavoratori diretti verso la Francia provenivano principalmente dal Veneto e dalla Puglia. Per il Belgio, dove erano richiesti principalmente minatori, i lavoratori italiani partirono soprattutto dall’Abruzzo e dalla Sicilia; per la Gran Bretagna, dove si richiedevano principalmente fornaciai, i lavoratori partirono dalla Campania. Per la Repubblica federale tedesca, dove la prima categoria a essere richiesta fu quella degli agricoli, si partì dalla Puglia, dal Friuli e dal Veneto. Per l’Olanda, dove si richiedevano soprattutto metalmeccanici, i lavoratori partirono dalla Sardegna. Per la Svizzera, dove erano richiesti principalmente gli agricoli, i lavoratori partirono dalla Basilicata. L’attività della Commissione tedesca presso il Centro di emigrazione di Milano, che si svolse dal 6 febbraio al 31 maggio 1956, permise il reclutamento di 3.545 lavoratori di cui 2.125 furono indirizzati verso l’agricoltura e 1.363 verso i settori dell’industria. Il primo giugno 1956 la Commissione tedesca in Italia si trasferì a Verona, dove fu creato un centro per ospitarla. Una commissione tedesca fu attiva anche presso il Centro di emigrazione di Napoli per il periodo compreso tra il 1960 e il 1966, quando, cioè, nella Germania federale si registrò un lungo periodo di crescita economica. Il Centro di emigrazione di Verona raggiunse nei primi anni ’60 una capacità ricettiva di 900 posti letto, organizzando un flusso migratorio che arrivò a superare le 1.000 persone al giorno.Dal 1956 al 1975 affluirono presso il Centro di Verona 338.147 persone di cui 302.755 furono i lavoratori ritenuti idonei per lavorare nella Germania federale. Il flusso migratorio proveniente principalmente dal Veneto, dalla Puglia e dalla Campania prese le caratteristiche dapprima di un flusso stagionale, diretto verso il settore agricolo e il settore edilizio del Niedersachsen, Baden-Württemberg e Nordrhein-Westfalen, mentre a partire dai primi anni ´60 il settore agricolo fu decisamente superato dal settore edilizio e meccanico. Dalla metà degli anni sessanta fino alla crisi petrolifera del 1973 il flusso emigratorio italiano si diresse verso il settore metalmeccanico assumendo, soprattutto negli stati federali del Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern e Hessen, le caratteristiche di un’emigrazione di lavoro permanente. Le caratteristiche del flusso migratorio furono determinate da un lato dall’andamento economico registrato nella Germania federale, dall’altro dall’entrata in vigore dei regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità economica europea. Nei periodi di alta congiuntura, i lavoratori selezionati dalla commissione tedesca di Verona erano principalmente lavoratori semplici diretti verso le industrie a ciclo permanente. Nei periodi di congiuntura negativa il numero dei lavoratori assunti nella Germania federale si riduceva in modo vertiginoso e si restringeva alle categorie di lavoratori specializzati assunti però con contratti stagionali. A fianco all’andamento economico tedesco, le caratteristiche del flusso migratorio furono determinate anche dalla progressiva entrata in vigore dei regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori nella Cee. Il trattato di Roma che sanciva «l’eliminazione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali», fu firmato nel 1957 ed entrò in vigore con il regolamento comunitario numero1.612 del 1968. La graduale applicazione dei decreti segnò la progressiva perdita d’importanza dei Centri di emigrazione. Il primo regolamento del 1961 sancì la libera circolazione per i lavoratori permanenti; il secondo regolamento del 1964 allargò il diritto di libera circolazione ai lavoratori stagionali ed ai frontalieri; il terzo regolamento del 1968 segnò la fine della priorità tedesca sul mercato della Germania federale e ai lavoratori tedeschi non fu più riservata la priorità di assunzione rispetto agli Italiani. L’emigrazione “assistita” fu progressivamente sostituita dall’emigrazione di lavoratori che, utilizzando sempre più spesso i canali informali offerti da parenti e amici già occupati nella Germania federale, vennero assunti direttamente dai datori di lavoro tedeschi. A fianco all’entrata in vigore dei regolamenti europei sulla libera circolazione, giocarono un ruolo importante nella definizione numerica dei flussi migratori le inefficienze e carenze del sistema di convocazione e selezione dei Centri stessi. Le inefficenze andavano palesandosi con la mancanza di compensazione fra le domande e le offerte di lavoro. Succedeva, infatti, che nel primo semestre di ogni anno, quando gli Uffici provinciali del lavoro segnalavano ai Centri di emigrazione la presenza di migliaia di lavoratori disponibili per l’espatrio, le Commissione tedesche disponevano solo di poche centinaia di contratti di lavoro. Molti lavoratori decidevano, così, di partire autonomamente per la Repubblica federale tedesca o di andare a lavorare in altre nazioni, principalmente la Svizzera. Per contro, nel secondo semestre la Commissione tedesca disponeva di un maggior numero di contratti di lavoro ma il numero dei lavoratori disposti a partire era decisamente ridotto. Nel 1968, per esempio, non trovarono collocamento nel primo semestre, a causa della mancanza di contratti, circa 8.000 lavoratori, mentre nella seconda parte dell’anno non si raggiunse invece il numero di lavoratori richiesto dalla Germania federale. Se i tempi della domanda e dell’offerta fossero coincisi, sarebbero espatriati il doppio dei lavoratori effettivamente partiti (10.489). Nel 1971, anno di alta congiuntura per l’economia tedesca, furono assunti attraverso il Centro di emigrazione di Verona solo 4.332 lavoratori mentre la quota dei lavoratori italiani registrata al 30 settembre nella Germania federale era di 407.900 persone. A partire dai primi anni settanta si andarono stabilizzando, grazie ai ricongiungimenti familiari, le comunità straniere residenti nella Germania federale. I lavoratori italiani erano passati da circa 220.000 del 1961 a circa 450.000 del 1973 e, alla stessa data, la comunità italiana consisteva di circa 620.000 persone. La comunità italiana seguiva quella turca composta da quasi 900.000 persone e quella jugoslava con circa 670.000. Nel 1974 e nel 1975 la crisi economica internazionale fece sentire i suoi effetti negativi soprattutto sul settore automobilistico tedesco e ciò si ripercosse anche sull’emigrazione italiana di lavoro. Nell’anno 1975 espatriarono dal Centro di Verona solo 229 lavoratori, toccando così la punta più bassa dell’emigrazione “assistita”, e circa 1.200 domande di espatrio rimasero insoddisfatte per mancanza di richieste da parte tedesca[. Se il numero dei lavoratori italiani si andò riducendo, quello della comunità italiana rimase con le sue 600.000 unità pressoché stabile dando vita alla comunità italiana più numerosa presente in Europa. (Grazia Prontera)
manodopera italiana nella Germania federale. Le trattative che condussero alla firma di tale accordo furono il frutto sia di esigenze nazionali, sia di istanze internazionali. Il flusso emigratorio che ne scaturì fu influenzato, a sua volta, dalla progressiva entrata in vigore della libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità economica europea, e dall’andamento economico registrato nelle nazioni coinvolte. La prima fase dell’emigrazione diretta verso la Germania federale fu definita “assistita” poiché pianificata a livello istituzionale e organizzata attraverso i Centri di emigrazione. La seconda fase dell’emigrazione fu caratterizzata della libera circolazione dei lavoratori e da forme di reclutamento indipendenti dalla mediazione dei Centri di emigrazione. I lavoratori italiani trovarono lavoro recandosi direttamente all’estero. Quest’articolo si concentra sullo studio dell’emigrazione “assistita” e, partendo dall’analisi del contesto politico-economico in cui l’accordo bilaterale fu sottoscritto, ne analizza la ricezione sulla stampa tedesca e italiana, soffermandosi, infine, sull’analisi dei flussi migratori gestiti dai Centri di emigrazione di Milano e Verona. In particolare, la storia del Centro di emigrazione di Verona e il ruolo giocato da questo nella definizione effettiva dei flussi migratori (provenienza regionale, quantità numerica, qualifiche professionali, e destinazione) rappresentano degli aspetti ancora poco approfonditi dell’emigrazione italiana verso la Germania federale. 1. Le premesse della firma dell’Accordo bilaterale italo-tedesco per il reclutamento e il collocamento della manodopera italiana nella Repubblica federale tedesca Le trattative che condussero alla firma dell’accordo bilaterale italo-tedesco si possono far risalire all’ottobre del 1953, quando il governo italiano chiese al governo tedesco di occupare lavoratori stagionali italiani a causa della diminuzione costante delle importazioni italiane da parte tedesca . La discussione sul saldo negativo dei pagamenti e sul reclutamento della manodopera caratterizzò i rapporti economici italo-tedeschi per tutto il 1954. L’apice si raggiunse a luglio, quando l’Italia, davanti alla reticenza tedesca, minacciò di «tornare ad una politica commerciale restrittiva se gli altri stati non fossero stati disposti ad un’attuazione liberale dell’assunzione di manodopera». Alla richiesta italiana, però, Bernhard Ehmke (dirigente del ministero federale del lavoro) rispose chiaramente che il bisogno di manodopera nella Repubblica federale tedesca poteva «ancora essere soddisfatto con quella locale» e rifiutava i «legami contrattuali» con l’Italia perché li riteneva prematuri. Le forti interdipendenze esistenti tra l’Italia e la Germania federale erano il frutto della ricostruzione economica post-bellica che ponendo le esportazioni al centro della rinascita economica europea, si basava sulla liberalizzazione del commercio estero. Il progetto di un’Europa economicamente integrata, progetto che, come afferma lo storico Charles Maier, era rimasto parzialmente irrealizzato, era stato il progetto degli Stati Uniti di Truman che, con il piano Marshall, aveva proposto alle nazioni europee un piano di crescita economica comune. Gli Stati Uniti pensavano all’Europa come a una “regione”, dove ogni nazione avrebbe dovuto ricoprire ruoli funzionalmente interdipendenti dettati dalla propria storia e dalle proprie risorse. Il compito degli Stati Uniti sarebbe stato quello di attivare un meccanismo «self help adatto a rimettere in moto la spina al recupero di produttività». La crescita economica avrebbe garantito la stabilità politica e la pace sociale dell’Europa e sarebbe stata l’unico antidoto sia contro i partiti comunisti, forti soprattutto in Francia e in Italia, sia contro il pericolo sovietico. Carlo Spagnolo sottolinea il valore principalmente politico assunto dagli aiuti economici americani affermando che «gli aiuti americani furono politicamente decisivi alla ricostruzione europea». Gli Stati Uniti individuavano, nel recupero politico ed economico della Germania occidentale, la condizione necessaria e indispensabile per la rinascita economica europea, e contemporaneamente ne facevano il baluardo della loro politica di contenimento. Se da un lato, infatti, alla Germania federale con il suo carbone e con le sue capacità tecniche veniva riconosciuto il ruolo trainante per la ripresa economica del continente, dall’altro lo scivolamento della Germania occidentale nell’area comunista avrebbe potuto significare la perdita dell’Europa. Nel 1948 gli Stati Uniti crearono l’Organizzazione europea di cooperazione economica (Oece) per ripartire gli aiuti del piano Marshall tra gli stati firmatari. L’Oece ebbe un carattere prevalentemente tecnico e di coordinamento e non soprannazionale, come invece avrebbero voluto gli americani. Nazioni come la Francia e la Gran Bretagna, infatti, vi si erano opposte per il timore di perdere la propria sovranità. Il principio della ricostruzione della Germania federale venne comunque riconosciuto da tutti gli stati firmatari a condizione che esso fosse controllato per evitare conseguenze dannose all’economia e alla finanza degli altri paesi. Da parte sua la Germania occidentale, con sovranità limitata fino al 1955 e soggetta a uno stazionamento di forze d’occupazione, si impegnava in una ricostruzione ed espansione industriale dichiarando esplicitamente il proprio «fervido desiderio di servire la causa europea». Nel settembre del 1949 era nata la Repubblica federale tedesca e Konrad Adenauer, il suo primo Bundeskanzler, seppe leggere le opportunità politiche insite nell’idea di Europa e far riguadagnare alla Repubblica federale tedesca la pari dignità con gli altri paesi rendendola così idonea alla «collaborazione all’interno degli organismi europei». L’Italia nel 1949 aderì all’Oece e intraprese la strada della liberalizzazione progressiva della sua economia. Per l’Italia, infatti, povera di materie prime, lo sviluppo industriale significava, prima di tutto lo sviluppo delle importazioni. Uno sviluppo delle importazioni avrebbe comportato una pari crescita delle esportazioni e avrebbe necessitato di un clima di aperture commerciali. L’Italia nel 1954 aprì, quindi, il proprio mercato alle importazioni dai paesi Oece abolendone fino al 99% le limitazioni quantitative. Per giocare un ruolo nell’intreccio di collaborazioni internazionali, l’Italia aveva puntato sulla stabilità monetaria pagando, però, il costo di «povertà e vulnerabilità interna». Lo sviluppo di un’industria competitiva sul piano internazionale, localizzato principalmente nel triangolo industriale di Milano, Torino e Genova e orientato verso l’aumento della produttività e dell’esportazione lasciava, infatti, irrisolto il problema del riassorbimento della disoccupazione. La domanda proveniente dai paesi europei più industrializzati, infatti, si orientava verso i consumi di massa e di lusso e quindi solo verso specifici settori della produzione italiana come l’industria automobilistica, i prodotti petroliferi, alcuni prodotti tessili, le calzature e la gomma. Secondo Graziani, furono proprio le esportazioni a mettere in moto un «circolo vizioso di squilibri e di disuguaglianze», prime fra tutte le emigrazioni esterne e interne e il sottosviluppo del mezzogiorno. L’Italia di Alcide De Gasperi affrontò il problema della disoccupazione aprendo strade istituzionali all’emigrazione stessa a cui neanche il Sindacato unitario dei lavoratori, «trincerandosi dietro la dura necessità del momento», si era realmente opposto. De Gasperi intendeva trovare sbocchi occupazionali per la manodopera italiana nelle nazioni aderenti all’Oece «in un’ottica di scambi di concessioni commerciali reciproche». Se da un lato gli emigranti avrebbero contribuito a sanare il bilancio statale, dall’altro l’emigrazione indeboliva i contrasti sociali interni permettendo il consolidamento politico della Democrazia cristiana. Che l’emigrazione fosse una voce fondamentale nel capitolo della bilancia dei pagamenti con l’estero, lo dimostra il primo piano per lo sviluppo dell’economia presentato dall’Italia all’Oece per il quadriennio 1948-49/1952-53 dove venne prevista un’emigrazione netta di 823.000 unità, di cui 364.000 dirette verso l’Europa e 468.000 dirette verso gli altri continenti; tutto ciò avrebbe prodotto, in rimesse, una quota di 205 milioni di dollari, pari al 10% delle importazioni. Al temine dello stesso periodo, però, ci si aspettava di registrare ancora 1.188.000 disoccupati, ai quali si sarebbero dovuti aggiungere, secondo la Direzione per l’emigrazione del ministero degli esteri, altri due milioni di sottoccupati. La Germania di Adenauer, invece, per garantire la stabilità sociale e politica interna si era prefissata l’obiettivo della piena occupazione. D’altronde, come osserva Christoph Buchheim, fu proprio «l’impiego della forza lavoro […] di milioni di disoccupati e sottoccupati, tra cui molti profughi e rifugiati», a essere il motore della crescita economica. Non c’era da stupirsi se, ancora all’inizio del 1954, il Ministro del lavoro e i sindacati tedeschi si opponessero alle trattative con l’Italia per il collocamento di lavoratori italiani nella Repubblica Federale Tedesca, richiamando l’attenzione sugli alti tassi di disoccupazione esistenti nel settore agricolo. D’altra parte, però, l’Italia era un’importantissima importatrice di carbone e i maggiori introiti delle esportazioni tedesche erano fatturati nel commercio di prodotti dell’industria meccanica, metallurgica e chimica, proprio con l’Italia. Così, all’inizio del 1955, la Germania federale propose all’Italia un accordo “preventivo” sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani, un accordo che sarebbe entrato in vigore solo nel caso in cui la Germania federale ne avesse avuto bisogno, e cioè solo quando la disoccupazione tedesca fosse stata completamente riassorbita. All’inizio dello stesso anno, l’Italia aveva presentato all’Oece il piano Vanoni in cui per il decennio successivo si prevedeva un’emigrazione di 800.000 lavoratori, ritenuta indispensabile per garantire la crescita economica e riequilibrare il grave divario esistente tra nord e sud.. Nel settembre 1955 la disoccupazione tedesca toccò il 2,7% e a novembre il ministero del lavoro tedesco stimò a 800.000 il «bisogno aggiuntivo di manodopera per il 1956». La firma dell’accordo italo-tedesco divenne imminente e fu firmato a Roma, il 20 dicembre dello stesso anno, dal ministro del lavoro Anton Storch, dal ministro degli esteri Clemens von Brentano e, da parte italiana, dal ministro degli esteri Gaetano Martino. I problemi lasciati fino a quel momento sospesi riguardanti le questioni sul sussidio di disoccupazione per i lavoratori stagionali e il pagamento degli assegni familiari, furono così risolti: «Il sussidio di disoccupazione non sarebbe stato trasferito in Italia, ma la Repubblica federale tedesca si impegnava a pagare gli assegni familiari anche alle famiglie che rimanevano in Italia». 2. La ricezione della firma dell’accordo sulla stampa tedesca e italiana La firma dell’accordo bilaterale italo-tedesco fu riportata su tutti i maggiori giornali italiani e tedeschi, ma la sua trattazione differiva notevolmente. Se a Roma il reclutamento e il collocamento venivano presentati come imminenti e numericamente quantificabili, a Bonn, invece, venivano presentati come provvedimenti precauzionali, la cui applicazione era tutt’altro che incombente. La diversa interpretazione era dovuta al fatto che nell’accordo appena firmato non erano stabilite né la data precisa, né la quota dei lavoratori italiani da occupare nella Repubblica federale tedesca. La polemica sulla stampa tedesca fu innescata dalle affermazioni entusiastiche rilasciate a Roma dal Ministro del lavoro tedesco e riportate sul «Frankfurter Rundschau», giornale indipendente che nel 1955 usciva con 123.000 copie giornaliere. Il ministro del lavoro Storch aveva affermato, infatti, che «nell’accordo non è fissata nessuna quota dei lavoratori italiani perché la Repubblica federale tedesca ne vuole prendere il più possibile», e aveva aggiunto che se nello stesso anno i lavoratori italiani presenti nella Germania federale erano più di 50.000, l’anno seguente sarebbero diventati «molti, molti di più». Da Bonn, però, Maximilian Sauerborn, Staatssekretär vom Bundesarbeitsministerium (sottosegretario al lavoro), rilasciava in conferenza stampa nel pomeriggio dello stesso 20 dicembre una dichiarazione dove affermava che il reclutamento di lavoratori stagionali italiani non si pone fino a quando esista la disponibilità di manodopera idonea tedesca; ed è questo il motivo per cui l’accordo non fissa la quota della manodopera da collocare nella Germania federale. La mole e il tipo del reclutamento saranno stabiliti dai due Governi in base alla natura del bisogno da coprire nella Repubblica federale tedesca. Alle affermazioni fatte dal ministro del lavoro tedesco a Roma avevano fatto immediatamente da contraltare, con l’effetto di ridimensionarle, quelle del suo sottosegretario a Bonn, che, più difensive, andavano a rassicurare quanti temevano un arrivo illimitato di italiani e una perdita di controllo sul proprio mercato del lavoro. Queste paure, infatti, avevano fatto sì che il giornale a maggior tiratura - il «Ruhr-Nachrichten», quotidiano di orientamento cristiano democratico con una tiratura giornaliera di 142.000 copie - riportasse la notizia dell’accordo siglato a Roma sotto il titolo scritto a caratteri cubitali: Keine Italiener für den Bergbau (nessun italiano per le miniere) quasi a voler testimoniare una battaglia vinta. In apertura l’articolo riportava che gli italiani, come fermamente voluto dall’industria estrattiva (tanto dai datori di lavoro, quanto dal sindacato) non sarebbero stati collocati nell’industria mineraria tedesca. L’attenzione, poi, veniva tutta riposta sulla priorità assoluta che i lavoratori tedeschi avrebero continuato a mantenere sul loro mercato del lavoro. L’articolo sottolineava, infatti, che sarebbero stati soprattutto i lavoratori non qualificati a essere assunti nella Germania federale e solo in seguito a una selezione professionale e sanitaria svolta da una commissione tedesca. L’articolo, infine, rassicurava i lavoratori tedeschi che l’assunzione di lavoratori italiani non li avrebbe in alcun modo danneggiati. I lavoratori italiani sarebbero stati equiparati a quelli tedeschi per stipendio e condizioni contrattuali. Neanche nel tanto problematico settore delle abitazioni gli italiani avrebbero costituito, una minaccia per i tedeschi, poichè, dichiarava lo stesso sottosegretario Sauerborn, «noi non vogliamo che i nuovi appartamenti costruiti per i rifugiati e gli sfollati possano essere adesso presi in considerazione per gli italiani e che i tedeschi ne rimangano esclusi». Per questo sarebbero state le imprese a occuparsi degli alloggi per i lavoratori italiani e non lo stato. L’articolo, quindi, metteva bene in evidenza come fosse la Germania federale a modellare l’accordo bilaterale a suo vantaggio nell’interesse della propria produzione e dei propri lavoratori. Il «Frankfurter Rundschau» intitolava Firmato il contratto di lavoro Roma-Bonn e nel sottotitolo scriveva: «Quota della manodopera italiana non limitata». Il giornale si poneva in modo più aperto rispetto all’assunzione dei lavoratori italiani, riportava le affermazioni “romane” del ministro del lavoro e dava una sfumatura diversa alle affermazioni di Sauerborn riportando che il ricorso a manodopera straniera per il 1956 non può più essere evitato. L’anno passato l’occupazione è cresciuta di un milione di unità. In futuro, però, non ci potremo aspettare risultati così positivi perché tra i disoccupati si trovano adesso solo relativamente basse riserve di manodopera. Il «Frankfurter Rundschau», quindi, metteva in evidenza l’inevitabilità della scelta di occupare manodopera straniera per non ostacolare la crescita economica tedesca. Estremamente interessante in relazione alla previsione della quota degli italiani da assumere nella Germania federale è l’articolo del «Tagesspiegel», giornale indipendente stampato a Berlino ovest con tiratura giornaliera di 90.000 copie. L’articolo, dal titolo Lavoratori italiani verso la Germania, dava come imminente l’arrivo degli italiani quantificando il contingente e riportando i settori economici interessati: L’accordo firmato a Roma prevede un’occupazione annuale tra gli 80.000 e i 100.000 italiani. Gli italiani saranno selezionati e impiegati nell’agricoltura, nell’edilizia e nella tecnica. I lavoratori che durante i nove mesi del contratto avranno imparato il tedesco potranno in seguito lavorare anche nelle miniere. [...] I primi italiani dovrebbero arrivare in primavera. L’articolo si rifaceva alle fonti romane dell’agenzia d’informazione statunitense United press, e metteva ulteriormente in evidenza, circa l’imminenza e la quota dei lavoratori da occupare nella Germania federale, la differenza sostanziale tra le notizie provenienti da Roma e quelle provenienti da Bonn. Nell’articolo del «Tagesspiegel» le affermazioni di Sauerborn assumono solo il tono di rassicurazioni marginali: «il ricorso alla manodopera straniera sarà nei prossimi anni inevitabile. Ma anche in futuro saranno prima i tedeschi ad essere assunti». L’«Industriekurier», giornale degli industriali tedeschi, che usciva con una tiratura di 22.000 copie giornaliere, quantificava il fabbisogno di manodopera italiana per il settore agricolo in 10.000 lavoratori e ne sollecitava una immediata assunzione. Lo stesso ministro del lavoro Storch, di ritorno dall’Italia, sottolineò il valore politico ed economico assunto dell’accordo italo-tedesco per la Germania federale: Questo accordo è per la Germania un modello e una prova allo stesso tempo. Se dovesse funzionare, si potrebbe allargare alla Grecia, alla Spagna e alle zone di crisi nel vicino est e ai paesi che si affacciano al Mediterraneo. Per la Germania deve essere motivo di soddisfazione se oggi, nonostante il continuo afflusso dall’Est, può già pensare a un tale allargamento perché solo due o tre anni fa il problema della disoccupazione sembrava irrisolvibile. Al ministro del lavoro faceva eco l’articolo pubblicato sul «Bullettin des Presse und Informationsamtes der Bundesregierung» (bollettino parlamentare) del gennaio 1956, in cui si leggeva: Nell’estate 1955 la crescita economica nella Repubblica federale tedesca esprimeva un’incredibile alta congiuntura. Essa riguardava non solo l’edilizia, l’industria delle materie prime e i beni d’investimento, ma anche l’industria dei beni di consumo. La crescita è stata così forte che il numero degli occupati è arrivato a 17,8 milioni, 4,2 milioni in più del 1949, e il numero dei disoccupati è diminuito a meno di mezzo milione riuscendo a occupare disoccupati, perseguitati, profughi, reduci, e invalidi Il ministro quindi rispondeva alle critiche mosse dal partito di opposizione Spd (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) che richiamava l’attenzione sulla disoccupazione di lungo periodo presente nelle zone periferiche e sul continuo afflusso dall’est Europa, affermando che l’economia era in una fase di crescita e l’assenza di manodopera straniera, sia semplice e sia specializzata, l’avrebbe potuta mettere in crisi. In Italia gli articoli pubblicati sulla firma dell’accordo italo-tedesco assunsero un tono ben diverso. D’altronde, se la Repubblica federale tedesca aveva posto la piena occupazione al centro delle sue scelte politiche ed economiche, l’Italia vedeva nell’emigrazione la via per rimettere in moto la sua economia. Questa convinzione era condivisa da tutti i partiti politici italiani oltre che dal mondo economico. “Emigrazione” era, per la stampa italiana, l’espressione che riassumeva il senso dell’accordo italo-tedesco, mentre la stessa espressione non trovava spazio sulla stampa tedesca. La Germania federale, infatti, aveva presentato l’occupazione dei lavoratori italiani come un esperimento legato alla positiva congiuntura economica, ma era ben lontana dal presentarla come l’inizio dell’immigrazione italiana nella Germania federale. Il «Corriere della Sera», principale quotidiano nazionale, riportava la notizia della firma dell’accordo avvenuta nel Salone della Vittoria di Palazzo Chigi, intitolando: Firmato a Roma l’accordo per i lavoratori italiani in Germania. Nel sottotitolo si riassumevano le principali informazioni: «I primi scaglioni apparterranno all’agricoltura e all’edilizia. Identità di trattamento, compresi gli assegni familiari, con gli operai tedeschi». L’articolo metteva in risalto l’importanza dell’intesa raggiunta sugli assegni familiari. Se le caratteristiche dell’accordo italo-tedesco erano, infatti, simili a quelle degli «accordi di emigrazione conclusi dall’Italia in questo dopoguerra», la novità principale consisteva «nell’accettazione, da parte tedesca, del pagamento degli assegni familiari anche quando la famiglia rimane in Italia». Gli assegni familiari erano presentati come la prova di un’effettiva uguaglianza di trattamento tra i lavoratori italiani e tedeschi e il «Corriere della Sera» riportava, al riguardo, le affermazioni del ministro del lavoro tedesco: «La maggior preoccupazione dell’accordo è stata quella di poter garantire ai lavoratori italiani che si recheranno in Germania ottime condizioni di lavoro e di sistemazione». Secondo l’accordo italo-tedesco, però, proprio la “sistemazione” dei lavoratori italiani era lasciata alle singole imprese e lo stato tedesco dettava solo delle norme molto generali sulla condizione degli alloggi. Il più delle volte le imprese tedesche misero a disposizione dei lavoratori italiani delle baracche di legno. L’articolo si concludeva riportando il comunicato di Palazzo Chigi sui tempi e le caratteristiche dell’occupazione italiana nella Germania federale: «Si ha motivo di ritenere che con l’inizio della primavera si possa realizzare praticamente una prima emigrazione di lavoratori italiani». I settori produttivi interessati erano quelli dell’agricoltura, dell’edilizia e della meccanica. L’accesso dei lavoratori italiani nelle miniere tedesche rimaneva, per il momento, chiuso e la motivazione apportata era la mancanza della conoscenza della lingua tedesca, «essendo prescritto che tutti i minatori debbano essere in grado di leggere e intendere le ordinanze in lingua tedesca per la sicurezza sul lavoro». «L’Unità», organo del Partito comunista italiano, intitolava: Firmato ieri l’accordo per l’emigrazione in Germania. Nell’articolo si metteva in evidenza il disappunto per la mancanza di una quota prestabilita di lavoratori da inviare all’estero e si affermava che «i termini dell’accordo sono estremamente vaghi». Venivano, così, deluse le aspettative di una corposa assunzione di manodopera italiana da parte tedesca. L’articolo continuava con il comunicato di Palazzo Chigi sui settori maggiormente interessati all’emigrazione e l’accordo sugli assegni familiari. Il «Giornale d’Italia», quotidiano romano d’ispirazione liberale, intitolava: Il significato dell’accordo emigratorio italo-tedesco. Nell’articolo si poneva l’accento sul valore politico dell’accordo bilaterale: Si prevede che a primavera potranno essere chiamati in Germania diecimila lavoratori, una cifra destinata a dilatarsi, se le circostanze aiuteranno. Perché in questo problema tutto è subordinato, connesso, a ragioni di alto interesse politico. Da un lato l’accordo era interpretato come «una prova della solidarietà economica e sociale» che la Germania occidentale offriva all’Italia, dall’altro lato, chiarito che l’accordo era funzionale anche alla crescita industriale tedesca, si sottolineava che era stato firmato in un particolare momento storico in cui «enormi interrogativi si levano nell’orizzonte politico», riferendosi alle questioni relative a «Unione Occidentale Europea, Alleanza atlantica, riunificazione tedesca»[41]. Lo stesso giornale, il giorno seguente, intitolava: Firma dell’accordo emigratorio italo-tedesco a Palazzo Chig. L’articolo informava che la delegazione tedesca aveva incontrato la delegazione italiana, prima della firma dell’accordo, per definire le questioni rimaste sospese relative agli assegni familiari e alla previdenza sociale. Nell’articolo si riportava che la Germania federale aveva accettato di pagare gli assegni familiari, ma non si dava notizia del rifiuto tedesco circa il pagamento della disoccupazione ai lavoratori italiani e ciò, presumibilmente, per non oscurare in alcun modo il successo della politica estera italiana. 3. Le caratteristiche dell’accordo bilaterale italo-tedesco e l’emigrazione “assistita” attraverso i Centri di emigrazione di Milano e Verona L’accordo bilaterale siglato con la Germania federale fu per l’Italia l’ultimo di tal genere mentre per la Germania federale fu il primo. L’Italia, infatti, attraverso la Direzione generale dell’emigrazione facente capo al ministero degli esteri, aveva firmato tra il 1946 e il 1955 accordi bilaterali con quattordici nazioni. La Germania federale, tra il 1955 ed il 1968, avrebbe firmato otto accordi bilaterali per il reclutamento di manodopera straniera. L’accordo bilaterale sottoscritto dall’Italia e dalla Germania federale si apriva con la seguente dichiarazione: Nel desiderio di approfondire e di stringere sempre più, nell’interesse reciproco, le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarietà europea, nonché di consolidare i legami d’amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera e un pieno sfruttamento delle possibilità di produzione, nella convinzione che questi sforzi servano l’interesse comune dei loro popoli e promuovano il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo. Il preambolo serviva a mostrare il comune interesse di entrambe le nazioni all’accordo e a metterne in evidenza il comune sentire europeo. Così il ministro del lavoro tedesco ne sottolineava il carattere di novità e di rottura con il passato: «l’italiano, che in base all’accordo bilaterale, viene in Germania, sa che lui non è un lavoratore dai diritti inferiori. Per lui valgono le stesse condizioni di lavoro e gli stessi diritti dei lavoratori tedeschi». Già nel primo capitolo dell’accordo però erano chiariti i rapporti di forza esistenti tra le due nazioni. Spettava solo al governo della Repubblica federale tedesca, «quando avesse constatato una penuria di manodopera e avesse voluto rimediarvi attraverso l’assunzione di lavoratori italiani», di avviare le trattative con il governo italiano. Spettava, quindi, solo al governo tedesco stabilire e comunicare le professioni e il fabbisogno numerico di manodopera al governo italiano. Responsabili del reclutamento e del collocamento della manodopera erano da parte tedesca, la Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung(Ente federale per il lavoro e l’assicurazione contro la disoccupazione), da parte italiana, il Ministero del lavoro e della providenza Sociale. La Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung nominava una commissione (Deutsche Kommission in Italien) che operava in Italia grazie alla collaborazione del Ministero del lavoro, che le metteva a disposizione i locali necessari e le assicurava assistenza attraverso i suoi uffici provinciali. Il funzionamento del reclutamento era così definito: la Commissione tedesca raccoglieva le richieste dei datori di lavoro tedeschi e le comunicava al ministero del lavoro italiano. Il ministero del lavoro organizzava le preselezioni professionali e sanitarie dei lavoratori italiani nelle diverse province interessate. La Commissione tedesca compiva, invece, la selezione finale a cui i candidati dovevano presentarsi forniti del certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei rispettivi comuni di provenienza. L’esame professionale doveva provare il grado d’istruzione generale posseduto dal candidato (in assenza di documentazione scritta bisognava provarne le capacità di calcolo), la sua formazione professionale ed eventualmente le occupazioni svolte in precedenza all’estero. L’esame medico invece aveva lo scopo di accertare lo stato di salute generale e l’idoneità fisica del candidato in relazione al mestiere da svolgere nella Germania federale. Erano escluse dal reclutamento le persone affette da «malattie e imperfezioni che avrebbero potuto limitare o annullare l’idoneità al mestiere» o che avrebbero potuto «danneggiare la convivenza con altre persone» o, ancora, che avrebbero potuto «richiedere continue cure mediche». Nell’accordo erano elencate la tubercolosi polmonare, le malattie infettive o parassitarie contagiose, i disturbi dell’apparato digestivo «suscettibili di aggravamento per effetto del cambiamento del regime alimentare». Erano anche da escludere i lavoratori con «diminuzioni considerevoli della funzione degli organi della vista e dell’udito, carie e paradentosi necessitanti cure mediche o dentatura con insufficiente capacità di masticazione. Una volta passate le selezioni, i candidati potevano firmare il contratto di lavoro con cui venivano equiparati, per retribuzione e condizioni di lavoro, ai lavoratori tedeschi con pari qualifica. Il primo contingente di 1.389 lavoratori italiani arrivò nella Repubblica federale tedesca nell’aprile 1956. La Commissione tedesca iniziò, il 6 febbraio 1956, la sua attività di reclutamento presso il Centro di emigrazione di Milano, operativo dal 1946, che era con i Centri di emigrazione di Genova, Napoli e Messina, preposto alla convocazione, alla selezione e all’espatrio dei lavoratori e dei loro familiari, diretti all’estero. Le Commissioni straniere presenti nel Centro di emigrazione di Milano si distinguevano tra “permanenti” e “mobili”. Cinque erano le Commissioni permanenti e cioè quella del Belgio, della Francia, della Gran Bretagna, della Repubblica federale tedesca e del Cime (Comitato intergovernativo migrazioni europee, che assisteva i familiari dei lavoratori che emigravano nei paesi oltremare). Le commissioni mobili, invece, erano presenti in numero variabile: tra queste l’Olanda, la Svezia, il Brasile, il Sud-Africa, il Cile, la Colombia, l’Australia e la Rhodesia. Il Centro di emigrazione di Milano curava soprattutto l’emigrazione verso l’Europa e solo in maniera più ridotta le destinazioni extraeuropee. L’afflusso raggiungeva, nei periodi di primavera e autunno, cioè quando le richieste di lavoratori stagionali erano maggiori, i 2.000 arrivi giornalieri. Per la mancanza di spazio, i corridoi del Centro emigrazione si trasformavano in camerate in cui erano dislocati fino a 600 posti letto (la maggior parte dei letti in dotazione al Centro erano triposto). Dal 1946 al 1955 la media annua degli emigranti passati dal centro di Milano era stata di 58.283 persone, mentre nel 1956 l’affluenza era raddoppiata toccando i 105.671 assistiti. Nello stesso anno, la principale meta del flusso migratorio fu rappresentata dalla Franci, dove la principale categoria professionale ricoperta dagli italiani, era quella dei bieticoltori (24.148 lavoratori), che rappresentava anche, in assoluto, la principale occupazione dei lavoratori italiani emigrati. Seguivano i lavoratori edili con 20.263 e quelli appartenenti alla categoria “industria” con 13.483. I lavoratori diretti verso la Francia provenivano principalmente dal Veneto e dalla Puglia. Per il Belgio, dove erano richiesti principalmente minatori, i lavoratori italiani partirono soprattutto dall’Abruzzo e dalla Sicilia; per la Gran Bretagna, dove si richiedevano principalmente fornaciai, i lavoratori partirono dalla Campania. Per la Repubblica federale tedesca, dove la prima categoria a essere richiesta fu quella degli agricoli, si partì dalla Puglia, dal Friuli e dal Veneto. Per l’Olanda, dove si richiedevano soprattutto metalmeccanici, i lavoratori partirono dalla Sardegna. Per la Svizzera, dove erano richiesti principalmente gli agricoli, i lavoratori partirono dalla Basilicata. L’attività della Commissione tedesca presso il Centro di emigrazione di Milano, che si svolse dal 6 febbraio al 31 maggio 1956, permise il reclutamento di 3.545 lavoratori di cui 2.125 furono indirizzati verso l’agricoltura e 1.363 verso i settori dell’industria. Il primo giugno 1956 la Commissione tedesca in Italia si trasferì a Verona, dove fu creato un centro per ospitarla. Una commissione tedesca fu attiva anche presso il Centro di emigrazione di Napoli per il periodo compreso tra il 1960 e il 1966, quando, cioè, nella Germania federale si registrò un lungo periodo di crescita economica. Il Centro di emigrazione di Verona raggiunse nei primi anni ’60 una capacità ricettiva di 900 posti letto, organizzando un flusso migratorio che arrivò a superare le 1.000 persone al giorno.Dal 1956 al 1975 affluirono presso il Centro di Verona 338.147 persone di cui 302.755 furono i lavoratori ritenuti idonei per lavorare nella Germania federale. Il flusso migratorio proveniente principalmente dal Veneto, dalla Puglia e dalla Campania prese le caratteristiche dapprima di un flusso stagionale, diretto verso il settore agricolo e il settore edilizio del Niedersachsen, Baden-Württemberg e Nordrhein-Westfalen, mentre a partire dai primi anni ´60 il settore agricolo fu decisamente superato dal settore edilizio e meccanico. Dalla metà degli anni sessanta fino alla crisi petrolifera del 1973 il flusso emigratorio italiano si diresse verso il settore metalmeccanico assumendo, soprattutto negli stati federali del Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern e Hessen, le caratteristiche di un’emigrazione di lavoro permanente. Le caratteristiche del flusso migratorio furono determinate da un lato dall’andamento economico registrato nella Germania federale, dall’altro dall’entrata in vigore dei regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità economica europea. Nei periodi di alta congiuntura, i lavoratori selezionati dalla commissione tedesca di Verona erano principalmente lavoratori semplici diretti verso le industrie a ciclo permanente. Nei periodi di congiuntura negativa il numero dei lavoratori assunti nella Germania federale si riduceva in modo vertiginoso e si restringeva alle categorie di lavoratori specializzati assunti però con contratti stagionali. A fianco all’andamento economico tedesco, le caratteristiche del flusso migratorio furono determinate anche dalla progressiva entrata in vigore dei regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori nella Cee. Il trattato di Roma che sanciva «l’eliminazione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali», fu firmato nel 1957 ed entrò in vigore con il regolamento comunitario numero1.612 del 1968. La graduale applicazione dei decreti segnò la progressiva perdita d’importanza dei Centri di emigrazione. Il primo regolamento del 1961 sancì la libera circolazione per i lavoratori permanenti; il secondo regolamento del 1964 allargò il diritto di libera circolazione ai lavoratori stagionali ed ai frontalieri; il terzo regolamento del 1968 segnò la fine della priorità tedesca sul mercato della Germania federale e ai lavoratori tedeschi non fu più riservata la priorità di assunzione rispetto agli Italiani. L’emigrazione “assistita” fu progressivamente sostituita dall’emigrazione di lavoratori che, utilizzando sempre più spesso i canali informali offerti da parenti e amici già occupati nella Germania federale, vennero assunti direttamente dai datori di lavoro tedeschi. A fianco all’entrata in vigore dei regolamenti europei sulla libera circolazione, giocarono un ruolo importante nella definizione numerica dei flussi migratori le inefficienze e carenze del sistema di convocazione e selezione dei Centri stessi. Le inefficenze andavano palesandosi con la mancanza di compensazione fra le domande e le offerte di lavoro. Succedeva, infatti, che nel primo semestre di ogni anno, quando gli Uffici provinciali del lavoro segnalavano ai Centri di emigrazione la presenza di migliaia di lavoratori disponibili per l’espatrio, le Commissione tedesche disponevano solo di poche centinaia di contratti di lavoro. Molti lavoratori decidevano, così, di partire autonomamente per la Repubblica federale tedesca o di andare a lavorare in altre nazioni, principalmente la Svizzera. Per contro, nel secondo semestre la Commissione tedesca disponeva di un maggior numero di contratti di lavoro ma il numero dei lavoratori disposti a partire era decisamente ridotto. Nel 1968, per esempio, non trovarono collocamento nel primo semestre, a causa della mancanza di contratti, circa 8.000 lavoratori, mentre nella seconda parte dell’anno non si raggiunse invece il numero di lavoratori richiesto dalla Germania federale. Se i tempi della domanda e dell’offerta fossero coincisi, sarebbero espatriati il doppio dei lavoratori effettivamente partiti (10.489). Nel 1971, anno di alta congiuntura per l’economia tedesca, furono assunti attraverso il Centro di emigrazione di Verona solo 4.332 lavoratori mentre la quota dei lavoratori italiani registrata al 30 settembre nella Germania federale era di 407.900 persone. A partire dai primi anni settanta si andarono stabilizzando, grazie ai ricongiungimenti familiari, le comunità straniere residenti nella Germania federale. I lavoratori italiani erano passati da circa 220.000 del 1961 a circa 450.000 del 1973 e, alla stessa data, la comunità italiana consisteva di circa 620.000 persone. La comunità italiana seguiva quella turca composta da quasi 900.000 persone e quella jugoslava con circa 670.000. Nel 1974 e nel 1975 la crisi economica internazionale fece sentire i suoi effetti negativi soprattutto sul settore automobilistico tedesco e ciò si ripercosse anche sull’emigrazione italiana di lavoro. Nell’anno 1975 espatriarono dal Centro di Verona solo 229 lavoratori, toccando così la punta più bassa dell’emigrazione “assistita”, e circa 1.200 domande di espatrio rimasero insoddisfatte per mancanza di richieste da parte tedesca[. Se il numero dei lavoratori italiani si andò riducendo, quello della comunità italiana rimase con le sue 600.000 unità pressoché stabile dando vita alla comunità italiana più numerosa presente in Europa. (Grazia Prontera)