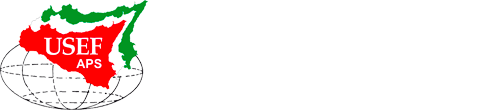Nell’ambito della discussione sulla crisi europea (e mondiale), la questione delle migrazioni viene tenuta abilmente ai margini dell’analisi e dell’approfondimento, pur avendo uno spazio consistente nella narrazione mediatica,
Nell’ambito della discussione sulla crisi europea (e mondiale), la questione delle migrazioni viene tenuta abilmente ai margini dell’analisi e dell’approfondimento, pur avendo uno spazio consistente nella narrazione mediatica,
ma si tratta di uno spazio dislocato sul crinale dei diritti umani, che in quanto diritti universali, non hanno, apparentemente, nulla a che fare con le fatidiche evoluzioni della crisi.
Invece le dinamiche migratorie costituiscono, insieme alle crisi climatiche, la più significativa conferma empirica che le crepe del modello di sviluppo e della sua cornice istituzionale sono ormai così larghe che le tante pezze messe a rattoppo e ad argine dello sgretolamento, non fanno altro che approfondirne le linee di frattura e gli squilibri.
Sulla questione delle migrazioni internazionali dal terzo mondo, in quanto effetto diretto delle ragioni di scambio nord-sud con tutti gli annessi e connessi di sfruttamento di popoli e delle risorse dei paesi di origine dei migranti, da quelle minerarie, al land grabbing per la produzione di alimenti, fino al commercio di armi e all’azione mirata allo scatenamento di conflitti locali, in questi ultimi decenni si è già scritto e parlato a lungo. I report dei diversi forum sociali mondiali costituiscono da questo punto di vista un resoconto puntuale dei processi in corso e delle nuove dinamiche neocoloniali che contemplano, solo in parte e solo come estrema ratio (peraltro sempre più frequentata), la conquista e il controllo statuale dei territori coloniali.
Così che i 232 milioni di migranti che si muovono sul pianeta, di cui oltre 150 milioni di lavoratori, non sono altro che il prodotto di quanto, da tempo, il capitale nord americano ed europeo e i rispettivi governi vanno facendo ad ottimizzazione dei conflitti (o degli accordi) inter-imperialisti e di quelli nascenti tra antiche e nuove potenze che si affacciano alla storia del XXI secolo. Quasi il 50% di essi si concentra infatti in Nord-America e Europa. Mentre la maggior percentuale di lavoratori migranti rispetto al totale dei lavoratori è nei paesi arabi. (Rapporto ILO: Global Estimates on Migrant Workers – 2015)
Invece per quanto riguarda i profughi, solo la punta dell’iceberg giunge in Europa o nel Nord America; la gran parte approda in paesi limitrofi alle zone di conflitto, di crisi climatiche e alimentari; ciò che noi vediamo non è altro che un segnale, se rapportati alla loro consistenza globale. E già come segnale produce gli sconquassi sociali e culturali che conosciamo.
Rispetti agli scenari forniti dai media, ampiamente orientati a diffondere il verbo dell’accoglienza paternalistica, nel migliore dei casi, o della segregazione razziale, nel peggiore, appare tuttavia ben occultata la nuova segmentazione che il fenomeno migratorio internazionale sta assumendo anche tra i paesi cosiddetti avanzati e all’interno di aree continentali, tanto istituzionalmente omogenee, quanto, di fatto, completamente eterogenee e ancora di più disomogenee in prospettiva: tra queste aree, quella dell’UE, costituisce un esempio paradigmatico per confermare una nuova (o antica) teoria dei flussi emigratori, di ciò che li causa, di ciò che tendenzialmente possono produrre nei paesi di origine e nei paesi di arrivo; in definitiva, della conferma della divisione tra centro e periferia che si dispiega sia nella dinamica dei movimenti di capitali, come in quella dei movimenti delle persone.
Si può anzi affermare che i flussi di emigrazione seguono i movimenti di capitale e i flussi di materie prime verso le medesime vie e direzioni e che i migranti si configurano come una particolarissima merce che è al tempo stesso, materia prima e capitale umano, cioè il massimo connubio di valorizzazione che può essere concepito.
E’ materia prima, in quanto i paesi che li ricevono, nulla hanno investito nella loro crescita e educazione e neanche, a differenza di quanto fanno per le materie prime naturali, la pagano alcunché. Ciò che si limitano a fare, nel migliore dei casi, è integrarli nel tessuto economico-sociale di arrivo come persone di seconda o terza serie, spendendo una frazione irrisoria di quanto da essi ricevono in termini di contribuzione fiscale e usufruendo della loro funzione di calmierare rivendicazioni, salari, ecc.
Come ci insegna Paolo Cinanni nelle sue rigorose analisi contenute in “Emigrazione e Imperialismo” ed “Emigrazione e Unità Operaia”, vi sono poi una serie di vantaggi accessori quali, per esempio, il contenimento dell’inflazione nei paesi di arrivo a causa della connaturata predisposizione dei migranti a trasferire parte dei loro guadagni nei paesi di origine (dove invece, al contrario, si innesca un processo inflattivo che contribuisce alla svalutazione della moneta con conseguente peggioramento delle ragioni di scambio tra paese di origine e paese di arrivo) e via dicendo, e quindi, in ultima istanza, al consolidamento della posizione dominante dei paesi di arrivo rispetto a quelli di origine, come in un classico processo del serpente che si morde la coda.
In sintesi, il processo migratorio, in termini macroeconomici, funziona come un acceleratore di sviluppo dei centri capitalistici e un deceleratore di sviluppo (o un acceleratore di sottosviluppo) per le aree di partenza che si configurano ancor più velocemente come periferie.
Ciò che invece accade, osservato dal punto di vista soggettivo del migrante è, generalmente, un miglioramento relativo del proprio benessere economico e questo ha consentito nel corso del tempo di accreditare la narrazione per cui, l’emigrazione costituirebbe un fattore di sviluppo anche per i paesi di partenza, dimenticando però, che di tante emancipazioni individuali si tratta, mentre, dal punto di vista dei territori, è innegabile che il travaso di popolazione produca il perfetto inverso, a prescindere dalla grande mole di rimesse storicamente devolute dalle migrazioni ai rispettivi paesi di origine, superiori perfino, negli ultimi decenni, agli IDE (investimenti diretti all’estero, da parte dei paesi sviluppati verso quelli in ritardo di sviluppo), le quali pervengono però, in larga misura, alle elites che le amministrano nei paesi di partenza, consentendo con ciò il perpetuarsi di condizioni e rapporti sociali generalmente arretrati.
In un discorso tenuto il 15 maggio del 1970 a Grassano (Matera), nel paese del suo primo confino del 1935, Carlo Levi, fondatore della Filef (Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie), sintetizza come segue la questione, richiamandosi alla famosa espressione di Francesco Saverio Nitti pronunciata a seguito di un’indagine parlamentare dell’inizio del ‘900, e secondo il quale, alle plebi meridionali post unitarie, era presente un’unica alternativa: “O brigante o emigrante”.
In mancanza di altre opportunità, dice Levi, ai contadini meridionali si presentavano solo due possibilità: o seguire la dea Giustizia (e darsi quindi al brigantaggio), oppure la dea Fortuna (e quindi darsi all’emigrazione), cioè alla ricerca di fortuna all’estero.
La conquista del meridione italiano da parte dello Stato Piemontese costituisce, da questo punto di vista, un esempio limpido di cosa può produrre un processo di annessione e centralizzazione e, parallelamente, di patto concordato tra le elites (industriali del nord e latifondisti del sud).
E può essere trasposto, con le varianti del caso, agli attuali eventi dentro la cornice istituzionale della UE.
“O brigante o emigrante”, nella sua folgorante durezza, è anche un’espressione molto inquietante che può dar conto dei conflitti in corso in diverse parti del pianeta, oppure, tenendoci a casa nostra, di una sconfitta già avvenuta e della apparentemente impercorribile strada di un riscatto generale a seguito di una “dea Giustizia”, pur corroborata da moderne qualità riformiste, il cui odierno raggio di azione è stretto tra pareggio di bilancio e vincoli comunitari. Una sorta di Giustizia mutilata che offre ampi spazi alla Fortuna!
Quando Francesco Saverio Nitti pronuncia quest’espressione, il movimento del brigantaggio, con le sue ambiguità che tuttavia andrebbero meglio conosciute e che configurò i moti e le rivolte contadine nel meridione postunitario, è già stato sconfitto da tempo. Infatti siamo in pieno boom emigratorio verso le Americhe. Che contribuirà a edificare grandi paesi come gli Usa o l’Argentina o il Brasile o dall’altro lato del mondo, l’Australia.
Come dire che effettivamente, in assenza di concrete prospettive di emancipazione collettiva, non resta che la fuga individuale. E su di essa, certamente non può essere gettato l’ostracismo verso chi parte, piuttosto andrebbe denunciata l’incapacità di cambiare lo status-quo da parte di chi rimane.
La storia italiana, viene poi successivamente attraversata da altri flussi emigratori (ivi inclusa la parentesi imperiale fascista durante la quale le plebi dei territori meno avanzati del paese vengono orientate verso le nuove sponde, libiche e del corno d’Africa), per arrivare a quella del dopoguerra che riporta circa 10 milioni di persone a percorrere in modo strutturale le strade della dea Fortuna in particolare nel nord Europa distrutto dalla guerra e da riedificare.
L’emorragia si ferma solo nella seconda metà degli anni ’70; e anche in questo caso, è possibile richiamarsi all’espressione di Nitti, laddove si potrebbe intravvedere che, non il boom economico degli anni ’60 (caratterizzati paradossalmente dal massimo di emigrazione di massa registratasi nel ‘900), ma il ritorno ad una prospettiva di emancipazione collettiva del paese e di miglioramento delle condizioni salariali e di vita, contribuiscono a fermare il deflusso di emigrazione, pur in presenza della famosa inflazione a due cifre, causata (forse) anche dalle consistenti rimesse dei migranti che consentivano di chiudere il bilancio statale in pareggio grazie all’afflusso di parecchie migliaia di miliardi di lire.
Migliaia di miliardi che nei recessi della finanza nazionale, continuavano a non produrre particolare sviluppo nel meridione, ma che, tanto per non smentire Paolo Cinanni, riprendevano in gran parte la via di investimenti verso il nord Italia e il nord Europa, alimentando ulteriormente il differenziale (o lo spread) nord-sud.
E veniamo all’immediato:
La nuova emigrazione italiana, ricomincia a dar segni di sé in contemporanea con l’aggravarsi della grande crisi del 2007-2008.
A meno di 10 anni dall’introduzione dell’Euro e quindi in mancanza di possibilità di pur provvisori riaggiustamenti dei tassi di cambio, da un saldo emigratorio negativo e anzi dall’afflusso consistente di una immigrazione terzomondiale ed est-europea che fa dire a numerosi studiosi che il paese si è trasformato da paese di emigrazione a paese di immigrazione, già nel 2011-12 il numero di chi se ne va dall’Italia è superiore a quello di chi arriva. I dati Istat lo confermeranno solo nel 2014, perché solo allora le cancellazioni di residenza nei Comuni risulteranno superiori alle iscrizioni.
Ma stando ai dati forniti da altri Istituti di statistica europei, a partire dallo Statistisches Bundesamt di Wiesbaden, si può verificare che gli ingressi registrati ad esempio in Germania, risultano in questi anni, sempre tra le 3 e le 4 volte superiori al dato Istat.
E’ abbastanza paradossale che pur richiamandoci continuamente all’Europa, non vi sia stata, in questo ambito, alcuna significativa attenzione istituzionale ad una comparazione dei dati italiani con quelli degli altri paesi. La cosa è spiegabile: il richiamo proditorio, quanto mendace, alla luce intravvista in fondo al tunnel dai vari leader nazionali che si sono succeduti dall’inizio di questo decennio, ne sarebbe risultata screziata, messa in forse prima del tempo.
Si è continuato a preferire, per forza di cose, l’interpretazione main stream della naturale e auspicabile mobilità internazionale delle forze di lavoro in regime di globalizzazione e di libera circolazione, che, secondo i suoi adepti, viaggerebbe sia in partenza che in arrivo, in un gradevole equilibrio di andirivieni di formiche a cui tutti i paesi parteciperebbero in modo analogo e equilibrato, come a costruire il formicaio babelico del nuovo ordine continentale (e globale).
Il Prof. Monti lo esplicitò nel discorso di investitura a capo del Governo, incitando (e ammonendo) le giovani generazioni alla disponibilità e flessibilità anche territoriale e anche internazionale.
Ambiti politici relativamente più avveduti hanno continuato a sostenere in questi anni, con un rigore logico da far cadere le braccia, che il problema non è il fatto che giovani e meno giovani italiani se ne vadano di nuovo, ma piuttosto che non arrivino da noi altri giovani, analogamente formati, da altri paesi avanzati (leggasi nord Europa, ecc.). Alla domanda su quali vantaggi avrebbero questi ultimi al venire a praticare le proprie virtù in Italia, ovviamente, non è arrivata risposta.
Fatto sta che a scanso di equivoci, la nuova emigrazione italiana, dopo una parentesi di 30-40 anni (più o meno gloriosi) ha ripreso tutto il suo vigore, surclassando, nel 2014, l’immigrazione, in un rapporto di 3 a 1 e consentendoci di rinverdire la nostra tradizionale funzione di erogatori di risorse umane (stavolta anche molto qualificate) al resto dell’Europa e del mondo.
Ecco l’evoluzione del fenomeno nel quinquennio 2010 -2014 rapportato al paese guida del continente, la Germania, senza dimenticare che flussi proporzionalmente comparabili si registrano verso la Gran Bretagna, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Olanda, ecc.:
Nuova emigrazione italiana in Germania
Dati riferiti agli stabilimenti dall’Italia in Germania dal 2010 al 2014:
ANNO Num. Emigrati italiani
2011 30.152 (Quinto gruppo nazionale dopo polacchi, rumeni, bulgari, ungheresi)
(Dopo gli italiani vengono i greci con 23.779 e gli spagnoli con 20.672)
2012 42.167 (Quinto gruppo nazionale dopo polacchi, rumeni, bulgari, ungheresi)
(Dopo gli italiani vengono i greci con 34.109 e gli spagnoli con 29.910)
2013 57.523 (Quinto gruppo nazionale dopo polacchi, rumeni, bulgari, ungheresi)
(Dopo gli italiani vengono gli spagnoli con 36.511 e i greci con 33.379)
2014 70.338 (Quarto gruppo nazionale dopo polacchi, rumeni, bulgari)
(Dopo gli italiani vengono gli ungheresi con 56.439, i croati con 43.843, gli spagnoli con 34.376 e i greci con 30.602)
| ANNO |
| Emigrati | Variazione | % |
| 2010 |
| 24.502 |
| 100 |
| 2011 |
| 30.152 | 5.650 | +23% |
| 2012 |
| 42.167 | 12.015 | +40% |
| 2013 |
| 57.523 | 15.356 | +36% |
| 2014 |
| 70.338 | 12.815 | +22% |
(Fonte: Statistisches Bundesamt Wiesbaden – https://www.destatis.de/)
Come si può vedere, dei paesi dell’Europa occidentale presi in esame, solo dall’Italia continua a manifestarsi una crescita consistente del flusso emigratorio anche nel 2014 (+22%), mentre si registra una diminuzione netta da Spagna (-26%) e Grecia (-29%), oltre che dall’Ungheria, unico tra i paesi dell’est europeo che manifesti una riduzione dei flussi verso la Germania (da Polonia, Romania e Bulgaria, continua invece la crescita). Ciò è preoccupante e segnala che la gravità della crisi italiana non è poi molto diversa da quella spagnola o greca.
Vale anche la pena confrontare il dato del 2014 con quelli degli anni ’60, sempre verso la Germania, (che allora erano definiti dall’accordo bilaterale sottoscritto proprio 60 anni fa, il 20 dicembre del 1955), e anche verso un altro paese, la Gran Bretagna (il primo quindi, dell’eurozona, il secondo no) avvertendo che gli anni ’60 sono per antonomasia gli anni dell’”emigrazione di massa” dall’Italia. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, dal marzo del 2014 al marzo del 2015, secondo l’ONS inglese, vi si sono stabiliti 57.600 italiani, con un aumento del 37% rispetto all’anno precedente, quando erano stati 42.000.
Flussi di espatri Italia / Germania e Italia / Gran Bretagna dal 1960 al 1970
| Anno | Germania federale | Gran Bretagna |
|
|
|
|
| 1960 | 100.544 | 10.118 |
| 1961 | 114.012 | 11.003 |
| 1962 | 117.427 | 8.907 |
| 1963 | 81.261 | 4.681 |
| 1964 | 75.210 | 4.979 |
| 1965 | 90.853 | 7.098 |
| 1966 | 78.343 | 7.346 |
| 1967 | 47.178 | 4.392 |
| 1968 | 51.152 | 3.777 |
| 1969 | 47.563 | 2.971 |
| 1970 | 42.849 | 2.476 |
Dati Istat
Come si vede, il numero di stabilimenti di italiani in Germania nel 2014 supera i flussi registratisi nel quadriennio 1967-1970 e si avvicina a quelli dal 1963 al 1966. La media registratasi nel decennio ’60/’70 è di 84.600. Ci siamo molto vicini.
Mentre per la Gran Bretagna siamo abbondantemente sopra, oltre 8 volte la media degli anni ’60, tanto è vero che Londra, risulterebbe essere la 6° o 7°città “italiana” in Europa.
L’Istat, invece, registrando il dato delle cancellazioni dalle anagrafi comunali nel 2014, fornisce il seguente dato: il totale degli espatrii (in tutto il mondo) sarebbe di 101.297.
Di questi, si sarebbero trasferiti in Germania 14.270, mentre 13.425 si sarebbero trasferiti in Gran Bretagna.
La proporzione tra i dati tedeschi e quelli italiani è di 4,92, cioè quasi 5 volte in più. Quella tra i dati inglesi e italiani è di 4,3, cioè oltre 4 volte in più.
Già nel 2012 e nel 2013 avevamo avuto modo di evidenziare questa macroscopica differenza tra i dati italiani e quelli dei paesi di arrivo, verificandola anche per il Belgio, l’Olanda, l’Australia e la Svizzera. In tutti questi paesi, la differenza si aggirava tra le 3 e le 4 volte il dato italiano. E’ noto che ciò derivi dal fatto che gran parte dei nuovi migranti comunicano la propria variazione di residenza ai rispettivi consolati o ai rispettivi comuni italiani con anni di ritardo; per molteplici ragioni, non ultima quella derivante dalla precarietà dell’occupazione assunta all’estero o dall’incertezza di stabilirsi definitivamente in un luogo, oppure per mantenere l’assicurazione sanitaria italiana; insomma, perché la cosiddetta emigrazione 2.0 non è regolata da alcun accordo, è pienamente “libera” e precaria e ricorsiva, un po’ come quella negli Usa degli negli anni ’30, durante la grande depressione.
Resta il fatto che nel 2014, solo sommando gli italiani che si sono stabiliti in Germania e in Gran Bretagna arriviamo alla somma di 127.939 persone, una cifra superiore, da sola, a quanto registra l’Istat verso tutti i paesi del mondo messi insieme.
Ma Svizzera, Francia, Argentina, Brasile e Usa rappresentano altre storiche mete di emigrazione, verso le quali, applicando una proporzione contenuta, di 3 ad 1 rispetto ai dati Istat, potrebbero essersi trasferiti oltre 100.000 italiani. Poi vi sono la Spagna, il Belgio e l’Australia, l’Olanda, l’Austria, il Canada e il resto del mondo.
E’ dunque più che probabile che l’ammontare complessivo degli emigrati italiani nel corso del 2014 abbia raggiunto la cifra di 300.000 persone. E potrebbe essere una stima in difetto.
La nuova emigrazione degli anni ’10 del XXI secolo, connotata con tanti nuovi termini abbastanza fighi, tipo expat, italians, e così via, assomiglia invece, quanto ad entità e cause, a quella, di massa, degli anni ’60.
Ma gli effetti sul paese potrebbero essere molto diversi e più gravi. Il volano dello squilibrio tra nucleo duro dell’Europa e paesi del sud, in prima fila l’Italia, ha già abbondantemente innescato la sua forza di trazione, in uno scenario che tuttavia si differenzia sensibilmente da quello degli anni ’60, non soltanto per l’assenza del boom (ovvero per la presenza del suo contrario, la cosiddetta stagnazione secolare), ma anche perché i nuovi flussi dall’Italia avvengono all’interno di un quadro di decrescita demografica che coinvolge l’intera Europa occidentale ad eccezione della Francia. Un quadro diametralmente opposto a quello degli anni ’60.
Dunque, per i paesi erogatori di nuova emigrazione, almeno per quelli in decrescita demografica, non si tratta di ridurre gli esuberi di popolazione rispetto al loro limitato potenziale produttivo, quanto eventualmente, di ridurre gli esuberi parallelamente alla distruzione, avvenuta o in corso, del potenziale produttivo causato dalla crisi. Vale a dire di accettare un inesorabile declino.
Se si raffronta la situazione italiana e quella tedesca, ci troviamo di nuovo di fronte, per entrambi i paesi, ad un alto tasso di decrescita demografica; lo Statistisches Bundesamt di Wiesbaden, (l’Istat tedesco) prevede diversi scenari di riferimento per la Germania, da oggi al 2060: in mancanza di aumento del tasso di natalità e con una bassa quota di immigrazione, la popolazione tedesca si ridurrebbe dagli attuali 81 milioni a circa 60 milioni. Tra le ipotesi formulate per evitarlo, oltre all’ovvia incentivazione del tasso di natalità che dovrebbe passare da 1,4 a 1,6 nati per donna ed oltre, vi è l’indispensabile aumento dell’immigrazione, in uno spettro che va da 6.3 a 10,8 milioni, cioè, mediamente 230.000 all’anno dal 2013 al 2060. Solo a quest’ultima condizione, vi è la possibilità di mantenere sostanzialmente stabile la popolazione tedesca.
La scelta è già stata fatta: dal 2012 la Germania viaggia a tassi di oltre 1 milione di immigrati all’anno: 1.081.000 nel 2012, 1.228.000 nel 2013, 1.465.000 nel 2014, con un saldo positivo, in quest’ultimo caso, di 550.000 persone. Soltanto nel 1992, dopo la caduta del muro, vi era stato un’afflusso superiore (1,55 milioni) ma si trattava in gran parte di cittadini ex tedeschi dall’est Europa e dalla Russia (Aussiedler e Uebersiedler).
E’ privilegiata l’immigrazione “di qualità”, con alti livelli di scolarizzazione, secondo le indicazioni della legge sull’immigrazione varata dal socialdemocratico Schroeder nel 2001. Quindi quella inter-europea innanzitutto, dal sud e dall’est: 190.000 polacchi, 190.000 rumeni, 77.000 bulgari, 70.000 italiani, 56.000 ungheresi, 43.000 croati, 34.000 spagnoli, 30.000 greci, sono affluiti nel paese centrale dell’Europa nel 2014.
Il totale degli immigrati dai paesi EU è stato di 520.000 persone. Altri 201.000 sono arrivati da altri paesi europei non EU. Soltanto 50.000 dall’Africa, 25.000 dalle Americhe e 125.000 dall’Asia e dal resto del mondo. Certamente non si disdegneranno alcune nazionalità extraeuropee provenienti da paesi con livelli educativi medi, come la Siria, se non altro per diluire nell’umanitario la sensazione sgradevole di una nuova politica di potenza giocata sui movimenti di popolazione, ma il grosso dell’assorbimento di risorse umane sta avvenendo a discapito (o con la complicità) dei paesi contigui, per i quali si configura sempre più lo status di satelliti da tutti i punti di vista.
La Germania attua una nuova politica di immigrazione, di massa e selezionata, per mantenere integro e rafforzare il proprio potenziale produttivo, analogamente a quanto avviene sul versante dei movimenti finanziari aspirando capitali dal proprio circondario. Progetta e attua il secolo a venire. Correttamente, dal suo punto di vista, e seguendo una prassi storicamente già percorsa, con diverse varianti.
L’Italia, invece, è il suo primo paese fornitore di braccia e intelligenze in Europa occidentale e la proiezione dello Svimez, di qui al 2050, fotografa il probabile lato sud della medaglia europea, con una contrazione di popolazione, che a bocce ferme, sarà di circa 5 milioni nel meridione d’Italia.
Deduzioni e connessioni relative a EU, Euro, democrazia, lavoro, diritti, ecc. ecc., sono gradite.
Rodolfo Ricci)