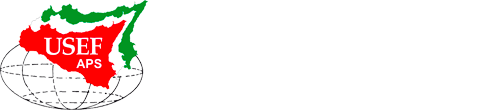Pubblichiamo a seguire la seconda parte della riflessione di Rodolfo Ricci (Filef) sui fenomeni dell’immigrazione, dell’emigrazione e della cooperazione. Ambiguità della “libera circolazione” Dall’inizio degli anni ’80, parallelamente all’affievolirsi dei flussi emigratori dall’Italia e alla parallela crescita dei flussi immigratori,
Pubblichiamo a seguire la seconda parte della riflessione di Rodolfo Ricci (Filef) sui fenomeni dell’immigrazione, dell’emigrazione e della cooperazione. Ambiguità della “libera circolazione” Dall’inizio degli anni ’80, parallelamente all’affievolirsi dei flussi emigratori dall’Italia e alla parallela crescita dei flussi immigratori,
comincia a farsi strada un’interpretazione dei flussi migratori come opportunità di sviluppo (risorsa emigrazione) e insieme di apertura ad altri mondi identitari, analogamente a quanto già, le classi dirigenti nord europee, con varie contraddizioni interne alle diverse aggregazioni politiche, datoriali e sindacali, andavano producendo: proprio perché si parla, ormai, di immigrati – non più di emigrati – l’accento si sposta sulle grandi opportunità di emancipazione individuale che i movimenti migratori offrono a chi li percorre e a chi li accoglie; emancipazione economica, sociale e – ma solo in prospettiva -, anche civile, che consente di superare condizioni e relazioni sociali arcaiche tipiche dei paesi di provenienza, generalmente arretrati e, allo stesso tempo crescita economica per il paese. L’indagine si sposta dunque da un approccio sociale e politico olistico in grado di tenere insieme i due corni del problema, ad un approccio che predilige la dimensione individuale della libertà del cittadino migrante nella quale prevale l’impostazione che potremmo definire genericamente diritto-umanistica, cioè del diritto alla libera circolazione delle persone, un approccio che tuttavia rischia di ignorare progressivamente le ragioni di fondo dei movimenti migratori e gli effetti che essi producono e produrranno a medio e lungo termine sui paesi di origine: gli stessi effetti che analoghi movimenti di massa avevano prodotto in tempi lontani e recenti, ma comunque in modo duraturo, ad esempio nel meridione italiano. Si dà per scontato ed ovvio che i flussi emigratori abbiano sempre e solo un’unica direzione: tante diverse correnti che però si muovono solo da sud verso il nord civilizzato, industrializzato e libero. Il perfetto contrario dei flussi legati ai processi di colonizzazione che storicamente erano andati in senso inverso e che, guarda caso, erano stati prodotti proprio da quel nord libero, civilizzato, industrializzato, insomma dall’occidente avanzato, all’interno del quale ormai ci collochiamo pienamente. In realtà i flussi di popolazione seguivano allora e seguono oggi la stessa direttrice del flusso di risorse naturali e di concentrazione dei capitali che si muove sempre prevalentemente da sud a nord (e da est verso ovest); il fatto che ad essi si sommino oggi esodi epocali e incontrollati di persone, significa probabilmente che la parte di risorse naturali che in epoca coloniale veniva conferita o lasciata nei luoghi di origine, adesso non è più sufficiente alla riproduzione, in tali aree, di una vita dignitosa, seppure con bassi livelli di consumo, mentre allora era, almeno relativamente, sufficiente ad impedire esodi imponenti come quelli che abbiamo di fronte. L’altra novità sembra costituita dal fatto che la fase di globalizzazione succeduta a quella fordista necessita di incorporare all’interno dei paesi guida di quote sempre maggiori di capitale umano caratterizzato da diversi livelli di qualificazione, da una parte per contrastarne il declino demografico, dall’altra per garantire un livello medio del costo del lavoro compatibile con le sfide che emergono dall’imporsi sulla scena globale dei grandi paesi asiatici con costi medi del lavoro notevolmente inferiori. Se quindi a parlare di emigrazione sono i paesi di arrivo, l’attenzione viene posta, nel migliore dei casi, sulla dimensione dei diritti di accoglienza, soggiorno, integrazione, ecc., ma ciò non impedisce tuttavia che dopo 40 anni dall’inizio massiccio dei movimenti immigratori verso l’Italia, questi diritti continuino in gran parte ad essere disattesi: le vicende di Rosarno, dei raccoglitori delle produzioni agricole dell’intero meridione dalla Calabria, alla Sicilia, alla Puglia, alla Campania, come gli innumerevoli episodi che coinvolgono lavoratori immigrati nell’edilizia e in altri settori maturi stanno lì a dimostrarcelo. Allo stesso modo, la quasi totalità del settore della cura alle persone – badanti – costituisce un ambito di lavoro informale e sottopagato sostitutivo di un welfare sempre più privatizzato e altrimenti impraticabile a causa della necessità di contenimento del debito pubblico. A distanza di decenni, questi lavoratori, oltre ad una condizione sociale di serie B, non hanno ancora neanche acquisito il diritto di voto amministrativo. Ciò significa che la “risorsa emigrazione” è essenzialmente risorsa per lo specifico sistema paese che li accoglie in un momento di destrutturazione e precarizzazione del mercato del lavoro e del welfare, consentendo per esempio, il pareggio dei bilanci degli istituti previdenziali anche attraverso l’appropriazione di parti consistenti dei contributi pensionistici. Si tratta e si è trattato quindi di un uso reazionario tutt’altro che progressista di questa risorsa che non ha minimamente affrontato la questione generale della ridistribuzione dei redditi e di un modello alternativo di organizzazione sociale. Si potrebbe dire che dentro la globalizzazione, tutto deve o doveva cambiare eccetto ciò che dovrebbe o deve cambiare. Con i risultati nefasti delle guerre ventennali in medio oriente e con le successive aggressioni a Libia e Siria in concomitanza con le cosiddette primavere arabe e con l’incedere della crisi capitalistica del 2007-2008 (e i suoi enormi effetti sui paesi africani e medio orientali: crollo dei prezzi delle produzioni agricole, parallelo sviluppo del “land grabbing” ad opera di multinazionali asiatiche e occidentali in molti paesi, ecc.) i cui esiti finiscono col lambire duramente tutto il sud Europa, i flussi immigratori si trasformano in veri e propri esodi “incontrollabili”. E’ a questo punto che, in Italia e nell’intera Europa, la coppia interpretativa “accoglienza” vs “respingimento”, “integrazione” vs “xenofobia”, ritrova una sua dinamica analoga, ma fortemente amplificata, a quella a cui si era assistito negli anni ’50 e ’60 nei paesi nord-europei, quando ad emigrare erano stati gli italiani, gli spagnoli, i greci, i portoghesi, gli jugoslavi. Ma, a parte la questione dell’accoglienza, in cui forse in quanto patria della cristianità continuiamo a distinguerci relativamente dal resto d’Europa, gran parte della concreta dimensione dei diritti continua a rimanere ipocritamente inevasa (come appunto accade in ambito previdenziale, per cui, come accennato, un lavoratore straniero proveniente da un paese non coperto da accordi bilaterali con il nostro paese, se lavora meno di 20 anni in Italia e poi torna definitivamente al proprio paese di origine non potrà godere dei contributi che nel frattempo ha versato, pur essendo definitivamente approdati all’osannato regime “contributivo”). La grande differenza da quella fase storica è infatti che i nuovi flussi avvengono all’interno di una dimensione di crisi permanente e di ristagno economico che si avvolge su se stesso e per il quale non si intravvedono vie di uscita, diversamente da quando l’intero occidente era percorso dai miracoli economici nazionali che sembravano consentirne una crescita infinita. Che essi si producono solo in minima parte attraverso accordi bilaterali tra paesi, ma nella cornice indefinita della globalizzazione, che si diffondono in contesti di mercati del lavoro nazionali sempre più precarizzati a partire dalle popolazioni autoctone. Bisogna ricordare che nel periodo che va dagli anni ‘50 ai ‘70, l’”accorto” atteggiamento utilitaristico di paesi come la Germania, prevedeva che l’immigrazione fosse sempre congiunturale, vale a dire abbinata alle fasi crescenti del ciclo, mentre nei periodi recessivi, i lavoratori immigrati potevano essere rispediti ai rispettivi paesi, tanto che si era coniato il formidabile sostantivo di gastarbeiter, cioè di lavoratore ospite a tempo determinato. Questa opportunità di respingimento soft venne usata da questo paese in tutte le crisi congiunturali degli anni ‘70 e ’80, ripercorrendo un’antica tradizione di utilizzo della forza lavoro straniera. La concreta possibilità di emancipazione, integrazione, successo del singolo lavoratore immigrato era dunque, in ogni caso, determinato dalle esigenze economiche nazionali, dall’andamento dell’export e dei cicli. Si trattava cioè di una pianificazione nella dimensione di stato-nazione. Ne è prova che degli oltre 8 milioni di italiani che hanno sperimentato l’emigrazione verso la Germania nel dopoguerra fino agli anni ’80, la popolazione italiana in questo paese non ha mai superato il milione. Il resto, nel frattempo, rientrava o era costretto a rientrare in Italia. Il diritto di libera circolazione, da questo punto di vista, è stato sempre una variabile della possibilità di valorizzazione del capitale locale nazionale dei paesi ospitanti. E da questo punto di vista, passata al sbornia ideologica della globalizzazione infinita, non vi è alcuna essenziale novità, come dimostrato recentemente anche dagli accordi tra Gran Bretagna e UE (in particolare a discapito dei diritti previdenziali dei lavoratori immigrati di origine comunitaria: polacchi, bulgari, rumeni ed italiani) che precedettero il Brexit. La “libera circolazione” delle forze di lavoro in Europa, rispondeva alla necessità di mantenere un equilibrio tra concentrazione finanziaria crescente in alcuni paesi e disponibilità di forza lavoro proveniente da paesi in stagnazione o in surplus relativo di popolazione attiva rispetto ai propri sistemi produttivi in balia di una competizione aperta ed accentuata. Non quindi di ristabilire un equilibrio tra aree sviluppate ed aree svantaggiate o in ritardo di sviluppo. Anzi, l’esatto opposto. Come anche dimostrato dalla dinamica degli spread sui titoli pubblici e dall’incedere inarrestabile del debito che, guarda caso (ed andrebbe attentamente ristudiato alla luce degli eventi dell’ultimo decennio), riguarda essenzialmente le aree comunitarie storicamente erogatrici di forza lavoro emigrata. La “nuova emigrazione” italiana E’ per gli stessi motivi che negli anni seguenti all’inizio della crisi del 2007-2008, si assiste ad un progressivo intensificarsi dei flussi di nuova emigrazione dall’Italia (e analogamente dagli altri paesi del sud e dell’est europeo), verso il nucleo duro della UE ed anche, nuovamente, oltre oceano, prevalentemente verso Australia e Canada, con l’inaugurazione di nuove rotte verso diversi paesi emergenti. Questa volta ad emigrare sono anche giovani a medio-alta qualificazione, in buona parte laureati e diplomati. Non si tratta solo dei cosiddetti cervelli, la cui perdita comunque costituisce di per sé un fattore per niente positivo che la dice lunga sullo stato in cui versa anche il nostro sistema di ricerca scientifica pubblica e privata, ma anche di moltissimi giovani e meno giovani aggrediti dalla crisi e senza opportunità di occupazione dignitosa o minimamente adeguata alla propria formazione e qualificazione. Stando ai dati di ingresso registrati da paesi come la Germania, la Gran Bretagna, l’Olanda, la Svizzera, il Belgio e l’Australia, nel quinquennio 2013-17, il flusso emigratorio italiano raggiunge livelli vicini a quello medio degli anni ’60 e supera di gran lunga i flussi di immigrazione da lavoro sommati anche ai flusso di arrivo di profughi e asilanti provenienti dal Mediterraneo e dall’Africa. Secondo stime ampiamente condivise, circa 250mila/300mila persone sono espatriate ogni anno dal 2013 ad oggi, mediamente 2,5/3 volte il dato fornito dall’Istat. (Mentre l’entità dello stock di emigrazione è attualmente, secondo le Anagrafi consolari, pari ad oltre i 5,6 milioni di persone, quello immigratorio è di circa 5,2 milioni. Poi vi sono circa un milione di emigrati non censiti, mentre gli irregolari immigrati sono circa mezzo milione. I totali darebbero 6,5 milioni di emigrati e 5,5 milioni di immigrati. La somma di emigrati e di immigrati è pari al 20% della popolazione totale italiana). Si tratta quindi di una nuova emigrazione di massa, la cui entità e consistenza risulta stranamente – diciamo così – sottovalutata e sottaciuta. Cercare di comprenderne il perché aiuterebbe a disvelare l’ ideologia di cui è impregnata la discussione sui movimenti migratori nel loro complesso. Le diverse varianti dell’approccio positivo – senza se e senza ma – alla libera circolazione delle persone si sforzano di interpretare questi massicci movimenti come opportunità di libera crescita individuale che non deve essere contrastata e che anzi, in un vago futuro, potrà portare dei risultati positivi al paese. Ma questo tentativo interpretativo appare sempre più difficile da sostenere: mentre la Germania ha in programma di ottenere, da ora, al 2050-60, un saldo positivo di immigrazione di circa 10 milioni di persone (cosa raggiungibile facendo entrare almeno 20 milioni di persone in questo arco di tempo), l’Italia rischia, secondo lo Svimez, in particolare nel meridione, di assistere ad una desertificazione demografica di 5,5 milioni di persone, sempre al 2050-60. Recentemente l’Istat ha ampliato questa previsione fino alla cifra record di -7 milioni. Già, perché l’altro problema non secondario è quello che gli attuali movimenti migratori intra-europei si verificano in un contesto di forte contrazione demografica generalizzata dell’intero continente (a parte la Francia), diversamente da quanto accaduto fino agli anni ’70. E, contrariamente a quanto si immagina, i paesi centrali accettori di emigrazione, privilegiano non i flussi provenienti da paesi extraeuropei, ma appunto quelli inter-comunitari che ne costituiscono circa i 2/3 e che hanno mediamente un alto livello di qualificazione. Ciò significa che la risorsa umana, in particolare quella qualificata, è una merce sempre più appetibile e ad essa si guarda come ad una vera e propria risorsa naturale limitata, ma gratuita, diversamente dalle risorse naturali che vengono quotate in qualche borsa globale e acquistate almeno in cambio di valuta pregiata. L’accaparramento di questa risorsa è dunque un obiettivo strategico, in grado di determinare il futuro dello sviluppo di paesi ed aree territoriali, anche perché, in un contesto di accentuata competizione tecnologica, essa costituisce il fattore che fa la differenza: dentro l’economia della conoscenza, la disponibilità di lavoro intelligente è il fattore determinante. Paesi come Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria sono stati sottoposti, ancor più che i paesi del sud Europa, ad un salasso ampio e costante di flussi emigratori. Quasi un quarto dell’intera popolazione rumena vive all’estero; come circa un quarto di popolazione tedesco orientale è emigrata verso l’ovest del paese dopo la riunificazione. Sarebbe molto istruttivo studiare la connessione tra questi fenomeni e l’evoluzione politica in questi paesi (Visegrad, ecc.), oltre che, appunto, nella ex Germania orientale, dove AfD (Alternative fuer Deutschland), il partito xenofobo in forte ascesa, vanta percentuali doppie rispetto all’ovest, mentre la percentuale di stranieri ivi residenti è notevolmente al di sotto di quella che si registra all’ovest. Si verrebbe tentati di affermare che il tasso di xenofobia e razzismo è direttamente proporzionale al tasso di emigrazione, piuttosto che di immigrazione ! Soprattutto le aree interne di tutti i paesi europei di nuova emigrazione sperimentano una sorta di tsunami demografico (Stefano Boffo e Enrico Pugliese – “L’Emigrazione dei Meridionali” – In Rivista delle Politiche Sociali n. 4-2017 – Ed. Ediesse) con punte inquietanti: da una recente indagine svolta da Carmine Nardone e Grazia Moffa nell’area del Beneventano si registra che la popolazione dei comuni tra i 5 e i 10mila abitanti hanno subito uno svuotamento del 30-35% di popolazione in gran parte giovane, solo nel quinquennio 2011-2016. L’effetto di questi spostamenti su questi territori e sui loro tessuti sociali ed economici, sono devastanti e non recuperabili nel breve medio periodo: stiamo assistendo alla nascita di una nuova geografia. Emigrazione o cooperazione In questo scenario complesso, il nostro paese assume le caratteristiche di un inconsueto “crocevia migratorio”, secondo l’espressione di Enrico Pugliese (“Quelli che se ne vanno” – Ed. Il Mulino 2018); ci troviamo cioè alle prese con grandi flussi in arrivo dal sud e dall’est del Mediterraneo verso i paesi periferici dell’Europa e, allo stesso tempo, con grandi flussi in uscita dal sud e dall’est Europa verso il centro-nord del continente. Il nord predilige i flussi in arrivo dai paesi europei periferici, mentre cerca di contenere all’interno di essi (Europa mediterranea ed est Europa), quelli provenienti da Africa e Oriente. Alla divisione internazionale del lavoro si accoppia la selezione mirata dei flussi migratori. Siamo cioè di fronte ad un nuovo scenario che mantiene intatte le logiche di una geopolitica che rimodula e generalizza gli ingredienti dell’imperialismo post-coloniale, graduando sapientemente i loro effetti e realizzando una sorta di cerchi concentrici per le masse umane in movimento che, a seconda del loro valore in termini di competenze e niveu formativi, devono essere contenute nelle periferie o possono essere ammesse e integrate nei centri di progettazione e di direzione finanziaria e capitalistica, in misura delle necessità dei reciproci sistemi produttivi e in misura delle necessità di un mercato del lavoro sempre più precarizzato e di un welfare in fase di ulteriore contrazione. Sembra trattarsi della riprogettazione della divisione internazionale del lavoro tra i paesi avanzati, in particolare tra economie a maggiore o minor grado di finanziarizzazione e di sviluppo teconologico e industriale: la “qualità” media dei flussi migratori (livelli di scolarizzazione, competenze, congenialità culturali) deve essere tendenzialmente compatibile con la posizione riservata ai singoli paesi nella nuova divisione internazionale del lavoro. Una dinamica che non riguarda solo la relazione tra paesi, ma anche la relazione tra aree di singoli paesi, ad esempio nord-sud Italia o Ovest-Est della Germania. Ne viene fuori un conglomerato esplosivo per i paesi (e i territori) periferici, i quali sono alle prese allo stesso tempo con arrivi di massa dai continenti della povertà e con esodi di massa di popolazione giovanile ad alta qualificazione, mentre per i paesi centrali, si riproduce l’antica e provvida divisione funzionale del mercato del lavoro con diritti ed opportunità segmentati a seconda della differente origine e qualità della merce lavoro, limitata soltanto dalla possibilità congiunturale di valorizzazione che si dà in un determinato paese o in un’area, in un determinato tempo. Se i tempi sono infausti, si procede a misure di riduzione dei diritti di welfare per i nuovi arrivati o addirittura di espulsione mettendo anche in discussione i sacri trattati. Il Belgio ha provveduto negli ultimi anni a intimare l’obbligo di lasciare il paese a migliaia di cittadini comunitari perché “di eccessivo peso” per il proprio sistema di welfare. Circa un migliaio gli italiani. Analogamente hanno fatto per anni, ben prima della Brexit, diversi Laender tedeschi. In mancanza di politiche di riequilibrio generali o regionali, gli effetti di questo intreccio migratorio sui paesi e sulle aree di origine dei flussi sono quindi destinati a peggiorare ulteriormente e, inevitabilmente, a riprodurre ed anzi ad intensificare ulteriori flussi di emigrazione fino al deperimento o alla distruzione del tessuto produttivo e sociale mettendo sotto stress certamente i paesi di partenza, ma anche i primi paesi di arrivo, che nel nostro caso, sono sempre ed ancora quelli periferici del sud e dell’est europeo. La desertificazione sociale avanza a grandi passi e con gradazioni differenziate da area ad area; i territori e gli eco-sistemi colpiti da questi esodi ne risulteranno a lungo sconvolti. Questa situazione da cui difficilmente anche i paesi che si ritengono più forti resteranno alla lunga immuni, può essere interrotta solo con un cambiamento radicale dei paradigmi e delle ragioni di scambio; solo con grandi progetti di cooperazione finalizzata allo sviluppo e al recupero dei differenziali di produttività; soltanto con un stop ai processi di accaparramento delle terre e delle risorse naturali e di centralizzazione finanziaria e capitalistica incontrollata. In ultima istanza con il contenimento e la riconfigurazione dei processi di globalizzazione che non può più essere gestita in termini neoliberistici. Non vi sono alternative se non quelle verso una risocializzazione e ridistribuzione delle risorse all’interno dei singoli paesi che consenta di ampliare i rispettivi mercati interni e di ridurre il ritmo di espropriazione di risorse naturali ed umane; mentre, nei rapporti tra singoli paesi, è indispensabile un ritorno a ragioni di scambio sostenibili ed equilibrate in modo che si riducano i differenziali di produttività (o di declino) e si blocchi la desertificazione economica e sociale a cui si va altrimenti incontro. In un auspicabile processo di questo tipo, che solo una politica forte può determinare, sono proprio i paesi periferici del sud Europa che paradossalmente possono fare la differenza: semplicemente perché saranno questi paesi a dover assumere delle decisioni prima di altri se non vogliono rischiare di restare stritolati dal crocevia migratorio. Se la risorsa umana qualificata costituisce sempre più il fattore centrale dello sviluppo, i paesi in eccesso di forza lavoro qualificata – rispetto alla loro attuale capacità di valorizzazione interna, come ad esempio quelli del sud Europa-, dovrebbero assumere politiche che ne impediscano il deflusso verso i paesi più forti, ma piuttosto, eventualmente, orientare almeno una parte di tali flussi verso le aree più deboli che sono a corto di specifiche competenze per il loro sviluppo, cosa che può consentire, allo stesso tempo, un parziale riequilibrio e conseguentemente una riduzione della crescita di correnti immigratorie incontrollabili verso i propri confini. Si tratta cioè di governare i flussi di emigrazione qualificata nostrana e di orientarli, almeno in parte, verso politiche di cooperazione internazionale. Chi sta al centro del Mediterraneo ha, da questo punto di vista, un grande compito. Se la variabile emigratoria (in questo caso quella sud europea) è un fattore strategico, si debbono costruire strumenti adeguati affinché essa non sia gestita dall’esterno, cioè dal libero mercato e dai suoi paesi guida, ma diventi costitutiva di un approccio geopolitico finalizzato alla cooperazione e alla democrazia economica e, nei contesti dovuti, all’intervento umanitario, cosa, quest’ultima, sperimentata con successo in paesi africani e latino-americani, da un piccolo paese come Cuba, povero di risorse naturali, ma non di capitale umano, che ha in più occasioni utilizzato in questa chiave il proprio personale medico e sanitario “in relativo esubero”. Il libero diritto di emigrazione individuale dovrebbe essere rimodulato alla luce della necessità dei territori erogatori di riconquistare un proprio diritto di conservazione, riproduzione e utilizzo interno delle proprie risorse umane (e dei propri ecosistemi). L’individuale diritto umano di emigrare va coniugato col diritto umano a non dover emigrare per forza. E se si deve lasciare la gente emigrare, vale la pena farlo non per arricchire ulteriormente chi è già ricco, ma piuttosto per aiutare a svilupparsi chi è più povero. Alla globalizzazione neoliberista che sollecita grandi movimenti migratori di massa lungo una linea che tende verso i centri del finanz-capitalismo globale, si dovrebbe rispondere con un approccio di globalizzazione delle risorse umane finalizzato al riequilibrio economico, sociale e ambientale, un approccio ad una generalizzata cooperazione internazionale che necessita tuttavia di una guida, di un attore, di una forte soggettività politica e istituzionale. Le coppie interpretative buonismo vs cattivismo, società aperta vs società chiusa ed altre mediocri amenità che si legittimano vicendevolmente, che ci hanno portato agli esiti attuali e in cui continuiamo improvvidamente a sostare, dovrebbero essere espunte dal vocabolario dell’analisi e dell’indagine. Le dinamiche con cui abbiamo a che fare non sono neanche più complesse, sono piuttosto semplici, evidenti, farebbero parte del senso comune, se esso non fosse stato così proditoriamente inquinato dall’ideologia del neoliberismo globalizzato. Se, infine, come sostengono Carlo Levi e Paolo Cinanni, le migrazioni moderne sono anche il risultato di sconfitte sociali e politiche, è proprio da lì che si dovrebbe riprendere a districare la matassa. Un buon esercizio per il ripasso estivo a sinistra.(Rodolfo Ricci*-cambiailmondo.org/Inform) *Federazione italiana emigrazione immigrazione