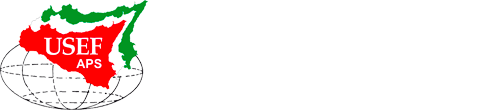Col passaggio dalla meccanizzazione all’automazione del processo produttivo muta il carattere dell’emigrazione. La battaglia per la conquista dei diritti. di Paolo Cinanni (foto accanto) Nel corso della storia dell’umanità, il fenomeno migratorio rappresenta sempre un fattore di progresso per i paesi d’immigrazione,
Col passaggio dalla meccanizzazione all’automazione del processo produttivo muta il carattere dell’emigrazione. La battaglia per la conquista dei diritti. di Paolo Cinanni (foto accanto) Nel corso della storia dell’umanità, il fenomeno migratorio rappresenta sempre un fattore di progresso per i paesi d’immigrazione,
che si adegua man mano alle esigenze dello sviluppo delle forze produttive. Dalla primitiva emigrazione coloniale, si passa alle ferme caratteristiche dell’emigrazione operaia più recente, sino ai nostri giorni, in cui l’immigrazione viene man mano adeguandosi al nuovo processo di decentramento produttivo, assumendo anch’essa forme nuove. La primitiva emigrazione di coloni era diretta verso paesi e regioni scarsamente popolate, per la messa in coltura di nuove terre e per la trasformazione progressiva delle colture estensive in colture intensive specializzate, con la promozione di un nuovo mercato, che crea le premesse medesime per lo sviluppo dei primi processi d’industrializzazione. A cominciare dal Nord-America, negli ultimi decenni del secolo scorso, la primitiva immigrazione viene perciò stesso trasformandosi: grandi masse di forza-lavoro, e fra queste i lavoratori immigrati, vengono concentrati nei grandi agglomerati urbani ove si sviluppa la grande produzione industriale. L’immigrato si trasforma, quindi, da contadino in operaio, concorrendo – col suo contributo aggiuntivo di lavoro produttivo – allo sviluppo accelerato dell’economia del paese ospite, fornendo al capitale stesso un supervalore crescente, che ne accelera la riproduzione e l’espansione del suo potere sui mercati mondiali. Questa supremazia economica e finanziaria del capitale dei paesi industrializzati sui mercati mondiali si trasforma presto in potere politico e dominio imperialistico sugli altri paesi del mondo. In questo senso l’immigrazione di forze-lavoro diventa una componente dello sviluppo e del potere dei grandi paesi industrializzati sul mercato mondiale, o per dirla con Lenin “una delle particolarità dell’imperialismo’’: cioè, una delle particolarità che aggrava ogni giorno la divisione del mondo in ricchi e poveri. Infatti, questo drenaggio di forze-lavoro dei paesi che le hanno formate dai paesi ove vengono impegnate nella produzione, rappresenta il più grave degli “scambi ineguali”, che concorre direttamente e inversamente a far più ricchi i paesi d’immigrazione e più poveri i paesi d’emigrazione. Ma con l’accentramento delle forze-lavoro e dei capitali nei grandi centri della produzione industriale, si determina un accelerazione eccezionale dello sviluppo tecnico-scientifico che nel corso di pochi decenni rivoluziona ancora una volta il processo produttivo. Dalla meccanizzazione si passa all’automazione, e con l’impiego più razionale dell’elettronica e dell’informatica si riduce enormemente il numero delle forze-lavoro impiegate nei nuovi processi produttivi. Più che il loro numero conta ora la loro preparazione tecnico-professionale, e ciò stesso trasforma ancora una volta i caratteri dell’emigrazione, che provenendo in generale da paesi più arretrati, servirà d’ora in poi a coprire prevalentemente i posti disertati dai lavoratori locali, nelle professioni più ingrate e peggio retribuite. A questo punto ci sembra opportuna qualche considerazione più generale: il progresso della scienza e della tecnica è patrimonio di tutta l’umanità, e le sue conquiste non possono essere abbandonate alle leggi del profitto dell’imprenditore privato: esse debbono invece servire allo sviluppo dell’intera società umana. Noi sappiamo che quando il progresso tecnico-scientifico si accompagna allo sviluppo contemporaneo dei rapporti sociali di produzione, esso accelera il cammino della società: mentre avviene precisamente il contrario, se di esso se ne appropria il capitale, ponendolo al servizio della crescita del proprio profitto: ciò porta, infatti, ad uno sviluppo distorto, dannoso, che può spingere oggi l’intera umanità sulla via della catastrofe ecologica e della stessa distruzione atomica. È questo il grande tema che fa discutere oggi gli studiosi che guardano in avanti, verso il futuro. Di questo tema più generale, a noi interessa, qui, porre in rilievo le nuove contraddizioni che scaturiscono dal rapporto fra il progresso tecnico-scientifico (col conseguente aumento della produzione e della produttività) e l’occupazione operaia; e in questo quadro, esaminare le nuove caratteristiche che viene assumendo il fenomeno immigratorio, in tutti i paesi industrializzati, compresa la stessa Italia che è un tipico paese di emigrazione. Giorgio Amendola, nell’ormai famoso articolo pubblicato su ‘Rinascita’ (n. 43 del 9 novembre 1979), afferma in proposito che “non si può passare dalla meccanizzazione all’automazione senza accelerare la riduzione del numero degli operai occupati per giungere ad una determinata produzione”. Il problema è chiaro: si tratta di vedere da quale punto di vista se ne affronta la soluzione. Il rapporto preso in esame da Amendola riguarda il progresso tecnologico e l’occupazione; la produzione, per contro, rimane quella “determinata” (che generalmente — nonostante la “crisi” risulta ovunque in aumento); ma tale produzione di beni in aumento dovrebbe secondo certe tesi – provvedere ai mezzi di vita di un numero inferiore di operai, col licenziamento di una parte degli operai occupati. Tutto ciò per salvare, si dice, le aziende dalla crisi; ma dove andrebbero a lavorare e a mangiare gli operai licenziati, se tutte le industrie che si rinnovano licenziano una parte degli operai occupati? Chi si preoccupa di salvare dalla crisi gli operai occupati e a dar lavoro ai giovani disoccupati che aumentano ogni giorno di più? Nella storia e nel pensiero dei grandi maestri del movimento operaio si è sempre indicata come conseguenza naturale dell’aumento della produttività la diminuzione proporzionale dell’orario di lavoro e non la diminuzione dei lavoratori occupati. In verità, si parla molto di crisi sorvolando spesso sulla diversa incidenza nei confronti dei differenti strati sociali, e approfondendo poco la sua stessa natura specifica. Tralasciando le considerazioni sul carattere strutturale della crisi che investe il sistema stesso in ogni aspetto della vita sociale, per quanto riguarda l’attuale crisi economica, essa non colpisce i livelli di produzione, e neppure i saggi di profitto del capitale, se è vero, com’è vero, che da quando si parla di crisi! la Fiat ha dato ogni anno ai suoi azionisti i dividendi più elevati, da decenni in qua. Non si tratta neppure di una crisi dei consumi, poiché il mercato tiene benissimo; per cui, se guardiamo le statistiche, le sole cifre in rosso riguardano l’occupazione operaia nei settori del lavoro produttivo. Ciò denuncia chiaramente che l’attuale crisi nasce dalla contraddizione crescente fra il progresso tecnico-scientifico e il mancato sviluppo dei rapporti sociali di produzione. I dati riguardanti la caduta costante e generalizzata dell’occupazione nei settori dell’agricoltura e dell’industria, i settori, cioè che producono la nuova ricchezza, rappresentano, secondo noi, gli indici più illuminanti per spiegarci i processi in atto. Questi dati ci dicono che nel corso del decennio 1967-1976, gli addetti ai due settori primari dell’economia sono diminuiti in tutti i grandi paesi industrializzati: negli Stati Uniti d’America, sono passati dal 39,0 al 32,7 per cento; analoga riduzione, nei decennio 1966-1975, hanno registrato anche la Gran Breiagna – dal 49,8 al 43,4 per cento; la Francia dai 56,3 al 49,8; la Germania occidentale dal 59,3 al 53,3; la Svizzera dal 60,7 al 52,7; e infine l’Italia, nel decennio 1968-1977, dal 66,0 ai 53,6 per cento (vedi “Emigrazione” n, 1/1979). La riduzione degli addetti al lavoro produttivo non ha ridotto la produzione reale, che risulta ovunque aumentata, ma ha ridotto la forza di classe direttamente antagonista del capitale, che ha come obiettivo primario, proprio la sua riduzione per smorzare le spinte rivoluzionarie per il cambiamento del sistema medesimo, che è pure responsabile della crisi. Per contro, risulta ovunque in espansione, nello stessa periodo, il settore terziario, che riguarda i servizi e la distribuzione della ricchezza prodotta dagli altri due settori, in campo interno e in campo internazionale. Questo terzo settore non produce direttamente dei beni, ma attraverso i cosiddetti scambi ineguali consente al capitale di accumulare enormi profitti, con l’impoverimento del contraente più debole. Una larga parte di questo terzo settore non fa parte del lavoro dipendente, ma della piccola e media borghesia, che sul piano dei rapporti sociali, fornisce all’alta borghesia la base di massa dei consensi che la fa arbitra del potere. Pertanto, se la tendenza dell’occupazione chiaramente indicata dai dati degli ultimi decenni nei vari settori produttivi, sarà confermata, com’è prevedibile, anche in futuro, con un rapporto, quindi, divergente fra il lavora produttivo dei due settori primari, e il lavoro, utile ma improduttivo del terziario, noi potremmo avere in ciò, sul piano economico-sociale, il meccanismo per assicurare la riproduzione del sistema, che potrà mantenere il controllo sociale sulla classe operaia, attraverso la costruzione di una società, che a somiglianza delle società schiavistiche dell’antichità, restringe il lavoro produttivo nell’ambito di una ristretta minoranza di produttori, che per il ruolo subordinato ad essa assegnato, sia dal potere di comando del capitale che dalle esigenze tecnologiche dei moderni apparati produttivi, verrebbe inevitabilmente ad assumere i caratteri di una dipendenza schiavistica, per quanto dorata potrebbe esteriormente sembrare. A tutto ciò si aggiunge, oggi, l’altro importante elemento della strategia del capitale, che decentra nei paesi “in via di sviluppo” le produzioni a bassa composizione organica di capitale e ad alta intensità di lavoro. Ciò gli consente di ottenere immediatamente dei profitti più elevati, per il costo inferiore della manodopera colà impiegata; ma gli consente altresì di ridurre numericamente la classe operaia metropolitana, che può contestare alla borghesia la funzione di classe dirigente della società. L’esempio della Svizzera, ove operano le più potenti multinazionali, è particolarmente significativo: già nel 1977, la percentuale dei lavoratori occupati all’estero, sugli effettivi totali delle sue imprese principali, era il seguente: nella chimica il 71,5% (!); nella metallurgia e meccanica il 56,2%; nell’industria della carta il 38,2; nelle costruzioni il 27,2; e nella tradizionale orologeria il 18,3%. Con tale decentramento, la Svizzera ha potuto rimandare ai propri paesi d’origine oltre 300 mila lavoratori stranieri, operando fra essi una rigorosa selezione, ai fini stessi del controllo politico della classe operaia nazionale. Questo, dunque, il grande disegno strategico della borghesia per modificare a proprio vantaggio il rapporto sociale: ridurre e dividere la classe operaia metropolitana anche col decentramento di determinate produzioni all’estero; ciò dovrebbe assicurarle la riproduzione del capitale e dei rapporti sociali dell’attuale sistema, con una pianificazione capitalistica della produzione e dell’accumulazione dei profitti che agevoli il controllo globale della classe operaia, sia all’interno che all’esterno del paese. La funzione della nuova emigrazione E qui viene la funzione assegnata alla immigrazione, che pure ridotta, mantiene la sua importanza strutturale nel disegno strategico della borghesia. Sia per ragioni economiche che per ragioni politiche, le classi dirigenti dei paesi industrializzati non possono più fare a meno del lavoro immigrato: per ragioni economiche, essi hanno, intatti, bisogno di una certa aliquota di lavoro immigrato per coprire anzitutto i vuoti nelle professioni disertate dai lavoratori locali, e per servirsene in generale nella funzione di “esercito industriale di riserva”; ma non meno importanti sono le ragioni politiche: il trattamento differenziato riservato al lavoro immigrato genera un’oggettiva concorrenza fra lavoratori nazionali ed immigrati, dividendo, quindi, e indebolendo, sul piano sociale, l’intera classe operaia, com’è interesse del padronato. Esso, pertanto, non può rinunciare all’immigrazione, anche in presenza di una forte disoccupazione di manodopera locale; ma nello stesso tempo che promuove l’afflusso di manodopera straniera, anche attraverso i canali clandestini, esso alimenta e finanzia le periodiche campagne xenofobe che generano rancori e divisioni nel seno medesimo della classe lavoratrice. Ciò avviene, oggi, anche in Italia, tipico paese di emigrazione. La recente scoperta di una consistente immigrazione di manodopera straniera, che conta già diverse centinaia di migliaia di unità lavorative, ha sollevato ultimamente particolare clamore: il loro impiego nelle mansioni più umili risulta altrettanto giustificato dalla diserzione della manodopera locale, per quanto scandaloso è il trattamento loro riservato. Ed è proprio questa atipica immigrazione in Italia, e il trattamento ad essa riservato, nonostante sia da noi in vigore uno ‘‘Statuto del Lavoratore”, che non può, tuttavia, tutelare questi lavoratori ‘clandestini’ ingaggiati sul ‘mercato nero” della manodopera, che ci fa riflettere sulle nuove caratteristiche delle immigrazioni odierne di lavoratori stranieri nei paesi industrializzati. In questi paesi, le medesime esigenze del progresso tecnico-scientifico hanno promosso, in questi ultimi lustri, la più diffusa scolarizzazione, con la divulgazione delle conoscenze tecnico-professionali richieste per l’impiego nei più moderni apparati produttivi; ma ciò stesso determina comprensibilmente – nelle più giovani generazioni che si presentano sul mercato del lavoro – un atteggiamento di rifiuto verso le professioni ingrate, che sullo stesso piano tecnico non si sono rinnovate, e sono socialmente poco stimate. Deriva da ciò la promozione di immigrazioni più o meno ‘‘clandestine’’ di forze-lavoro provenienti da paesi più arretrati, ove i lavoratori hanno salari inferiori, per cui i nuovi immigrati accettano di buon grado di coprire gli impieghi lasciati vacanti dalle forze-lavoro locali, trovando persino conveniente il trattamento loro offerto, in quanto fanno il confronto, per lo meno nei primi tempi, con quello lasciato nel proprio paese d’origine. Oggettivamente, però, questo trattamento differenziato pone questi lavoratori in concorrenza con i locali, e può suscitare in questi ultimi dei sentimenti xenofobi. Ciò si è verificato ovunque, anche negli altri periodi. La prospettiva di questa nuova immigrazione è di gran lunga diversa da quella dei periodi precedenti: essa non crea né ricchi coloni, né operai specializzati, ma semplici sguatteri, scopini, uomini di fatica per i lavori più pesanti e dequalificati: nella stessa Svezia, che portiamo ad esempio per tanti altri aspetti positivi, le statistiche ufficiali registrano una prevalenza di addetti stranieri proprio nelle industrie più pesanti e nelle miniere – nella proporzione del 42,0% di stranieri contro il 24,6% di addetti svedesi; oppure nell’industria alberghiera – col 14,57 di stranieri contro il 13,8% di svedesi, che naturalmente hanno mansioni ben diverse dei primi. In questa situazione, il primo e più importante problema che si pone, per la tutela dei lavoratori immigrati, è quello della conquista da parte loro dei principali diritti civili, a cominciare dal diritto di residenza, sino a quello di parità di trattamento in ogni aspetto del rapporto di lavoro. Se fossero lasciati senza diritti, come sono oggi le centinaia di migliaia d’immigrati in Italia, alla mercé del ricatto padronale e della legge fascista del 1924, con la spada di Damocle dell’espulsione permanente sul capo, essi si troverebbero in condizioni peggiori dell’antico schiavo, che rappresentava pure un capitale per il padrone, il quale aveva, pertanto interesse a trattarlo bene, per conservarlo efficiente il più a lungo possibile. In seguito alla crisi petrolifera e alle trasformazioni cui abbiamo accennato sopra, in tutti gli Stati dell’Europa occidentale si è venuta manifestando la tendenza a peggiorare le legislazioni già esistenti sulle immigrazioni: ne ha dato per primo l’esempio il Prima ministro francese Barre, seguito dai suoi colleghi comunitari e non-comunitari (in Belgio come ultimamente in Olanda, nei laender della Germania occidentale come nel Cantoni elvetici, e nella stessa Svezia, ove il governo liberale ha in programma di modificare la precedente legislazione laburista, ritenuta troppo favorevole per gli immigrati). Se nella Germania federale dovesse vincere la Democrazia Cristiana di Strauss sarebbe adottata la “rotazione quinquennale” obbligatoria per tutti i lavoratori stranieri. L’unica schiarita, nell’addensarsi di tante nubi minacciose, ci viene oggi dal mondo sindacale, che nei decenni scorsi era stato pur’esso refrattario nei confronti dell’immigrazione straniera. Nell’ultimo congresso della Confederazione europea dei sindacati (Ces) una delle risoluzioni Finali si sofferma specificamente sulla condizione dei lavoratori immigrati, per i quali chiede “il multilaterale superamento delle ineguaglianze tuttora esistenti in Europa”, per farne “dei cittadini a pieno titolo”. Essa denuncia, poi, chiaramente come “nella maggior parte dei nostri paesi, gruppi di lavoratori – uomini e donne – sono ogni giorno vittime di discriminazioni di ogni genere. Essi sono sottoposti ad incomprensioni, ineguaglianze, ingiustizie e al razzismo”; denuncia ancora la pratica sempre più diffusa del “traffico illegale della manodopera straniera”, e le condizioni dei lavoratori ‘‘clandestini’’ che dopo aver subito ricatti di ogni genere da parte del padronato meno scrupoloso, non di rado “vengono sottoposti a misure di espulsione, mentre i veri responsabili non vengono sempre perseguiti o puniti con il dovuto rigore”. La risoluzione riconosce, infine, che le stesse “leggi di certi paesi hanno un carattere discriminatorio nei confronti dei lavoratori immigrati”, Tuttavia, “preoccupata per le conseguenze economiche e sociali della crisi occupazionale in Europa” la Ces rivendica soltanto “che i sindacati dei vari paesi e la stessa Ces siano consultati permanentemente “nelle trattative interstatali, per gli accordi bilaterali e multilaterali sulla manodopera”, senza richiedere chiaramente l’abolizione di tutte le norme discriminatorie, che pure denuncia, o l’adozione di uno Statuto, con poteri di legge esecutiva, che rimuovendo le discriminazioni esistenti, riconosca a tutti i lavoratori immigrati la piena parità di diritti, che sola può garantire contemporaneamente anche i lavoratori locali. E proprio esaminando la nuova condizione in cui vengono a trovarsi i lavoratori immigrati, in seguito ai processi di ristrutturazione e alla crisi occupazionale, ed avendo insieme presente che tale occupazione viene sempre più identificandosi col “lavoro nero” in espansione, che può rilevarsi tutto il valore e insieme l’imprescindibile necessità di una grande battaglia democratica per il riconoscimento dei diritti civili, sindacali e politici, che assicuri a tutti i lavoratori immigrati un trattamento paritario sia nel rapporto di lavoro che nella vita civile. E’ questo il tema generale dibattuto oggi dalle Associazioni degli immigrati stranieri in Europa, che pongono queste loro rivendicazioni come istanze emancipatrici dell’intero movimento operaio. Esse si articolano in quattro obiettivi principali: 1) la conquista di uno Statuto dei diritti del lavoratore emigrante, il cui testo è stato ripresentato, il 7 novembre scorso, al Parlamento europeo, insieme con una petizione popolare; 2) il riconoscimento della ‘‘cittadinanza europea’’, a tutti coloro che risiedono stabilmente in un paese della Comunità, da almeno due anni; 3) la partecipazione al voto europeo, in riconoscimento del contributo dato col loro lavoro al progresso del paese ospite e nell’insieme a tutta la Comunità europea; 4) la partecipazione al voto comunale ed altri enti locali o previdenziali, come diritto acquisito attraverso il pagamento di imposte e contributi, al pari dei lavoratori locali. Dal riconoscimento di questi diritti hanno da guadagnarci tutti, tranne gli sfruttatori che fanno affidamento proprio sulla concorrenza fra lavoratori immigrati e locali, per dominare gli uni e gli altri: solo la parità di trattamento potrà garantire entrambi, rafforzando la solidarietà operaia e la stessa azione sindacale unitaria per le comuni conquiste. E’ questo, oggi, il traguardo del Comitato Europeo dell’emigrazione, che coordina l’azione delle Associazioni nazionali di immigrati che hanno partecipato al Congresso di Torino: verso tale traguardo sono orientate, inoltre, le organizzazioni democratiche di tutti i paesi interessati, e formalmente anche i sindacati europei. Ma dal riconoscimento formale occorre ora passare all’unità d’azione, che faccia scaturire le iniziative più appropriate e le lotte democratiche più incisive per vincere le resistenze interessate dei Governi e battere la speculazione padronale che gioca tuttora sulla divisione dei lavoratori, trovando nell’unità di lotta di tutto il mondo del lavoro la forza necessaria per portare alla vittoria la giusta causa dei lavoratori immigrati e della solidarietà operaia. 1) – Ha origine, ed è oggi costantemente aggravata da questi “scambi ineguali” la divisione del mondo in ricchi e poveri, in sfruttati e sfruttatori, che fa prospettare nel futuro, l’Apocalisse di cui ha parlato Fidel Castro come Presidente dell’organizzazione dei Paesi del Terzo Mondo, alla ultima Assemblea dell’ONU, nel settembre scorso (1979, ndr). 2 – La Fiat, per esempio, produce i motori della “127” negli stabilimenti del Brasile e dell’Argentina, pagando gli operai locali con salari di gran lunga inferiore a quelli degli operai della Mirafiori, che montano, però, gli stessi motori, sulle vetture prodotte in Italia. Paolo Cinanni