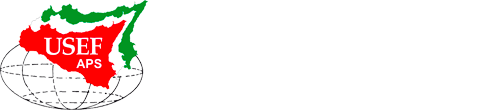IL “CAREGHETA”: L’ARTE DI IMPAGLIARE LE SEDIE, DEL LAVORO E DEL SACRIFICIO I seggiolai segnano un’epoca nella nostra provincia e oggi possiamo saperne di più attraverso la voce di Elio Da Rozze, classe 1941. Originario di Rozze, paese fantasma dall’alluvione di California del 1966. Valigia sempre in mano, Elio ha lavorato in mezzo mondo: Canada, Scozia, Corea
IL “CAREGHETA”: L’ARTE DI IMPAGLIARE LE SEDIE, DEL LAVORO E DEL SACRIFICIO I seggiolai segnano un’epoca nella nostra provincia e oggi possiamo saperne di più attraverso la voce di Elio Da Rozze, classe 1941. Originario di Rozze, paese fantasma dall’alluvione di California del 1966. Valigia sempre in mano, Elio ha lavorato in mezzo mondo: Canada, Scozia, Corea

(costruzione dello stadio per le olimpiadi del lontano 1988). Poi Israele e altri posti ancora A Belluno ha contribuito alla costruzione della nostra A27. Lavoro duro sempre in cantiere, ma nel cuore il primo lavoro da “scraner”. O “caregheta”. Queste sono le sue parole Quando ero ragazzo, i miei genitori mi hanno mandato presto al lavoro: avevo solo quattordici anni. Era il 1956, mamma casalinga e papà lavorava alla Sade, otto figli da crescere. Una realtà di montagna dura da vivere: un maiale, una mucca e una gallina non potevano bastare per crescerci tutti. La terra di montagna dava patate, fagioli e qualche zucca: tanta fatica e poco con cui vivere. Sono così partito, o meglio, mi hanno mandato. Ho lasciato la montagna, non senza rimpianti e con lei gli amici di scorribande. La mia prima meta fu l’Emilia Romagna: Castel San Pietro, Faenza. Il primo “padrone” così si chiamava, perché alla fine ti possedeva e ti faceva fare di tutto, era del mio paese e mi portò con lui. Non importava se conosceva la mia famiglia: il trattamento che mi spettava era quello di un estraneo, quasi schiavo. C’erano episodi di violenza, verbale e non solo, quando ti insegnavano il lavoro di impagliatore e tu non eri ancora esperto. La pazienza? Semplicemente non esisteva. A tavola i bocconi di cibo più buoni erano i suoi, a me restavano le botte se non capivo cosa ordinava per pranzo. Oppure mi lanciava qualche attrezzo del mestiere. Vita dura per un ragazzo e non potevi chiamare la mamma in soccorso. Si partiva con la “craz”, una specie di gerla che conteneva la cassetta degli attrezzi: la “feraza”. La paglia non poteva mancare, come i vari pezzi per assemblare sedie e sgabelli, dipendeva dalla commessa. Ho imparato pian piano e non senza qualche ceffone a impagliare e usare il seghetto, il trapano a mano e i coltellini. Mi consolava il fatto che c’erano altri ragazzi nella mia condizione: con il tempo abbiamo imparato a parlarci attraverso una lingua nostra per non farci capire dal padrone. Il mezzo di trasporto era la bicicletta: pioggia o freddo, non importava molto. Con la bici arrivavamo nel paese destinato e andavamo al mercato. Lì trovavamo i contadini con la merce esposta, ma i clienti più ricchi ci chiamavano: «Scaner, scaner o caregheta!». Ci ordinavano il numero di sedie o di sgabelli di cui avevano bisogno e con l’indirizzo in un pezzo di carta, il pomeriggio andavamo a casa loro. Ci mettevamo fuori nella corte, con tutto l’occorrente e cominciavamo il lavoro. A volte le sedie erano solo da impagliare, altre volte invece da costruire ex novo. Quindi il lavoro principale era andare per boschi a cercare il legno giusto, tagliarlo e aspettare si essiccasse a casa del committente di turno, generalmente ricchi contadini. Grazie a loro sì che si mangiava bene! Si lavorava dall’alba al tramonto: sempre sotto l’occhio vigile del padrone. La cameretta? Un fienile, ovviamente così come eravamo: vestiti e senza doccia. Finito il lavoro, il padrone ci pagava e cambiavamo paese sempre in bici. Quanti chilometri, quante strade, quanta fatica! Nel tempo ho cambiato tanti datori di lavoro e non tutti sono stati cattivi con me, anzi, alcuni pagavano bene. Ogni tanto tornavo a casa, soprattutto l’inverno e portavo a casa i soldi per aiutare mamma e papà. Poi sono cresciuto: il militare, l’incontro con mia moglie e i figli. Conservo ancora ricordi di me seduto su un marciapiede a impagliare e la cassetta degli attrezzi, la mia ”feraza”. Oltre agli attrezzi del lavoro da caregheta, custodisco i momenti duri che ho passato ragazzino, solo in un mondo di grandi. Non è stata facile la vita da “caregheta”, ma mi ha insegnato il senso del sacrificio. Elio Da Rozze