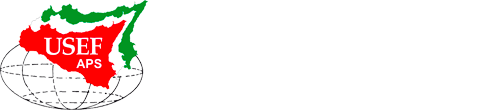Il Siciliano di una volta conservava anche nell’età matura, un temperamento spontaneo, vicino alla natura, senza sotterfugi, con trasporti di generosità e gelosie, gioie e dolori, allegrie e tristezze, rancori e perdoni, amori ed odi, come solo i ragazzi possono fare.
Il Siciliano di una volta conservava anche nell’età matura, un temperamento spontaneo, vicino alla natura, senza sotterfugi, con trasporti di generosità e gelosie, gioie e dolori, allegrie e tristezze, rancori e perdoni, amori ed odi, come solo i ragazzi possono fare.
Per il suo carattere focoso, amava con tutta l’anima ma odi implacabili si tramandavano da padre in figlio per diverse generazioni, con conseguenze anche delittuose. Le scene cavalleresche, rappresentate nell’ “Opra di li pupi” sono l’espressione del suo carattere e delle sue virtù. In una civiltà arcaica contadina e maschilista, il fuoco passionale lo rendeva geloso della sua donna e dell’onore. Per questo motivo il termine d’offesa più grave per un Siciliano è la parola “curnutu”. I delitti d’onore erano molto comuni; anche la legge si rendeva partecipe di questa realtà storica e concedeva un’attenuante al colpevole di un tale delitto. Infatti, per lavare l’onta dell’onore offeso, non bastava una condanna giudiziaria, l’onore si poteva lavare solo col sangue; vendicare l’onore offeso era un dovere che la natura, la società e Dio stesso prescrivevano. Cesare Abba, che cito spesso, nelle sue “Noterelle sulla Sicilia del 1860” scrive:- “...siamo in paesi dove la donna è cara più della vita, più della libertà.” La donna, di solito casalinga, dipendeva completamente dal padre o dal marito; i figli maschi, fino a quando partivano per il servizio militare o si sposavano, dipendevano dalla volontà del padre. “Li picciotti” non avevano nessun diritto a parlare o a protestare nei riguardi delle persone adulte; addirittura il fratello più piccolo doveva ubbidire a quello più grande e gli doveva dare anche del “vossia”. Un proverbio in merito diceva:- “Li picciotti hannu a parlari sulu quannu piscia la addina”, cioè mai. A tavola la divisione dei cibi spettava al “padrone di casa” che, spesse volte, seguendo la legge istintiva della natura, prendeva per sé la parte migliore e più abbondante, dava la parte buona e sufficiente ai figli maschi ed infine quelle peggiori e più piccole alle donne. Questa realtà storica è confermata da questa strofa, che diceva:- “Sugnu patri e sugnu patruni (sono padre e sono padrone) aiu tortu e vogghiu raggiuni” (ho torto e voglio ragione). Eppure, “patruni e domini” (come si diceva nelle nostre parti) o “padre padrone” (come l’ha definito in Sardegna Gavino Ledda), aveva un comportamento cavalleresco nei riguardi della donna (vedi “fimmina di casa”). Il Siciliano era un “omu di panza” perché, per una serie di circostanze storiche e ambientali doveva e sapeva trattenere per sé i segreti. L’omertà, era quasi innata; non perchè prediligeva un delinquente assassino, ma per paura di ritorsioni, per il quieto vivere, per amore della sua famiglia e, principalmente, per non avere rapporti con la giustizia e gli “sbirri”, per i quali aveva paura ed orrore. I discorsi dei siciliani erano fatti in rigoroso dialetto del posto e con poche parole; si usavano moltissimo i proverbi, le metafore, “lu pizzicuneddu” (il diminutivo e il vezzeggiativo), e le frasi idiomatiche. Molto espressiva, ad esempio, era la frase: “Si iuncìa la testa cu li peri” (si univa la testa con i piedi - si piegava in due) per dire che soffriva di un forte dolore allo stomaco. “Ci voli assai pi sapiri picca” (ci vuole molto per sapere poco) in questo solo proverbio c’è racchiusa tutta la saggezza di un popolo. Così in ogni discorso od occasione citava un proverbio, che calzava sempre a pennello. Spesso nei suoi discorsi, per affermare o negare, si limitava solamente a dire “ora si” oppure “ora no” o addirittura abbassava solamente la testa o l’alzava dicendo “nzu”. Egli, inoltre, a causa dell’analfabetismo e dei pochi vocaboli a sua disposizione, per farsi capire più facilmente si aiutava molto con i gesti delle mani, con la mimica del viso e, principalmente, con gli occhi. Questi occhi vivi, intelligenti e scrutatori hanno impressionato E. De Amicis che, nel suo libro  “Ricordi di un viaggio in Sicilia”, così cita testualmente: -“...così profondi, così acutamente scrutativi, così pieni di sentimento e di pensiero...”. La gestualità era sorta in un lontano passato anche per la necessità di comunicare con i numerosi popoli del Mediterraneo, diversi per lingua e civiltà, con cui allacciava rapporti commerciali, ma anche per farsi capire dai numerosi conquistatori, che nel corso dei secoli hanno conquistato la Sicilia. Noi non ci accorgiamo di questa nostra complessità, se ne accorge chi viene da fuori. Vuiller Gastone, pittore e scrittore francese nel suo libro “La Sicilia” 1897, così scrive: “…finanche i fanciulli si esercitano fin da piccini in questo singolare linguaggio; Si pretende che questa abitudine di comunicare per mezzo di gesti cominciasse a Siracusa ai tempi del tiranno Dionigi.” Il Pitré, che si era fatto amico del Vuiller, parlando della mimica dei siciliani così scrive: non pochi viaggiatori si sono meravigliati. Dalla più lieve impercettibile vibrazione dei muscoli della faccia, a tutto un movimento del capo e delle mani, questo muto linguagio esprime sentimenti, affetti, volontà, che sfuggono ai forestieri. Coi gesti si afferma, si nega, si comanda e si ubidisce, si dispone e si esegue, si prega e si concede, si chiama e si risponde, si loda e si biasima, si carezza e si disprezza fino a comporre interi discorsi. Ogni popolo ha caratteristiche proprie, anche quando se ne sta in piazza a discutere o a guardare la gente che passa. Un giornalista Svedese una volta mi fece notare che noi Siciliani, stando fermi in piazza a parlare con amici, teniamo le spalle appoggiate al muro e, spesse volte, con una gamba rivolta verso il dietro e con la pianta del piede appoggiata al muro. Se guardiamo i prospetti degli edifici nella piazza dove abitualmente ci fermiamo a discutere, si nota all’altezza di 30 – 40 cm. l’impronta oscura della suola di scarpa. I Tunisini, ad esempio, si vedono facilmente accovacciati sulle loro gambe o seduti sui gradini dei portoni. Nella nostra società quando una persona prende delle iniziative, anche di un certo valore, diventa oggetto di critica gratuita da parte di tutti; una critica distruttiva, mai costruttiva. Seduti comodamente al bar oppure al circolo ricreativo, fra un caffè ed una partita a carte si aggiusta l’Italia: “Si fussi sinnacu... Si fussi prisirenti di lu cuvernu ...” Un vero siciliano si sentiva d’essere “omu” e portava in sé altissimo il senso dell’onore per la famiglia, per la sua donna e, principalmente, per la parola data: preferiva morire, che venire meno alla sua parola. La parola data, secondo la concezione arcaica, resta scritta col sangue nell’onore. Spesse volte i contratti erano sigillati da una stretta di mano: “Cca la manu, l’affari è fattu”; seguiva immancabilmente una promessa, seguita da: “Parola d’onuri”. Purtroppo, anche allora, c’erano persone, che si vantavano d’essere “omini d’onuri”, ma solo a parole. A comprova, un proverbio diceva: “Genti assai ma omini picca”. Costoro, però, erano additati da tutti e perdevano la stima e l’attendibilità alla sua parola. Inoltre, un “omu veru”, che si comportava come tale, parlava poco e mai di cose inutili, inoltre non rideva mai. Quando voleva dare un consiglio ad un amico o accusare una persona di qualcosa senza volerlo offendere, parlava con allusioni e discorsi più o meno velati, che bisognava capire, faceva riferimento a casi simili successi o sentiti raccontare da terze persone assolutamente non nominate: “si dici lu piccatu, no’ lu piccaturi”; intanto, mentre parlava diceva fra sé: “Cu avi aricchi mi senti”. Durante la civiltà contadina e fino agli anni ’50 il tempo entro cui scorreva l’esistenza della gente, sembrava fermo. Nel fare la spesa il negoziante, che spesse volte era donna, chiacchierava con gli acquirenti: parlava del tempo, della raccolta delle ulive, della vendemmia, s’informava dei fatti di famiglia; si trattava anche di un ricco patrimonio di calore umano oggi scomparso. Nel comportamento del siciliano c’era tutto un modo d’essere, derivato dalla stratificazione delle varie culture, acquisite dai vari popoli conquistatori, che si sono succedute e sovrapposte nel corso dei secoli, fuse integralmente e armoniosamente amalgamate. Il contadino siciliano era un gran lavoratore, frugale nei cibi, lontano dai vizi cittadini, rispettoso, onesto e religioso fino alla superstizione; inoltre, diffidente, furbo, egoista e vendicativo. Se capiva di essere stato preso in giro, reagiva con violenza e ferocia. Classificato all’ultima fascia della scala sociale, egli, esposto a tutte le intemperie, lavorava più di ogni altro lavoratore, guadagnava di meno, e veniva appellato con termini poco civili: “zuardu, testa di sceccu, testa di lignu, viddanu, panturru, zurbu”. In realtà, nonostante l’analfabetismo, fra i contadini esistevano molti poeti, che sapevano improvvisare poesie; molte canzoni popolari, ancora famose, furono elaborate da contadini. La letteratura popolare siciliana è ricca di poesie, canzoni e racconti. Voglio solo citare, affinché non venga dimenticato, un libro di racconti siciliani del contadino castelvetranese Berto Giambalvo, con trascrizione e traduzione di Franco Di Marco. Si tratta di storielle molto spiritose che il Giambalvo, in precedenza, aveva raccontato solo ai suoi amici. Con la sua cultura ed il suo animo generoso, il Siciliano ha insegnato al mondo, bagnato dal sangue degli odi razziali e religiosi, cosa significa la pacifica convivenza e il rispetto fra genti di diverse razze e religioni. Questo insegnamento continua più che mai ai nostri giorni in maniera veramente silenziosa: in questa terra di Sicilia, ricca soltanto di disoccupazione e sottosviluppo, c’è sempre posto per i nostri fratelli immigrati dal terzo mondo, che rischiano la loro vita, per cercare qui quel lavoro e quel rispetto per la persona umana, mai trovato nella loro patria. Nessuno di noi si è mai permesso di pensare lontanamente o di dire: “Buttiamoli a mare” oppure “usiamo la legge nazista!” (come invece hanno detto, in questi ultimi anni, insigni uomini politici dell’Italia settentrionale). Il popolo siciliano nel corso della sua storia ha subito ben tredici dominazioni straniere, tuttavia non si è fatto sottomettere culturalmente. Da questi popoli, infatti, ha saputo acquisire il meglio della loro civiltà, selezionando quelle conoscenze che si confacevano alla sua cultura dotta e popolare. Infatti, ha saputo conservale la propria identità che comprende l’intelligenza, la diffidenza, l’umorismo, l’arte di arrangiarsi; come pure non ha perso il senso del valore per la famiglia e dell’onore, l’amore e il rispetto per i morti, per gli anziani, per i genitori, la sacralità per l’amicizia, il senso della cavalleria per le donne. Si tratta di un ricchissimo bagaglio di comportamenti che si porta dietro da secoli e nessuna dominazione straniera ha potuto intaccare. La Sicilia, fino a quando conserverà tale identità, le sue tradizioni e la propria memoria storica, non sarà mai un paese vinto. Nella storia spirituale plurisecolare della Sicilia si trovano le radici dell’animo popolare; in essa si trovano e si intrecciano fantasia e realtà, mondo pagano, musulmano e cristiano, superstizioni e scetticismo, volgarità e cavalleria, l’attruvatura e il fatalismo, mondo antico e mondo moderno. Ciò costituisce il folclore della Sicilia, inteso non come un’attrazione turistica o come un elemento ornamentale, ma il modo di vivere stesso della popolazione. Nei nostri canti popolari e in quella dei carrettieri si sente la cantilena araba. Il senso della cavalleria, uno dei sentimenti più delicati che ci caratterizza, è stato portato dai Normanni e si è fortemente radicato nel nostro animo. L’opera dei pupi, il canto del carrettiere e del cantastorie, la recita del “cuntastorie”, le scene cavalleresche raffigurate con decorazioni artistiche nei carri siciliani, sono altri esempi della civiltà lasciati dai normanni e ben assimilati dai nostri avi. Il ricordo delle lotte sostenute dai normanni contro gli arabi è tuttora vivo nell’annuale combattimento che si svolge per la festa della Madonna delle Milizie a Scicli o per la festa dell’Assunta a Piazza Armerina o per quella del Taratatà che si svolge a Casteltermini in occasione della festa di Santa Croce. Nelle chiese, l’antico rito greco bizantino imponeva la separazione dei sessi. Le navate erano divise da transenne di legno: le donne stavano sedute a sinistra, gli uomini a destra. Questa consuetudine è continuata fino a qualche decennio fa. L’economia della civiltà contadina, era condizionata dalla disoccupazione e dal raccolto sempre incerto, perché vincolato al buono ed al cattivo tempo. Da qui nasce il morboso attaccamento alle poche ricchezze possedute. “La robba” (spesso solo sognata) era considerata la sola ancora di salvezza, il toccasana per ogni male, una realtà incontrastata a cui il siciliano sacrificava l’intera sua esistenza. Ne scaturiva, pertanto, una corsa affannosa, ma di solito infruttuosa, ad accumulare beni. Per il contadino di allora, l’uomo e la sua vita non avevano nessun valore, solo la terra contava ed aveva un valore: “Lu patri si nni va la robba arresta” (L’uomo può morire, la terra no, essa non deve essere mai abbandonata). Per questa concezione della vita e della morte molti “picciotti” sono stati spinti a seguire con entusiasmo Garibaldi per scacciare i Borboni. Garibaldi, infatti, aveva promesso di dividere fra i contadini la terra dei latifondisti, incolta e abbandonata. Vincenzo Consolo in Pietre di Pantalica così descrive i contadini durante lo sbarco degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale: “...pastori e contadini. Immobili, logori come la terra su cui stavano, piegati con le zappe a rompere la crosta, sembrano indifferenti alle colonne di carri armati, alle truppe che passavano sulle trazzere bordate d’agave e di rovi, indifferenti a questa guerra che si svolgeva accanto a loro. Indifferenti e fermi lì da secoli sembravano; spettatori di tutte le conquiste, riconquiste, invasioni e liberazioni che in quel teatro s’erano giocate. E sembrava che la loro guerra fosse un’altra, millenaria e senza fine, contro quella terra d’altri, feudi di baroni e soprastanti, avara e avversaria, contro quel cielo impossibile e beffardo”. Intorno agli anni ’50, la classe contadina rappresentava la parte più sana della popolazione, perchè la così detta civiltà li aveva appena sfiorati. Essi erano rozzi e superstiziosi, ingenui ma grandi lavoratori che conservavano ancora i costumi e le tradizioni degli avi. I vecchi, in particolare, anche ai nostri giorni costituiscono una fonte inesauribile di remote conoscenze. In questo scenario antico, i personaggi sono deboli, limitati da molti elementi ostili quali l’ambiente, le tradizioni, il bisogno e la volontà inutile di liberarsene. I “vinti” di G:Verga sono stati sempre presenti nel palcoscenico siciliano. Sempre per la stessa ragione, l’incerto futuro ha dato un senso d’apprensione e di paura; forse a causa di ciò nella grammatica siciliana e nel parlare corrente non si usa il futuro. Per dire ad es. domani andrò, si dice: domani vado. Invece, molto usato è il passato remoto; per dire ad es. poco fa ho visto, si dice: “antura vitti” (poco fa vidi). Anche per la casa, spesso costituita da una sola stanza, dove la famiglia coabita con l’asino e le galline, c’è un morboso attaccamento, perché qui sono nati e cresciuti i propri avi, i cui “ritratti” sono appesi al muro quasi dei santi protettori. La famiglia e la casa, per le persone più povere, rappresentavano il fulcro, attorno al quale giostravano tutti gli altri interessi della vita. Tutto ciò che non interessava direttamente la propria famiglia, poco li riguardava, Si diceva, infatti: “Casuzza to, fuculareddu to” - “E’ la to casa chi ti strinci e ti vasa!” – “Casa mia, casa mia, tu sì reggia e sì batia!” – “Casa mia, matri mia!”. Possedere una casa, avere un tetto sotto cui ripararsi, e trovarvi ristoro tornando dal lavoro, era la massima ambizione di un lavoratore. Il contadino, in particolare, considera una grave disgrazia non poter morire nel suo letto fra le quattro mura di casa sua. Chi possedeva “un paru di casi” (una casa) poteva considerarsi veramente fortunato. E’ giusto chiarire che il vocabolo “paru” in siciliano ha un significato molto generico; infatti, può significare anche un oggetto divisibile in tante parti: “un paru di carti, un paru di forfici, un paru di scarpi, ecc. Un paio si dice “na para” oppure “na cucchia”. Dopo gli anni ’50, quando i figli incominciavano a lavorare e guadagnare, con i risparmi si cercava di costruire quattro mura per ognuno di loro, fabbricando sopra la casa esistente o dividendola in due (la mezza casa). Difficilmente coabitavano genitori e figli sposati; anche allora più di oggi esisteva la proverbiale discordia fra suocera e nuora. Tante volte le abitazioni a primo piano rimasero incomplete o chiuse, poiché nel frattempo i figli emigrarono all’estero. Il contadino, ma anche molti altri lavoratori, andava a letto “a la ntrabbunuta” o “a la cuddata di lu suli” (al tramonto del sole); “comu li addini” si diceva, poiché l’indomani mattina “a li sett’arbi” (ancora al buio) si dovevano trovare sul posto di lavoro, spesso lontano dal paese. La morte accompagnava i suoi pensieri nel corso della vita; morte intesa come castigo dei peccati commessi e come liberazione da questa vita grama, causata dai benestanti prepotenti, e subita con sdegno, rassegnazione e senso d’impotenza allo stesso tempo. Tuttavia, il ricordo dei propri avi, la nostalgia del passato, l’amore per la famiglia, per la casa e la terra, procuravano un maggiore attaccamento alla vita. Il suicidio, tanto di moda fra i moderni popoli del benessere, nel passato, da noi era quasi sconosciuto; la speranza di un domani migliore dava più carica per non arrendersi alle avversità. Il Siciliano ha avuto da sempre il culto dei morti e delle tombe. Dopo la morte, nella sua cultura non c’è il nulla eterno; il defunto, infatti, continua a vivere nell’aldilà, mentre i parenti viventi parlano di lui, “bon’arma”, in ogni occasione; continua così una “corrispondenza d’amorosi sensi” (direbbe il Foscolo) con l’estinto. Nell’argomento “la cattiva” ho già ampiamente trattato questo problema parlando del “repitu” e del lutto; nell’argomento “li picciriddi” ho parlato del due novembre come “la festa di li morti”. I nostri nonni si rivolgevano ai propri defunti per ottenere delle grazie; “li murticeddi”, riconoscenti, venivano spesse volte in sogno per accontentarli (vedi anche argomento “l’attruvatura”). La letteratura popolare siciliana è ricca di racconti dove si esalta la furbizia del contadino, che riesce a prendere in giro anche il diavolo. Oggi, lo sviluppo delle vie di comunicazione e dei mezzi d’informazione di massa, ha dato un impulso alla cultura ed al risveglio sociale; purtroppo ha provocato anche l’appiattimento dei pensieri fra i vari popoli. La globalizzazione, tanta esaltata e contestata, ha provocato in Sicilia la perdita della propria identità, del modo d’essere e di pensare, del folclore, della cultura, assorbendo invece quelli d’altri popoli. Una volta la vita offriva pochi svaghi e divertimenti anche per le persone benestanti. Il contadino, ma anche l’artigiano e l’operaio, sperava per l’incerto domani soltanto un poco di sicurezza. Un ragazzo sognava di raggiungere i 18 anni d’età, per potere frequentare le case di tolleranza, per andare militare e conoscere un poco l’Italia settentrionale ed il suo tenore di vita più elevato, quindi aprirsi una sua attività, svincolarsi dalla famiglia ed infine sposarsi. Per una ragazza chiusa in casa, perché così imponeva la civiltà maschilista, la sua unica aspirazione era il matrimonio con un uomo comprensivo, per potersi assicurare il mantenimento per tutta la vita, ed avere tanti figli. Allora, per una famiglia povera, la nascita di una femminuccia rappresentava un vero castigo di Dio; infatti, c’era una bocca in più da sfamare, una dote da preparare per il matrimonio e delle braccia in meno per il lavoro. Inoltre, un padre che aveva avuto solo figlie femmine, era disperato, perché con lui si sarebbe estinto il suo cognome portato con tanto orgoglio ed ereditato dai suoi avi maschi. In merito un proverbio diceva: - Cu bona reda voli fari, di figghia fimmina avi a cuminciari, ma all’annu nun ci avi arrivari. Cioè la nascita di una femmina, come primogenito, era un buon segno, purché questa muoia entro l’anno. Ho sempre sostenuto che noi Siciliani amiamo la nostra terra e il nostro modo di vivere più della stessa vita; tuttavia, disprezziamo il nostro comportamento ed esaltiamo quello d’altri popoli più evoluti. Secondo me, non siamo ammalati d’esterofilia, tale comportamento sorge dalla consapevolezza di essere un popolo potenzialmente ricco: per volontà, operosità, intelligenza, territorio, clima, ecc. e che tuttavia, a causa della burocrazia, dei cattivi amministratori e della mafia, restiamo sempre il fanalino di coda. Per la mancanza di lavoro, molti capi famiglia, con la morte nel cuore ed una rabbia repressa, emigrarono verso l’Italia del nord o all’estero fino alle lontane Americhe o all’Australia. Oggi, molti giovani figli del benessere, emigrano in cerca di un lavoro più redditizio (ma andando incontro anche ad un costo della vita più cara), perché ammalati di “aria del continente” (come direbbe il Martoglio). Scoprire nuovi orizzonti della vita è un istinto innato: “Nati non fosti a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” ebbe a dire Dante. Essi lasciano la propria terra, dove sono attaccate le proprie radici, per la voglia di fuga, di evadere, di cercare una nuova ragione di vita più giusta, più ricca anche culturalmente. Essi spesso si accorgono di trovare un mondo vuoto, frenetico che adora soltanto il Dio Denaro, privo di quella umanità e solidarietà che ancora si trova nei nostri piccoli paesi. Delusi e pieni di nostalgia ritornano al paese natio: troppo tardi! Il tempo, il cemento e la globalizzazione hanno fatto anche qui dei cambiamenti e non ritrovano più il proprio habitat che avevano lasciato. “Lu Signuri ti lu paa”, è una frase di ringraziamento, che una volta era molto usata da chi riceveva un aiuto, un favore. Oggi si direbbe “a buon rendere”, ma allora molte persone non avevano la possibilità di poter rendere, per cui si disobbligavano tramite l’intercessione del Signore. Per dare maggiore enfasi al proprio discorso, si usava ripetere più di una volta la stessa frase; per esempio: “ti ho detto di smetterla!” detto a voce alta e, continuando: “che ti ho detto di smetterla!” (con voce più bassa, ripetuta anche più volte). In queste poche pagine ho cercato di racchiudere tutta la cultura del popolo siciliano e di Castelvetrano in particolare. Una cultura che ci hanno lasciato i nostri avi, un bene prezioso, che ci consente di trovare le nostre radici e di capire che noi, posteri dei nostri antenati non stiamo più seguendo la strada che loro ci avevano spianata. Infatti, la moderna civiltà globalizzata ci induce a seguire culture straniere provenienti dal Nord e ad abbandonare quella nostra, quella dei nostri avi, quella che era una volta comune a tutto il Mediterraneo. Oltre a quelli già citati, ho trovato altri proverbi che riguardano la roba, la casa, il paese.
“Ricordi di un viaggio in Sicilia”, così cita testualmente: -“...così profondi, così acutamente scrutativi, così pieni di sentimento e di pensiero...”. La gestualità era sorta in un lontano passato anche per la necessità di comunicare con i numerosi popoli del Mediterraneo, diversi per lingua e civiltà, con cui allacciava rapporti commerciali, ma anche per farsi capire dai numerosi conquistatori, che nel corso dei secoli hanno conquistato la Sicilia. Noi non ci accorgiamo di questa nostra complessità, se ne accorge chi viene da fuori. Vuiller Gastone, pittore e scrittore francese nel suo libro “La Sicilia” 1897, così scrive: “…finanche i fanciulli si esercitano fin da piccini in questo singolare linguaggio; Si pretende che questa abitudine di comunicare per mezzo di gesti cominciasse a Siracusa ai tempi del tiranno Dionigi.” Il Pitré, che si era fatto amico del Vuiller, parlando della mimica dei siciliani così scrive: non pochi viaggiatori si sono meravigliati. Dalla più lieve impercettibile vibrazione dei muscoli della faccia, a tutto un movimento del capo e delle mani, questo muto linguagio esprime sentimenti, affetti, volontà, che sfuggono ai forestieri. Coi gesti si afferma, si nega, si comanda e si ubidisce, si dispone e si esegue, si prega e si concede, si chiama e si risponde, si loda e si biasima, si carezza e si disprezza fino a comporre interi discorsi. Ogni popolo ha caratteristiche proprie, anche quando se ne sta in piazza a discutere o a guardare la gente che passa. Un giornalista Svedese una volta mi fece notare che noi Siciliani, stando fermi in piazza a parlare con amici, teniamo le spalle appoggiate al muro e, spesse volte, con una gamba rivolta verso il dietro e con la pianta del piede appoggiata al muro. Se guardiamo i prospetti degli edifici nella piazza dove abitualmente ci fermiamo a discutere, si nota all’altezza di 30 – 40 cm. l’impronta oscura della suola di scarpa. I Tunisini, ad esempio, si vedono facilmente accovacciati sulle loro gambe o seduti sui gradini dei portoni. Nella nostra società quando una persona prende delle iniziative, anche di un certo valore, diventa oggetto di critica gratuita da parte di tutti; una critica distruttiva, mai costruttiva. Seduti comodamente al bar oppure al circolo ricreativo, fra un caffè ed una partita a carte si aggiusta l’Italia: “Si fussi sinnacu... Si fussi prisirenti di lu cuvernu ...” Un vero siciliano si sentiva d’essere “omu” e portava in sé altissimo il senso dell’onore per la famiglia, per la sua donna e, principalmente, per la parola data: preferiva morire, che venire meno alla sua parola. La parola data, secondo la concezione arcaica, resta scritta col sangue nell’onore. Spesse volte i contratti erano sigillati da una stretta di mano: “Cca la manu, l’affari è fattu”; seguiva immancabilmente una promessa, seguita da: “Parola d’onuri”. Purtroppo, anche allora, c’erano persone, che si vantavano d’essere “omini d’onuri”, ma solo a parole. A comprova, un proverbio diceva: “Genti assai ma omini picca”. Costoro, però, erano additati da tutti e perdevano la stima e l’attendibilità alla sua parola. Inoltre, un “omu veru”, che si comportava come tale, parlava poco e mai di cose inutili, inoltre non rideva mai. Quando voleva dare un consiglio ad un amico o accusare una persona di qualcosa senza volerlo offendere, parlava con allusioni e discorsi più o meno velati, che bisognava capire, faceva riferimento a casi simili successi o sentiti raccontare da terze persone assolutamente non nominate: “si dici lu piccatu, no’ lu piccaturi”; intanto, mentre parlava diceva fra sé: “Cu avi aricchi mi senti”. Durante la civiltà contadina e fino agli anni ’50 il tempo entro cui scorreva l’esistenza della gente, sembrava fermo. Nel fare la spesa il negoziante, che spesse volte era donna, chiacchierava con gli acquirenti: parlava del tempo, della raccolta delle ulive, della vendemmia, s’informava dei fatti di famiglia; si trattava anche di un ricco patrimonio di calore umano oggi scomparso. Nel comportamento del siciliano c’era tutto un modo d’essere, derivato dalla stratificazione delle varie culture, acquisite dai vari popoli conquistatori, che si sono succedute e sovrapposte nel corso dei secoli, fuse integralmente e armoniosamente amalgamate. Il contadino siciliano era un gran lavoratore, frugale nei cibi, lontano dai vizi cittadini, rispettoso, onesto e religioso fino alla superstizione; inoltre, diffidente, furbo, egoista e vendicativo. Se capiva di essere stato preso in giro, reagiva con violenza e ferocia. Classificato all’ultima fascia della scala sociale, egli, esposto a tutte le intemperie, lavorava più di ogni altro lavoratore, guadagnava di meno, e veniva appellato con termini poco civili: “zuardu, testa di sceccu, testa di lignu, viddanu, panturru, zurbu”. In realtà, nonostante l’analfabetismo, fra i contadini esistevano molti poeti, che sapevano improvvisare poesie; molte canzoni popolari, ancora famose, furono elaborate da contadini. La letteratura popolare siciliana è ricca di poesie, canzoni e racconti. Voglio solo citare, affinché non venga dimenticato, un libro di racconti siciliani del contadino castelvetranese Berto Giambalvo, con trascrizione e traduzione di Franco Di Marco. Si tratta di storielle molto spiritose che il Giambalvo, in precedenza, aveva raccontato solo ai suoi amici. Con la sua cultura ed il suo animo generoso, il Siciliano ha insegnato al mondo, bagnato dal sangue degli odi razziali e religiosi, cosa significa la pacifica convivenza e il rispetto fra genti di diverse razze e religioni. Questo insegnamento continua più che mai ai nostri giorni in maniera veramente silenziosa: in questa terra di Sicilia, ricca soltanto di disoccupazione e sottosviluppo, c’è sempre posto per i nostri fratelli immigrati dal terzo mondo, che rischiano la loro vita, per cercare qui quel lavoro e quel rispetto per la persona umana, mai trovato nella loro patria. Nessuno di noi si è mai permesso di pensare lontanamente o di dire: “Buttiamoli a mare” oppure “usiamo la legge nazista!” (come invece hanno detto, in questi ultimi anni, insigni uomini politici dell’Italia settentrionale). Il popolo siciliano nel corso della sua storia ha subito ben tredici dominazioni straniere, tuttavia non si è fatto sottomettere culturalmente. Da questi popoli, infatti, ha saputo acquisire il meglio della loro civiltà, selezionando quelle conoscenze che si confacevano alla sua cultura dotta e popolare. Infatti, ha saputo conservale la propria identità che comprende l’intelligenza, la diffidenza, l’umorismo, l’arte di arrangiarsi; come pure non ha perso il senso del valore per la famiglia e dell’onore, l’amore e il rispetto per i morti, per gli anziani, per i genitori, la sacralità per l’amicizia, il senso della cavalleria per le donne. Si tratta di un ricchissimo bagaglio di comportamenti che si porta dietro da secoli e nessuna dominazione straniera ha potuto intaccare. La Sicilia, fino a quando conserverà tale identità, le sue tradizioni e la propria memoria storica, non sarà mai un paese vinto. Nella storia spirituale plurisecolare della Sicilia si trovano le radici dell’animo popolare; in essa si trovano e si intrecciano fantasia e realtà, mondo pagano, musulmano e cristiano, superstizioni e scetticismo, volgarità e cavalleria, l’attruvatura e il fatalismo, mondo antico e mondo moderno. Ciò costituisce il folclore della Sicilia, inteso non come un’attrazione turistica o come un elemento ornamentale, ma il modo di vivere stesso della popolazione. Nei nostri canti popolari e in quella dei carrettieri si sente la cantilena araba. Il senso della cavalleria, uno dei sentimenti più delicati che ci caratterizza, è stato portato dai Normanni e si è fortemente radicato nel nostro animo. L’opera dei pupi, il canto del carrettiere e del cantastorie, la recita del “cuntastorie”, le scene cavalleresche raffigurate con decorazioni artistiche nei carri siciliani, sono altri esempi della civiltà lasciati dai normanni e ben assimilati dai nostri avi. Il ricordo delle lotte sostenute dai normanni contro gli arabi è tuttora vivo nell’annuale combattimento che si svolge per la festa della Madonna delle Milizie a Scicli o per la festa dell’Assunta a Piazza Armerina o per quella del Taratatà che si svolge a Casteltermini in occasione della festa di Santa Croce. Nelle chiese, l’antico rito greco bizantino imponeva la separazione dei sessi. Le navate erano divise da transenne di legno: le donne stavano sedute a sinistra, gli uomini a destra. Questa consuetudine è continuata fino a qualche decennio fa. L’economia della civiltà contadina, era condizionata dalla disoccupazione e dal raccolto sempre incerto, perché vincolato al buono ed al cattivo tempo. Da qui nasce il morboso attaccamento alle poche ricchezze possedute. “La robba” (spesso solo sognata) era considerata la sola ancora di salvezza, il toccasana per ogni male, una realtà incontrastata a cui il siciliano sacrificava l’intera sua esistenza. Ne scaturiva, pertanto, una corsa affannosa, ma di solito infruttuosa, ad accumulare beni. Per il contadino di allora, l’uomo e la sua vita non avevano nessun valore, solo la terra contava ed aveva un valore: “Lu patri si nni va la robba arresta” (L’uomo può morire, la terra no, essa non deve essere mai abbandonata). Per questa concezione della vita e della morte molti “picciotti” sono stati spinti a seguire con entusiasmo Garibaldi per scacciare i Borboni. Garibaldi, infatti, aveva promesso di dividere fra i contadini la terra dei latifondisti, incolta e abbandonata. Vincenzo Consolo in Pietre di Pantalica così descrive i contadini durante lo sbarco degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale: “...pastori e contadini. Immobili, logori come la terra su cui stavano, piegati con le zappe a rompere la crosta, sembrano indifferenti alle colonne di carri armati, alle truppe che passavano sulle trazzere bordate d’agave e di rovi, indifferenti a questa guerra che si svolgeva accanto a loro. Indifferenti e fermi lì da secoli sembravano; spettatori di tutte le conquiste, riconquiste, invasioni e liberazioni che in quel teatro s’erano giocate. E sembrava che la loro guerra fosse un’altra, millenaria e senza fine, contro quella terra d’altri, feudi di baroni e soprastanti, avara e avversaria, contro quel cielo impossibile e beffardo”. Intorno agli anni ’50, la classe contadina rappresentava la parte più sana della popolazione, perchè la così detta civiltà li aveva appena sfiorati. Essi erano rozzi e superstiziosi, ingenui ma grandi lavoratori che conservavano ancora i costumi e le tradizioni degli avi. I vecchi, in particolare, anche ai nostri giorni costituiscono una fonte inesauribile di remote conoscenze. In questo scenario antico, i personaggi sono deboli, limitati da molti elementi ostili quali l’ambiente, le tradizioni, il bisogno e la volontà inutile di liberarsene. I “vinti” di G:Verga sono stati sempre presenti nel palcoscenico siciliano. Sempre per la stessa ragione, l’incerto futuro ha dato un senso d’apprensione e di paura; forse a causa di ciò nella grammatica siciliana e nel parlare corrente non si usa il futuro. Per dire ad es. domani andrò, si dice: domani vado. Invece, molto usato è il passato remoto; per dire ad es. poco fa ho visto, si dice: “antura vitti” (poco fa vidi). Anche per la casa, spesso costituita da una sola stanza, dove la famiglia coabita con l’asino e le galline, c’è un morboso attaccamento, perché qui sono nati e cresciuti i propri avi, i cui “ritratti” sono appesi al muro quasi dei santi protettori. La famiglia e la casa, per le persone più povere, rappresentavano il fulcro, attorno al quale giostravano tutti gli altri interessi della vita. Tutto ciò che non interessava direttamente la propria famiglia, poco li riguardava, Si diceva, infatti: “Casuzza to, fuculareddu to” - “E’ la to casa chi ti strinci e ti vasa!” – “Casa mia, casa mia, tu sì reggia e sì batia!” – “Casa mia, matri mia!”. Possedere una casa, avere un tetto sotto cui ripararsi, e trovarvi ristoro tornando dal lavoro, era la massima ambizione di un lavoratore. Il contadino, in particolare, considera una grave disgrazia non poter morire nel suo letto fra le quattro mura di casa sua. Chi possedeva “un paru di casi” (una casa) poteva considerarsi veramente fortunato. E’ giusto chiarire che il vocabolo “paru” in siciliano ha un significato molto generico; infatti, può significare anche un oggetto divisibile in tante parti: “un paru di carti, un paru di forfici, un paru di scarpi, ecc. Un paio si dice “na para” oppure “na cucchia”. Dopo gli anni ’50, quando i figli incominciavano a lavorare e guadagnare, con i risparmi si cercava di costruire quattro mura per ognuno di loro, fabbricando sopra la casa esistente o dividendola in due (la mezza casa). Difficilmente coabitavano genitori e figli sposati; anche allora più di oggi esisteva la proverbiale discordia fra suocera e nuora. Tante volte le abitazioni a primo piano rimasero incomplete o chiuse, poiché nel frattempo i figli emigrarono all’estero. Il contadino, ma anche molti altri lavoratori, andava a letto “a la ntrabbunuta” o “a la cuddata di lu suli” (al tramonto del sole); “comu li addini” si diceva, poiché l’indomani mattina “a li sett’arbi” (ancora al buio) si dovevano trovare sul posto di lavoro, spesso lontano dal paese. La morte accompagnava i suoi pensieri nel corso della vita; morte intesa come castigo dei peccati commessi e come liberazione da questa vita grama, causata dai benestanti prepotenti, e subita con sdegno, rassegnazione e senso d’impotenza allo stesso tempo. Tuttavia, il ricordo dei propri avi, la nostalgia del passato, l’amore per la famiglia, per la casa e la terra, procuravano un maggiore attaccamento alla vita. Il suicidio, tanto di moda fra i moderni popoli del benessere, nel passato, da noi era quasi sconosciuto; la speranza di un domani migliore dava più carica per non arrendersi alle avversità. Il Siciliano ha avuto da sempre il culto dei morti e delle tombe. Dopo la morte, nella sua cultura non c’è il nulla eterno; il defunto, infatti, continua a vivere nell’aldilà, mentre i parenti viventi parlano di lui, “bon’arma”, in ogni occasione; continua così una “corrispondenza d’amorosi sensi” (direbbe il Foscolo) con l’estinto. Nell’argomento “la cattiva” ho già ampiamente trattato questo problema parlando del “repitu” e del lutto; nell’argomento “li picciriddi” ho parlato del due novembre come “la festa di li morti”. I nostri nonni si rivolgevano ai propri defunti per ottenere delle grazie; “li murticeddi”, riconoscenti, venivano spesse volte in sogno per accontentarli (vedi anche argomento “l’attruvatura”). La letteratura popolare siciliana è ricca di racconti dove si esalta la furbizia del contadino, che riesce a prendere in giro anche il diavolo. Oggi, lo sviluppo delle vie di comunicazione e dei mezzi d’informazione di massa, ha dato un impulso alla cultura ed al risveglio sociale; purtroppo ha provocato anche l’appiattimento dei pensieri fra i vari popoli. La globalizzazione, tanta esaltata e contestata, ha provocato in Sicilia la perdita della propria identità, del modo d’essere e di pensare, del folclore, della cultura, assorbendo invece quelli d’altri popoli. Una volta la vita offriva pochi svaghi e divertimenti anche per le persone benestanti. Il contadino, ma anche l’artigiano e l’operaio, sperava per l’incerto domani soltanto un poco di sicurezza. Un ragazzo sognava di raggiungere i 18 anni d’età, per potere frequentare le case di tolleranza, per andare militare e conoscere un poco l’Italia settentrionale ed il suo tenore di vita più elevato, quindi aprirsi una sua attività, svincolarsi dalla famiglia ed infine sposarsi. Per una ragazza chiusa in casa, perché così imponeva la civiltà maschilista, la sua unica aspirazione era il matrimonio con un uomo comprensivo, per potersi assicurare il mantenimento per tutta la vita, ed avere tanti figli. Allora, per una famiglia povera, la nascita di una femminuccia rappresentava un vero castigo di Dio; infatti, c’era una bocca in più da sfamare, una dote da preparare per il matrimonio e delle braccia in meno per il lavoro. Inoltre, un padre che aveva avuto solo figlie femmine, era disperato, perché con lui si sarebbe estinto il suo cognome portato con tanto orgoglio ed ereditato dai suoi avi maschi. In merito un proverbio diceva: - Cu bona reda voli fari, di figghia fimmina avi a cuminciari, ma all’annu nun ci avi arrivari. Cioè la nascita di una femmina, come primogenito, era un buon segno, purché questa muoia entro l’anno. Ho sempre sostenuto che noi Siciliani amiamo la nostra terra e il nostro modo di vivere più della stessa vita; tuttavia, disprezziamo il nostro comportamento ed esaltiamo quello d’altri popoli più evoluti. Secondo me, non siamo ammalati d’esterofilia, tale comportamento sorge dalla consapevolezza di essere un popolo potenzialmente ricco: per volontà, operosità, intelligenza, territorio, clima, ecc. e che tuttavia, a causa della burocrazia, dei cattivi amministratori e della mafia, restiamo sempre il fanalino di coda. Per la mancanza di lavoro, molti capi famiglia, con la morte nel cuore ed una rabbia repressa, emigrarono verso l’Italia del nord o all’estero fino alle lontane Americhe o all’Australia. Oggi, molti giovani figli del benessere, emigrano in cerca di un lavoro più redditizio (ma andando incontro anche ad un costo della vita più cara), perché ammalati di “aria del continente” (come direbbe il Martoglio). Scoprire nuovi orizzonti della vita è un istinto innato: “Nati non fosti a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” ebbe a dire Dante. Essi lasciano la propria terra, dove sono attaccate le proprie radici, per la voglia di fuga, di evadere, di cercare una nuova ragione di vita più giusta, più ricca anche culturalmente. Essi spesso si accorgono di trovare un mondo vuoto, frenetico che adora soltanto il Dio Denaro, privo di quella umanità e solidarietà che ancora si trova nei nostri piccoli paesi. Delusi e pieni di nostalgia ritornano al paese natio: troppo tardi! Il tempo, il cemento e la globalizzazione hanno fatto anche qui dei cambiamenti e non ritrovano più il proprio habitat che avevano lasciato. “Lu Signuri ti lu paa”, è una frase di ringraziamento, che una volta era molto usata da chi riceveva un aiuto, un favore. Oggi si direbbe “a buon rendere”, ma allora molte persone non avevano la possibilità di poter rendere, per cui si disobbligavano tramite l’intercessione del Signore. Per dare maggiore enfasi al proprio discorso, si usava ripetere più di una volta la stessa frase; per esempio: “ti ho detto di smetterla!” detto a voce alta e, continuando: “che ti ho detto di smetterla!” (con voce più bassa, ripetuta anche più volte). In queste poche pagine ho cercato di racchiudere tutta la cultura del popolo siciliano e di Castelvetrano in particolare. Una cultura che ci hanno lasciato i nostri avi, un bene prezioso, che ci consente di trovare le nostre radici e di capire che noi, posteri dei nostri antenati non stiamo più seguendo la strada che loro ci avevano spianata. Infatti, la moderna civiltà globalizzata ci induce a seguire culture straniere provenienti dal Nord e ad abbandonare quella nostra, quella dei nostri avi, quella che era una volta comune a tutto il Mediterraneo. Oltre a quelli già citati, ho trovato altri proverbi che riguardano la roba, la casa, il paese.
 -Addisiari lu iornu pani e la notti robba.
-Addisiari lu iornu pani e la notti robba.
- Ad ogni aceddu lu so niru pari beddu.
- Biatu l’aceddu chi fa lu niru nta lu so paisi.
- Casa quantu stai, vigna quantu vivi, terra quantu ni viri.
- Tinta dda casa ch’un avi un vecchiu. (Vito Marino)
NOTA: Le foto del portale ed alcuni testi, sono prese in gran parte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà segnalarlo alla redazione che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini e dei testi utilizzati.