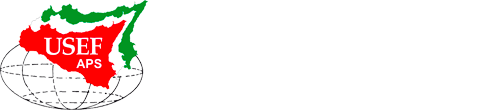La concezione del matrimonio per i nostri nonni fino al 1940 – 45 era del tutto diversa dei nostri giorni; infatti, allora una persona si sposava per "sistimarisi": l'uomo si sposava per avere "lu sirvimentu" (per essere servito in casa), mentre la donna per "lu mantinimentu" (per essere mantenuta).
La concezione del matrimonio per i nostri nonni fino al 1940 – 45 era del tutto diversa dei nostri giorni; infatti, allora una persona si sposava per "sistimarisi": l'uomo si sposava per avere "lu sirvimentu" (per essere servito in casa), mentre la donna per "lu mantinimentu" (per essere mantenuta).
 Unendo “sirvimentu e mantinimentu” ad una buona dote, si otteneva per la coppia un buon matrimonio. Inoltre, per un buon matrimonio la donna doveva essere “un vrazzu di mari” (laboriosa), “unurata” (onesta), “bona quasata” (con una giusta dote), “di lu propriu casatu” (di pari condizioni sociali); l’uomo doveva essere laborioso (le sue mani incallite erano un segno di garanzia). Il matrimonio era ancora considerato da tutti sacro ed indissolubile e gli sposi si recavano al matrimonio con un gran senso di responsabilità. La fecondità, specialmente fra la gente più umile, era considerata come un dono della Provvidenza; la sterilità era invece temuta. Allora, era normale trovare famiglie numerose anche con dieci o più figli. La famiglia patriarcale dei vecchi tempi, con “patruni e domini” per come si diceva, come capo famiglia, era utile per mantenere più salda e più sana tutta la famiglia, ma non era ben vista dai figli già adulti, che cercavano di emanciparsi. Per i figli maschi era più facile uscirne fuori, mettendosi a lavorare fuori della cerchia familiare o con l’emigrazione; la donna, invece, doveva aspettare il matrimonio. Di conseguenza, succedeva spesso che essa, per sistemarsi ed emanciparsi, si sposasse ancora minorenne, con il consenso dei genitori. Anche i genitori cercavano di “sistemare” la loro figliola al più presto possibile, per paura che restasse, dopo la loro morte, nubile e sola. Infatti, un proverbio allora così sentenziava: “La figghia fimmina è comu ‘na cammiali, prima la scanci e megghiu è”. Un altro proverbio diceva: “La figghia a diciott’anni o è maritata o la scanni”. Un altro diceva “donna a dicirottu e omu a vintottu”. La donna era completamente all’oscuro sul sesso e sulla vita di coppia o aveva delle idee vaghe ed errate; solo il giorno del matrimonio la madre, con molte difficoltà, dava qualche cenno sul come comportarsi con il marito la notte del matrimonio. Purtroppo, anche la madre si vergognava di parlare di un argomento considerato così scabroso e peccaminoso e, di solito, mandava la figlia allo sbaraglio. Quando in una famiglia c'erano diverse figlie in età di prendere marito, era normale fare la richiesta di matrimonio per la figlia più grande; le altre dovevano aspettare il loro turno. I fratelli, specialmente se erano loro a sostenere la famiglia, si dovevano sposare dopo le sorelle. Quando moriva il padre, il figlio più grande prendeva le redini della famiglia. Quando la figlia era già in età di contrarre matrimonio i genitori se la portavano dietro quando c’era la fiera della Tagliata, la manifestazione dell’Aurora o altre feste paesane o se la portavano a messa o a passeggio la domenica, quasi fosse una mercanzia posta in bella mostra su una bancarella della fiera. I genitori del ragazzo (specialmente la madre) avevano il compito di trovare un “buon partito” per il figlio; pertanto, spettava a loro fare il primo passo presso i genitori della ragazza prescelta. Per prima cosa si accordavano sulla dote d’ambo le parti, quindi, in un foglio di carta si stilava il contratto di matrimonio, senza la presenza del notaio. Si trattava di un sistema arcaico, adottato dalle famiglie più intransigenti. Generalmente le due famiglie si “appaluravanu” (si davano la parola d’onore) per l’impegno preso. Infine i due promessi sposi si potevano conoscere. La “canuscenza” era una cerimonia solenne che si concludeva con la distribuzione di “scacciu” (ceci, nocciole, mandorle, e fave “caliati” (tostati). Nelle città l’incombenza di creare un fidanzamento era affidata al “paraninfu” (o sinsali o ruffianu) , una persona che faceva da intermediario per mestiere ed era regolarmente pagata. Qualche giorno prima del matrimonio, si stilava l’atto di cessione dei beni dal notaio. Questo sistema di “scambio merce” esisteva ancora intorno agli anni ’40. L’elenco dei beni che una ragazza portava in dote si chiamava “minuta”. Il contratto, con le clausole matrimoniali, effettuato dal notaio esisteva anche fra gli ebrei. A comprova della disuguaglianza allora esistente fra uomo e donna, quando si parlava di un uomo appena sposato si diceva: “A cu si pigghià?” (a chi si è preso?); per la donna invece si diceva: “a cu ci dettiru?” (a chi le hanno dato?). Siccome a quei tempi esisteva una marcata scala gerarchica, solo difficilmente avvenivano matrimoni fra persone di diverse condizioni sociali. Un “burgisi”, un “iurnateri” (bracciante) o un “picuraru” si poteva sposare con la figlia di un contadino della stessa scala gerarchica. Un proverbio, infatti, diceva: “Para, cu para pigghia, asinnò ti sperdi comu la canigghia”; un altro diceva: “ciciri cu ciciri e favi cu favi, ca bona arricota s’havi”. “Lu schettu granni” (l’uomo scapolo) era considerato un incapace, senza coraggio e personalità; un proverbio diceva addirittura: “L’omu a cinquant’anni o è maritatu o è varvaianni”. Durante il Governo Mussolini, era stata istituita la tassa sul celibato, per spingere i più indecisi a sposarsi e procreare figli per la Patria. In certi casi i fidanzamenti erano “accordati” tramite l’intervento d’intermediari come il “ruffianu” o il sensale. Raggiunto un accordo, i due promessi sposi potevano finalmente fare “canuscenza” con una cerimonia ufficiale: "l'entrata". In quell’occasione il fidanzato per “spiegarsi” portava come pegno d'amore un gran mazzo di rose rosse, di numero dispari, mentre la fidanzata indossava un vestito verde come “signaliamentu” (come simbolo). Il colore verde simboleggiava la speranza che tutto andasse a buon fine; per maggiore garanzia la ragazza indossava sotto il vestito un nastro rosso contro il malocchio. Secondo la tradizione di quegli anni, il fidanzato, in occasione della fiera della Tagliata, nel primo anno di fidanzamento doveva comprare una collana alla fidanzata, mentre per la ricorrenza del 2 novembre doveva regalare borsa, ombrello e guanti, oltre ai “pupi di zuccaru” raffiguranti una coppia di fidanzati. A Campobello di Mazara lo sposo, nel primo anno di matrimonio doveva portare la sposa a visitare detta fiera oltre alla manifestazione dell’Aurora che si svolge tutt’ora a Castelvetrano in Piazza Carlo d’Aragona il giorno di Pasqua. Quando si parlava già di matrimonio, le parti si scambiavano gli anelli di fidanzamento con i brillanti, in una cerimonia a cui partecipavano i parenti intimi d'ambo le parti. Fatto il fidanzamento, i due giovani si potevano vedere solo in casa della fidanzata, ma guardati a vista e seduti distanti uno dall'altra. Seduti a tavola, se restavano vicini, dovevano trattenere le mani sul tavolo e i piedi guardati a vista per paura di qualche contatto (con...scarica elettrica?). La ragazza non poteva nemmeno essere sfiorata dal fidanzato, ne andava di mezzo l’onore della famiglia; così, quando si “scunchiuria”, tutto era a posto, perché era stata sempre guardata e si poteva sperare in un prossimo fidanzamento. “Li zitaggi su comu li tuvagghi di tavula, si mettinu e si lavanu”, così si diceva; in questo modo potevano susseguirsi anche più fidanzamenti. Quando nei giorni di festa si usciva a passeggio, anche per far sapere alla cittadinanza l'avvenuto fidanzamento, i due promessi, stando vicini, ma spesse volte con divieto di mettersi a braccetto, erano seguiti da tutti i familiari della ragazza: “la cura”; così veniva scherzosamente chiamata questa coda di persone a seguito: davanti stavano i più piccoli, dietro i fidanzati, poi le sorelle o i fratelli più grandi, di seguito le rispettive mamme, e infine i papà, futuri consuoceri. In tempi più recenti i fidanzati uscivano a passeggio, seguiti da un solo parente che, si diceva scherzosamente, “tinìa la cannila”. Generalmente si trattava della sorella o del fratello più piccolo, che con poche caramelle si allontanava un poco, diventando “ruffiano”, lasciando amoreggiare i due piccioncini. I genitori della ragazza a giustificare il loro comportamento rigido citavano alcuni proverbi: - “Lisinedda va circannu lignu moddu” (il punteruolo del calzolaio va cercando legno morbido) oppure “La fimmina è pagghia, lu masculu è focu, veni lu diavulu e ci ciucia” (la donna è paglia, l’uomo è fuoco, viene il diavolo e vi soffia) –. Inoltre, raccomandavano sempre di stare attenti a “li masculi”, ma anche ai preti, “picchì vonnu ‘na cosa sula di li fimmini”. Tutte queste limitazioni facevano aumentare il fuoco d’amore, che ardeva di nascosto dentro le giovani coppie; prova ne sia che spesse volte, inspiegabilmente, la fidanzata restava incinta. In questi casi il matrimonio anticipato nascondeva tutto, ma i figli nati prima di nove mesi dal matrimonio lasciavano parlare “li “mali lingui”. Durante il fidanzamento, la ragazza non doveva più uscire sola da casa, perché poteva interpretarsi come un andare in giro in cerca di miglior pretendente, pertanto poteva essere “sparlata”. Otto giorni prima del matrimonio, in casa della futura sposa, si faceva un banchetto, che si poteva considerare un addio al nubilato, a cui partecipavano i parenti più intimi d'ambo le parti. Nello stesso periodo, essa metteva in bella mostra “la biancheria esposta” (tutto il suo corredo di sposa) per tre giorni. In quell’occasione gli invitati alle nozze portavano i regali e guardavano la biancheria; a loro si offriva “calia, simenza, noccioline” (semi vari tostati), frutta fresca (la frutta allora era considerata un bene voluttuario) e “rasoliu” (liquore fatto in casa). Finalmente, giunto il giorno tanto atteso del matrimonio, lo sposo si recava in casa della sposa e, dopo la laboriosa vestizione di lei, si avviavano, assieme a tutti gli invitati, in corteo a piedi, in chiesa per lo sposalizio. Il corteo era preceduto da alcune “verginelle” (ragazzine vestite di bianco, simbolo della purezza), mentre altre due, che facevano da damigelle, tenevano alzato il lungo strascico del vestito nuziale. La sposa a braccio del padre portava un mazzo di fiori freschi “il buchè”, portato dal fidanzato. Seguivano il fidanzato a braccio della madre e tutti gli altri parenti. Il prete e i testimoni aspettavano all’altare. Le persone del ceto medio si sposavano di sera e la cerimonia durava poco perché allora di sera non c’era la messa serale, mentre i benestanti si sposavano di mattina durante la messa. Dopo la cerimonia religiosa, uscendo dalla chiesa c’erano i parenti ad aspettarli, che in segno augurale buttavano addosso frumento e monetine metalliche. Quindi si riformava il corteo nuziale, con gli sposi finalmente a braccetto, che si indirizzava a casa dei genitori della sposa, per il trattenimento. Intorno agli anni ’40 il rinfresco si differiva secondo le disponibilità economiche delle parti: quello più modesto consisteva nel “trippiari” (ballare) quasi tutta la notte, al suono della “zi banna” (l’orchestrina), offrendo agli invitati durante gli intervalli quello che si poteva: confetti, "calia e simenza" (ceci e semi di zucca abbrustoliti), mandorle e noci tostate, uva passa, fichi secchi, biscotti fatti in casa come “tetù, quaresimali, muscardina, mustazzola, viscotta picanti”, vino vecchio o marsala, "rasoliu" (liquore fatto in casa con alcool e aromi già preparati). L’azione di passare durante il ricevimento, con il vassoio pieno di quanto detto, per offrirlo agli invitati, si chiamava “fari lu firriatu” (da firriari = girare). Gli invitati stavano seduti sulle sedie disposte lungo le pareti delle stanze; i parenti della sposa con i vassoi passavano con le offerte. Questa funzione era meglio definita: “la passata”; secondo il numero delle “passate” si poteva giudicare la buona riuscita del trattenimento. Per i numerosi bambini del vicinato che “abbaruccavanu” (curiosavano) davanti la porta, c’era sempre qualche pugno di confetti buttati a casaccio su di loro. Per i più ricchi, c’erano abbondanti dolci fatti dai dolcieri e ottimi liquori; negli anni antecedenti alle mie memorie, sicuramente prima degli anni ’40 si parlava di grandi abbuffate, che duravano tre giorni, a base di castrato, maiale, "vistiola" (vitello) e pollame, cucinati in vari modi, intere infornate di pane casereccio, pasta fatta in casa, brace e forno sempre acceso per gli arrosti e cotture varie. Finita la festa, gli sposi, accompagnati dai parenti e dai musicanti, si recavano alla loro nuova dimora; qui, prima di essere lasciati soli, si eseguiva l'ultima suonata attorno al letto nuziale. Riguardo al letto nuziale, c’era l’usanza indiscussa d’essere “cunzatu” (preparato) dalla madre della sposa e da un’altra donna sposata.
Unendo “sirvimentu e mantinimentu” ad una buona dote, si otteneva per la coppia un buon matrimonio. Inoltre, per un buon matrimonio la donna doveva essere “un vrazzu di mari” (laboriosa), “unurata” (onesta), “bona quasata” (con una giusta dote), “di lu propriu casatu” (di pari condizioni sociali); l’uomo doveva essere laborioso (le sue mani incallite erano un segno di garanzia). Il matrimonio era ancora considerato da tutti sacro ed indissolubile e gli sposi si recavano al matrimonio con un gran senso di responsabilità. La fecondità, specialmente fra la gente più umile, era considerata come un dono della Provvidenza; la sterilità era invece temuta. Allora, era normale trovare famiglie numerose anche con dieci o più figli. La famiglia patriarcale dei vecchi tempi, con “patruni e domini” per come si diceva, come capo famiglia, era utile per mantenere più salda e più sana tutta la famiglia, ma non era ben vista dai figli già adulti, che cercavano di emanciparsi. Per i figli maschi era più facile uscirne fuori, mettendosi a lavorare fuori della cerchia familiare o con l’emigrazione; la donna, invece, doveva aspettare il matrimonio. Di conseguenza, succedeva spesso che essa, per sistemarsi ed emanciparsi, si sposasse ancora minorenne, con il consenso dei genitori. Anche i genitori cercavano di “sistemare” la loro figliola al più presto possibile, per paura che restasse, dopo la loro morte, nubile e sola. Infatti, un proverbio allora così sentenziava: “La figghia fimmina è comu ‘na cammiali, prima la scanci e megghiu è”. Un altro proverbio diceva: “La figghia a diciott’anni o è maritata o la scanni”. Un altro diceva “donna a dicirottu e omu a vintottu”. La donna era completamente all’oscuro sul sesso e sulla vita di coppia o aveva delle idee vaghe ed errate; solo il giorno del matrimonio la madre, con molte difficoltà, dava qualche cenno sul come comportarsi con il marito la notte del matrimonio. Purtroppo, anche la madre si vergognava di parlare di un argomento considerato così scabroso e peccaminoso e, di solito, mandava la figlia allo sbaraglio. Quando in una famiglia c'erano diverse figlie in età di prendere marito, era normale fare la richiesta di matrimonio per la figlia più grande; le altre dovevano aspettare il loro turno. I fratelli, specialmente se erano loro a sostenere la famiglia, si dovevano sposare dopo le sorelle. Quando moriva il padre, il figlio più grande prendeva le redini della famiglia. Quando la figlia era già in età di contrarre matrimonio i genitori se la portavano dietro quando c’era la fiera della Tagliata, la manifestazione dell’Aurora o altre feste paesane o se la portavano a messa o a passeggio la domenica, quasi fosse una mercanzia posta in bella mostra su una bancarella della fiera. I genitori del ragazzo (specialmente la madre) avevano il compito di trovare un “buon partito” per il figlio; pertanto, spettava a loro fare il primo passo presso i genitori della ragazza prescelta. Per prima cosa si accordavano sulla dote d’ambo le parti, quindi, in un foglio di carta si stilava il contratto di matrimonio, senza la presenza del notaio. Si trattava di un sistema arcaico, adottato dalle famiglie più intransigenti. Generalmente le due famiglie si “appaluravanu” (si davano la parola d’onore) per l’impegno preso. Infine i due promessi sposi si potevano conoscere. La “canuscenza” era una cerimonia solenne che si concludeva con la distribuzione di “scacciu” (ceci, nocciole, mandorle, e fave “caliati” (tostati). Nelle città l’incombenza di creare un fidanzamento era affidata al “paraninfu” (o sinsali o ruffianu) , una persona che faceva da intermediario per mestiere ed era regolarmente pagata. Qualche giorno prima del matrimonio, si stilava l’atto di cessione dei beni dal notaio. Questo sistema di “scambio merce” esisteva ancora intorno agli anni ’40. L’elenco dei beni che una ragazza portava in dote si chiamava “minuta”. Il contratto, con le clausole matrimoniali, effettuato dal notaio esisteva anche fra gli ebrei. A comprova della disuguaglianza allora esistente fra uomo e donna, quando si parlava di un uomo appena sposato si diceva: “A cu si pigghià?” (a chi si è preso?); per la donna invece si diceva: “a cu ci dettiru?” (a chi le hanno dato?). Siccome a quei tempi esisteva una marcata scala gerarchica, solo difficilmente avvenivano matrimoni fra persone di diverse condizioni sociali. Un “burgisi”, un “iurnateri” (bracciante) o un “picuraru” si poteva sposare con la figlia di un contadino della stessa scala gerarchica. Un proverbio, infatti, diceva: “Para, cu para pigghia, asinnò ti sperdi comu la canigghia”; un altro diceva: “ciciri cu ciciri e favi cu favi, ca bona arricota s’havi”. “Lu schettu granni” (l’uomo scapolo) era considerato un incapace, senza coraggio e personalità; un proverbio diceva addirittura: “L’omu a cinquant’anni o è maritatu o è varvaianni”. Durante il Governo Mussolini, era stata istituita la tassa sul celibato, per spingere i più indecisi a sposarsi e procreare figli per la Patria. In certi casi i fidanzamenti erano “accordati” tramite l’intervento d’intermediari come il “ruffianu” o il sensale. Raggiunto un accordo, i due promessi sposi potevano finalmente fare “canuscenza” con una cerimonia ufficiale: "l'entrata". In quell’occasione il fidanzato per “spiegarsi” portava come pegno d'amore un gran mazzo di rose rosse, di numero dispari, mentre la fidanzata indossava un vestito verde come “signaliamentu” (come simbolo). Il colore verde simboleggiava la speranza che tutto andasse a buon fine; per maggiore garanzia la ragazza indossava sotto il vestito un nastro rosso contro il malocchio. Secondo la tradizione di quegli anni, il fidanzato, in occasione della fiera della Tagliata, nel primo anno di fidanzamento doveva comprare una collana alla fidanzata, mentre per la ricorrenza del 2 novembre doveva regalare borsa, ombrello e guanti, oltre ai “pupi di zuccaru” raffiguranti una coppia di fidanzati. A Campobello di Mazara lo sposo, nel primo anno di matrimonio doveva portare la sposa a visitare detta fiera oltre alla manifestazione dell’Aurora che si svolge tutt’ora a Castelvetrano in Piazza Carlo d’Aragona il giorno di Pasqua. Quando si parlava già di matrimonio, le parti si scambiavano gli anelli di fidanzamento con i brillanti, in una cerimonia a cui partecipavano i parenti intimi d'ambo le parti. Fatto il fidanzamento, i due giovani si potevano vedere solo in casa della fidanzata, ma guardati a vista e seduti distanti uno dall'altra. Seduti a tavola, se restavano vicini, dovevano trattenere le mani sul tavolo e i piedi guardati a vista per paura di qualche contatto (con...scarica elettrica?). La ragazza non poteva nemmeno essere sfiorata dal fidanzato, ne andava di mezzo l’onore della famiglia; così, quando si “scunchiuria”, tutto era a posto, perché era stata sempre guardata e si poteva sperare in un prossimo fidanzamento. “Li zitaggi su comu li tuvagghi di tavula, si mettinu e si lavanu”, così si diceva; in questo modo potevano susseguirsi anche più fidanzamenti. Quando nei giorni di festa si usciva a passeggio, anche per far sapere alla cittadinanza l'avvenuto fidanzamento, i due promessi, stando vicini, ma spesse volte con divieto di mettersi a braccetto, erano seguiti da tutti i familiari della ragazza: “la cura”; così veniva scherzosamente chiamata questa coda di persone a seguito: davanti stavano i più piccoli, dietro i fidanzati, poi le sorelle o i fratelli più grandi, di seguito le rispettive mamme, e infine i papà, futuri consuoceri. In tempi più recenti i fidanzati uscivano a passeggio, seguiti da un solo parente che, si diceva scherzosamente, “tinìa la cannila”. Generalmente si trattava della sorella o del fratello più piccolo, che con poche caramelle si allontanava un poco, diventando “ruffiano”, lasciando amoreggiare i due piccioncini. I genitori della ragazza a giustificare il loro comportamento rigido citavano alcuni proverbi: - “Lisinedda va circannu lignu moddu” (il punteruolo del calzolaio va cercando legno morbido) oppure “La fimmina è pagghia, lu masculu è focu, veni lu diavulu e ci ciucia” (la donna è paglia, l’uomo è fuoco, viene il diavolo e vi soffia) –. Inoltre, raccomandavano sempre di stare attenti a “li masculi”, ma anche ai preti, “picchì vonnu ‘na cosa sula di li fimmini”. Tutte queste limitazioni facevano aumentare il fuoco d’amore, che ardeva di nascosto dentro le giovani coppie; prova ne sia che spesse volte, inspiegabilmente, la fidanzata restava incinta. In questi casi il matrimonio anticipato nascondeva tutto, ma i figli nati prima di nove mesi dal matrimonio lasciavano parlare “li “mali lingui”. Durante il fidanzamento, la ragazza non doveva più uscire sola da casa, perché poteva interpretarsi come un andare in giro in cerca di miglior pretendente, pertanto poteva essere “sparlata”. Otto giorni prima del matrimonio, in casa della futura sposa, si faceva un banchetto, che si poteva considerare un addio al nubilato, a cui partecipavano i parenti più intimi d'ambo le parti. Nello stesso periodo, essa metteva in bella mostra “la biancheria esposta” (tutto il suo corredo di sposa) per tre giorni. In quell’occasione gli invitati alle nozze portavano i regali e guardavano la biancheria; a loro si offriva “calia, simenza, noccioline” (semi vari tostati), frutta fresca (la frutta allora era considerata un bene voluttuario) e “rasoliu” (liquore fatto in casa). Finalmente, giunto il giorno tanto atteso del matrimonio, lo sposo si recava in casa della sposa e, dopo la laboriosa vestizione di lei, si avviavano, assieme a tutti gli invitati, in corteo a piedi, in chiesa per lo sposalizio. Il corteo era preceduto da alcune “verginelle” (ragazzine vestite di bianco, simbolo della purezza), mentre altre due, che facevano da damigelle, tenevano alzato il lungo strascico del vestito nuziale. La sposa a braccio del padre portava un mazzo di fiori freschi “il buchè”, portato dal fidanzato. Seguivano il fidanzato a braccio della madre e tutti gli altri parenti. Il prete e i testimoni aspettavano all’altare. Le persone del ceto medio si sposavano di sera e la cerimonia durava poco perché allora di sera non c’era la messa serale, mentre i benestanti si sposavano di mattina durante la messa. Dopo la cerimonia religiosa, uscendo dalla chiesa c’erano i parenti ad aspettarli, che in segno augurale buttavano addosso frumento e monetine metalliche. Quindi si riformava il corteo nuziale, con gli sposi finalmente a braccetto, che si indirizzava a casa dei genitori della sposa, per il trattenimento. Intorno agli anni ’40 il rinfresco si differiva secondo le disponibilità economiche delle parti: quello più modesto consisteva nel “trippiari” (ballare) quasi tutta la notte, al suono della “zi banna” (l’orchestrina), offrendo agli invitati durante gli intervalli quello che si poteva: confetti, "calia e simenza" (ceci e semi di zucca abbrustoliti), mandorle e noci tostate, uva passa, fichi secchi, biscotti fatti in casa come “tetù, quaresimali, muscardina, mustazzola, viscotta picanti”, vino vecchio o marsala, "rasoliu" (liquore fatto in casa con alcool e aromi già preparati). L’azione di passare durante il ricevimento, con il vassoio pieno di quanto detto, per offrirlo agli invitati, si chiamava “fari lu firriatu” (da firriari = girare). Gli invitati stavano seduti sulle sedie disposte lungo le pareti delle stanze; i parenti della sposa con i vassoi passavano con le offerte. Questa funzione era meglio definita: “la passata”; secondo il numero delle “passate” si poteva giudicare la buona riuscita del trattenimento. Per i numerosi bambini del vicinato che “abbaruccavanu” (curiosavano) davanti la porta, c’era sempre qualche pugno di confetti buttati a casaccio su di loro. Per i più ricchi, c’erano abbondanti dolci fatti dai dolcieri e ottimi liquori; negli anni antecedenti alle mie memorie, sicuramente prima degli anni ’40 si parlava di grandi abbuffate, che duravano tre giorni, a base di castrato, maiale, "vistiola" (vitello) e pollame, cucinati in vari modi, intere infornate di pane casereccio, pasta fatta in casa, brace e forno sempre acceso per gli arrosti e cotture varie. Finita la festa, gli sposi, accompagnati dai parenti e dai musicanti, si recavano alla loro nuova dimora; qui, prima di essere lasciati soli, si eseguiva l'ultima suonata attorno al letto nuziale. Riguardo al letto nuziale, c’era l’usanza indiscussa d’essere “cunzatu” (preparato) dalla madre della sposa e da un’altra donna sposata.
Scherzando sul dopo matrimonio:
- Lu primu annu cori a cori
- lu secunnu culu a culu
- lu terzu a cauci ‘n culu
VITO MARINO