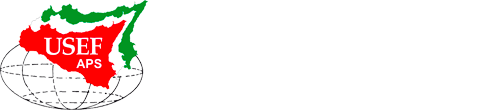La globalizzazione sta livellando la cultura di tutti i popoli della Terra, annullando a poco a poco tutte la tradizioni popolari locali, dove si trova la sintesi della storia, della lingua e della civiltà millenaria di una nazione.
La globalizzazione sta livellando la cultura di tutti i popoli della Terra, annullando a poco a poco tutte la tradizioni popolari locali, dove si trova la sintesi della storia, della lingua e della civiltà millenaria di una nazione.
 Consapevoli che su questi valori affondano le radici della nostra civiltà, dobbiamo cercare di recuperare e valorizzare queste tradizioni. E’ quello che da anni cerco di attuare attraverso la ricerca e la raccolta di materiale che riguardano le nostre tradizioni e diffondendoli attraverso i mezzi di diffusione di massa. Il Carnevale di Castelvetrano, scomparso da anni, teoricamente è una ricorrenza che risale al 1600, con l’introduzione del gioco del toro e di tre giorni di festa, che in Sicilia si chiamavano “Li sdirri”. Il gioco del toro, che restò in voga fino al 1800 era una reminiscenza della dominazione spagnola barocca; faceva parte dei programmi culturali eseguiti a Castelvetrano all’insegna del chiasso e del grande spasso popolare. Un toro veniva legato per le corna con una lunga e robusta fune, trattenuta al capo da un gruppo di uomini. Aizzato dai giocatori con drappi rossi e con le urla sfrenate del pubblico, messo al sicuro dietro uno steccato, il toro, lasciato libero rincorreva minaccioso il giocatore. Costui quando sentiva di essere raggiunto e di non poter schivare il corpo dell’animale, si salvava scendendo lesto in un fosso scavato precedentemente nel mezzo della piazza. Il più bravo dei concorrenti non era solo colui che con movimenti agili e lesti scansava i colpi del toro senza scendere nel rifugio, ma chi invece riusciva a cavalcarlo. Cessato l’uso della corrida, per festeggiare il Carnevale sono subentrati “li stracanciati”, cioè le maschere. Storicamente si hanno notizie dell’esistenza del carnevale, in una delibera comunale al punto n.23, riportata sul giornale locale di Castelvetrano “La Diga” n.1 del 15/6/1911 “Il Consiglio Comunale di Castelvetrano nell’ultima seduta, al n. 23 ratificò la deliberazione della Giunta sulla spesa del Carnevale”. Durante il regime fascista, con provvedimento dell’allora Cavaliere uff. Melchiorre Infranca, (podestà dal 1939 al 1943), viene istituito il Carnevale con la seguente motivazione: <>. La spesa comunale consisteva nella costruzione di un palco a tre piani per la banda musicale e nell’acquisto di un pupazzo raffigurante il Carnevale. Durante la II Guerra Mondiale, la manifestazione era stata sospesa per evidenti motivi; nel dopoguerra fu il sindaco Simanella, in carica dal 1947 al 1952, durante il suo mandato, a far ritornare questo divertimento popolare. Nella storia di questa festa, gli anni compresi fra il 1950 e il 1960 forse furono i più ruggenti; Castelvetrano aveva acquisito un Carnevale d’avanguardia, veramente sentito da tutta la popolazione; addirittura veniva gente dai paesi vicini, anche da Palermo, per divertirsi. “Doppu li tri re olè olè”, diceva un noto proverbio; infatti, con “la festa di li tri re” (Epifania), una volta prettamente religiosa, oggi chiamata “della befana”, cioè del consumismo e dei regali, il sei gennaio chiudeva tutta la festività e l’atmosfera natalizia, ed iniziava a taglio netto il Carnevale. Infatti, già la stessa sera alcune maschere giravano per le strade con le loro voci artefatte riscaldando e preparando l’atmosfera per la grande festa. In quei giorni e fino al giovedì grasso, si ballava soltanto in casa di amici “a parti di casa” (presso i priva
Consapevoli che su questi valori affondano le radici della nostra civiltà, dobbiamo cercare di recuperare e valorizzare queste tradizioni. E’ quello che da anni cerco di attuare attraverso la ricerca e la raccolta di materiale che riguardano le nostre tradizioni e diffondendoli attraverso i mezzi di diffusione di massa. Il Carnevale di Castelvetrano, scomparso da anni, teoricamente è una ricorrenza che risale al 1600, con l’introduzione del gioco del toro e di tre giorni di festa, che in Sicilia si chiamavano “Li sdirri”. Il gioco del toro, che restò in voga fino al 1800 era una reminiscenza della dominazione spagnola barocca; faceva parte dei programmi culturali eseguiti a Castelvetrano all’insegna del chiasso e del grande spasso popolare. Un toro veniva legato per le corna con una lunga e robusta fune, trattenuta al capo da un gruppo di uomini. Aizzato dai giocatori con drappi rossi e con le urla sfrenate del pubblico, messo al sicuro dietro uno steccato, il toro, lasciato libero rincorreva minaccioso il giocatore. Costui quando sentiva di essere raggiunto e di non poter schivare il corpo dell’animale, si salvava scendendo lesto in un fosso scavato precedentemente nel mezzo della piazza. Il più bravo dei concorrenti non era solo colui che con movimenti agili e lesti scansava i colpi del toro senza scendere nel rifugio, ma chi invece riusciva a cavalcarlo. Cessato l’uso della corrida, per festeggiare il Carnevale sono subentrati “li stracanciati”, cioè le maschere. Storicamente si hanno notizie dell’esistenza del carnevale, in una delibera comunale al punto n.23, riportata sul giornale locale di Castelvetrano “La Diga” n.1 del 15/6/1911 “Il Consiglio Comunale di Castelvetrano nell’ultima seduta, al n. 23 ratificò la deliberazione della Giunta sulla spesa del Carnevale”. Durante il regime fascista, con provvedimento dell’allora Cavaliere uff. Melchiorre Infranca, (podestà dal 1939 al 1943), viene istituito il Carnevale con la seguente motivazione: <>. La spesa comunale consisteva nella costruzione di un palco a tre piani per la banda musicale e nell’acquisto di un pupazzo raffigurante il Carnevale. Durante la II Guerra Mondiale, la manifestazione era stata sospesa per evidenti motivi; nel dopoguerra fu il sindaco Simanella, in carica dal 1947 al 1952, durante il suo mandato, a far ritornare questo divertimento popolare. Nella storia di questa festa, gli anni compresi fra il 1950 e il 1960 forse furono i più ruggenti; Castelvetrano aveva acquisito un Carnevale d’avanguardia, veramente sentito da tutta la popolazione; addirittura veniva gente dai paesi vicini, anche da Palermo, per divertirsi. “Doppu li tri re olè olè”, diceva un noto proverbio; infatti, con “la festa di li tri re” (Epifania), una volta prettamente religiosa, oggi chiamata “della befana”, cioè del consumismo e dei regali, il sei gennaio chiudeva tutta la festività e l’atmosfera natalizia, ed iniziava a taglio netto il Carnevale. Infatti, già la stessa sera alcune maschere giravano per le strade con le loro voci artefatte riscaldando e preparando l’atmosfera per la grande festa. In quei giorni e fino al giovedì grasso, si ballava soltanto in casa di amici “a parti di casa” (presso i priva ti), “dunni si teni sonu” (dove si suona), allora si diceva. Con la porta tenuta appositamente aperta, i mascherati si facevano riconoscere ed entravano. Generalmente erano delle coppie che, dopo avere ballato un “caddozzu” (un pezzo di musica) andavano via, per fare posto ad altri che arrivavano. Ma spesso si trattava di giovanotti che venivano appositamente a ballare in quella casa, perché c’era la ragazza che piaceva e che si pretendeva come fidanzata; infatti, il Carnevale era una delle pochissime occasioni per farsi fidanzati. Gli strumenti musicali possibilmente consistevano in un “friscalettu” di canna e un “cincirincì” (tamburello con i “ciancianeddi”= campanellini), ma molto spesso c’era la fisarmonica o altri strumenti musicali. In tempi più recenti si usavano i dischi con il grammofono. Negli anni ’50, gli echi della recente guerra e i suoi effetti devastanti sugli edifici e sull’economia della città erano ancora visibili, ma la gente, finalmente libera dalla dittatura e dalla guerra, aspettava con ansia il Carnevale, per scrollarsi di dosso gli orrori, la miseria e i pericoli vissuti; ma anche per dimenticarsi di essere dei miseri mortali e per godersi quegli attimi di spensieratezza e d’allegria, che la festa forniva in maniera collettiva, genuina e gratuita. Pochi potevano comprarsi il domino: una veste lunga e mantella con i bordi rossi, con cappuccio e maschera, il tutto di colore rigorosamente nero; la maggior parte portava delle maschere improvvisate, povere perché fatte con vecchi vestiti riciclati, ma spontanee, che suscitavano allegria e risata. A Castelvetrano il carnevale ruggente degli anni 50 ha tralasciato “Peppe Nappa”, la maschera classica siciliana, per la creazione di maschere che mettevano in evidenza i difetti della società, raffigurando i personaggi dei vari ceti sociali, in maniera burlesca. Così, era sorta la figura del “baruni”, rappresentato “panza parata” (cioè col pancione) e possibilmente con un paio di corna in testa, mentre per i “cappeddi”, cioè coloro che nella scala sociale portavano il cappello per distinguersi dal popolino che portava la “coppula”, c’era la maschera dei “galantuomini”, che comprendeva anche quello del “dutturi, avvocatu e iurici”; quindi c’eranu “li mastri”, cioè gli artigiani con i loro attrezzi di lavoro. Inoltre c’era la maschera del “camperi” con aspetto mafioso, “lu massariotu, lu siniaru, lu viddanu. “Lu picuraru” (il pecoraio), vestito di pelle di capra e con numerosi campanacci alla cintola, che faceva risuonare, rappresentava la personalizzazione del demonio. Infine c’era anche la figura del “parrinu” (il prete), non sempre ben visto dal popolino. Infatti un proverbio allora diceva: “Parrinu, guardacci la missa e rumpicci lu schinu” . I criticati, assistevano alla manifestazione apparentemente divertiti. Qualcuno si divertiva a portare in giro “lu cantaru” o “lu rinali” pieno di spaghetti al sugo e a mangiare con le mani. Quando un mascherato incontrava un conoscente, lo spingeva, gli ballava attorno e gli chiedeva con la voce artefatta: “Cu sugnu?”. Generalmente era una donna che, protetta dall’anonimato si divertiva a stuzzicare un uomo. L’uomo, invece, per non farsi riconoscere si metteva le scarpe da donna e si aggiungeva un petto rigonfio di stracci all’interno di un reggiseno riciclato. (i ruoli invertiti dei Saturnali). In una civiltà ancora maschilista, i petardi erano lanciati abitualmente in direzione delle donne, procurando spesso bruciature alle calze e alle gambe; la gioia di chi lanciava i botti era quello di sentire le donne gridare di spavento. Ma, spesso avvenivano fra squadre rivali delle vere battaglie con lanci di petardi. Purtroppo qualcuno si procurava danni anche gravi, come la perdita di un occhio, per un petardo esploso sul viso. I ragazzi si consolavano con “l’assicuta fimmini” e “li sparapauli” innoqui; i secondi erano delle cartine rosse con tanti piccoli rigonfiamenti, contenenti polvere da sparo; esse si facevano esplodere picchiandovi sopra con un sasso o un martello. “Li piticchi” (coriandoli) e le stelle filanti c’erano anche allora; molto in voga era “lu fetu” (la puzzolina), a volte buttata in classe dagli alunni, per far sospendere la lezione. Gli scherzi praticati venivano accettati senza offesa. Un proverbio diceva “Carnevali ogni scherzu vali, cu s’affenni è un gran maiali”. Fra gli scherzi che ricordo, ne cito qualcuno: Dei ragazzi si mettevano d’accordo di “salari” un altro ragazzo, perché troppo presuntuoso. Alcuni lo tenevano fermo, mentre un altro gli abbassava pantaloni e mutande, buttandogli addosso sul suo attributo, ufficialmente del sale, ma all’occorrenza, terriccio, cenere o gli si sputava. Un altro scherzo consisteva nell’appendere con una spilla un foglio di carta con un messaggio scritto o una figura burlesca stampata. L’ignara persona, generalmente ben vestita, andava camminando per il paese fra le risate degli astanti. Il messaggio più noto era “Cerco moglie anche usata”. A proposito di proverbi, uno diceva: “cu è fissa Carnevali o cu ci va appressu?”, un altro diceva: “Pi Sant’Antoniu (17 gennaio) mascari e soni; pi San Bastianu (20 gennaio) mascari ‘n chianu”. I cinque giovedì antecedenti al Carnevale erano molto attesi da quegli innamorati che, con i consensi dei rispettivi genitori, avevano le buone intenzioni di fidanzarsi. E’ giusto in merito aggiungere che in quegli anni è avvenuto un capovolgimento riguardo al fidanzamento. Infatti, negli anni precedenti erano i genitori a organizzare il fidanzamento con la ragazza scelta a loro insindacabile giudizio, ora era il ragazzo che sceglieva la sua fidanzata e dava comunicazione ai genitori. per averne il consenso. – Così, Il primo giovedì veniva chiamato “di li vicini”, in quel giorno si organizzavano dei balli in casa della ragazza e fra gli invitati c’era anche il ragazzo pretendente e i relativi familiari. - Nel secondo, detto “degli amici”, si ballava di nuovo; ma, se tutto procedeva bene fra le due famiglie, avveniva anche la “spiegazione” cioè l’intesa per un fidanzamento ufficiale. - Il terzo, detto “dei parenti”, in occasione del ballo si poteva festeggiare anche l’entrata ufficiale al fidanzamento (si era già parenti).- Nel quarto, detto “delle comari”, i consuoceri diventavano automaticamente anche compari e comari; ormai i due fidanzati potevano stringersi (si fa per dire, ma entro certi limiti) fra le braccia durante il ballo. - Il quinto era il “giovedì grasso”, il più conosciuto e atteso, perché dava inizio alla baldoria di piazza. In questo giorno, appunto perché grasso, si consentiva anche alle donne di parlare in maniera poco pulita. Quindi avveniva l’inversione dei ruoli secondo la consuetudine dei saturnali. Infatti, in una società maschilista le donne, anche se sposate, per Carnevale potevano permettersi certe libertà, come fare scherzi agli uomini, ballare con un altro uomo o parlare in maniera volgare (appunto grasso); esse potevano giocare agli indovinelli in dialetto “nniminagghi”, ricchi di doppi sensi e parolacce, ma che spesso avevano una soluzione più ingenua di quello che poteva sembrare. Ma c’erano anche gli scioglilingua apparentemente perfetti, che recitati in maniera svelta diventavano “vastasi”. In quel periodo, la festa era molto attesa anche per fare grandi abbuffate. Le carni di maiale e di tacchino, cucinate al ragù con la “sarsa sicca” e la “pasta di casa” fatta a “tagghiarini” o “maccarruna busiati” erano i piatti più consumati. Allora la carne di maiale conteneva uno strato considerevole di lardo che si cucinava e si mangiava assieme alla carne e alla cotenna, tagliati a pezzetti. In merito un proverbio diceva: “Pi cannalivaru si sì manciuni, mancia sosizza e maccarruni”, pietanze invece vietate il giorno di Capodanno; infatti, secondo le consuetudini, le cose rotonde, compresi cannoli e involtini, in quel giorno portavano male. Per portare allegria, il vino si consumava a fiumi. Ricordo che dal Giovedì Grasso e per sei giorni, una gran folla si riversava per le strade vestita in maschera e si divertiva a più non posso con scherzi e balli; nell’aria si sentiva un continuo frastuono, vociare, ridere, frammisto da scoppi di petardi. Qualcuno delle maschera girava con l’asinello, che quando era stanco si coricava per terra o incominciava a tirare calci. Altri portavano la scritta: “cerco moglie anche usata, non importa se bucata”; una battuta provocatoria per quegli anni. Si ballava presso tutti i circoli ricreativi e culturali, come il Circolo della Gioventù, la Società Operaia, il Circolo Pirandello, il Circolo Cacciatori, il Motoclub, ai cinema: Capitol, Palme, Marconi, al Dopolavoro Ferroviario (detto il Pirocchino), alla sala bigliardi (in via Marconi), ma si ballava anche “a lu chianu” (Piazza Garibaldi, piazza per antonomasia), con l’orchestrina che suonava. Si ballava pure “a parti di casa”. Sembrava proprio che tutti dicessero: “Chi vuol esser lieto sia di doman non c’è certezza”. Parallelamente agli amori umili e sinceri dei giovani popolani, che aspettavano il Carnevale per la realizzazione dei propri sogni, c’erano gli amori clandestini fra uomini maturi sposati, con altrettante donne compiacenti che, approfittando dell’anonimato garantito dalla maschera, realizzavano i loro sogni illegittimi. “Li sdirri” erano chiamati i tre giorni più caldi del Carnevale, ma anche gli ultimi. Gianni Diecidue asserisce che il vocabolo “sdirri”, gli ultimi giorni del Carnevale, derivi dal francese dernier. Secondo una mia interpretazione “sdirri” in siciliano significa ultimi; infatti, se analizziamo il vocabolo, questo si divide in sdi + irri, dove il prefisso “sdi” dà un significato inverso della parola che segue: (es. sdari = non dare), mentre “irri” significa irritare, arrabbiare, rabbia; quindi “sdirri” significa il contrario di rabia, cioè gioia, festa. Sdirriduminica, sdirrilunniri, sdirrimartiri”, cioè domenica, lunedì e martedì prima delle Ceneri, rappresentavano il culmine della festa. Un proverbio siciliano dice in merito: “tuttu l’annu cu cu voi e li sdirri cu li toi”. Il proverbio aveva delle fondamenta, perché il “sdirri martiri” c’era una grande abbuffata in casa del capo famiglia, con la presenza di tutti i figli e nipoti. Possibilmente si mangiava “pasta a scannaturi” con maccheroni fatti in casa con stufato di maiale, e, come caratteristica mangiata con le “forchette d’Adamo” (con le mani), seguiva la salsiccia arrostita o la carne di maiale cucinata a stufato, “vinu di utti” (genuino) in abbondanza e a volontà per creare allegria e per ultimo “lu scacciu” frutta secca, ceci e fave abbrustoliti. Nel corso dell’abbuffata, qualcuno che sapeva poetare improvvisava il brindisi. Fra i miei ricordi di un lontano passato, In questi tre giorni di baldoria in Piazza Garibaldi c’erano dei contadini - poeti, posti su dei carri, si prendevano in giro improvvisando discorsi in rima baciata. Infatti, nella scomparsa civiltà contadina analfabeta, nella cultura popolare c’erano molti contadini che sapevano verseggiare in rima baciata, improvvisando e conversando in rima. Di questo lontano passato ci sono rimaste bellissime poesie d’amore, ricche di sentimenti.
ti), “dunni si teni sonu” (dove si suona), allora si diceva. Con la porta tenuta appositamente aperta, i mascherati si facevano riconoscere ed entravano. Generalmente erano delle coppie che, dopo avere ballato un “caddozzu” (un pezzo di musica) andavano via, per fare posto ad altri che arrivavano. Ma spesso si trattava di giovanotti che venivano appositamente a ballare in quella casa, perché c’era la ragazza che piaceva e che si pretendeva come fidanzata; infatti, il Carnevale era una delle pochissime occasioni per farsi fidanzati. Gli strumenti musicali possibilmente consistevano in un “friscalettu” di canna e un “cincirincì” (tamburello con i “ciancianeddi”= campanellini), ma molto spesso c’era la fisarmonica o altri strumenti musicali. In tempi più recenti si usavano i dischi con il grammofono. Negli anni ’50, gli echi della recente guerra e i suoi effetti devastanti sugli edifici e sull’economia della città erano ancora visibili, ma la gente, finalmente libera dalla dittatura e dalla guerra, aspettava con ansia il Carnevale, per scrollarsi di dosso gli orrori, la miseria e i pericoli vissuti; ma anche per dimenticarsi di essere dei miseri mortali e per godersi quegli attimi di spensieratezza e d’allegria, che la festa forniva in maniera collettiva, genuina e gratuita. Pochi potevano comprarsi il domino: una veste lunga e mantella con i bordi rossi, con cappuccio e maschera, il tutto di colore rigorosamente nero; la maggior parte portava delle maschere improvvisate, povere perché fatte con vecchi vestiti riciclati, ma spontanee, che suscitavano allegria e risata. A Castelvetrano il carnevale ruggente degli anni 50 ha tralasciato “Peppe Nappa”, la maschera classica siciliana, per la creazione di maschere che mettevano in evidenza i difetti della società, raffigurando i personaggi dei vari ceti sociali, in maniera burlesca. Così, era sorta la figura del “baruni”, rappresentato “panza parata” (cioè col pancione) e possibilmente con un paio di corna in testa, mentre per i “cappeddi”, cioè coloro che nella scala sociale portavano il cappello per distinguersi dal popolino che portava la “coppula”, c’era la maschera dei “galantuomini”, che comprendeva anche quello del “dutturi, avvocatu e iurici”; quindi c’eranu “li mastri”, cioè gli artigiani con i loro attrezzi di lavoro. Inoltre c’era la maschera del “camperi” con aspetto mafioso, “lu massariotu, lu siniaru, lu viddanu. “Lu picuraru” (il pecoraio), vestito di pelle di capra e con numerosi campanacci alla cintola, che faceva risuonare, rappresentava la personalizzazione del demonio. Infine c’era anche la figura del “parrinu” (il prete), non sempre ben visto dal popolino. Infatti un proverbio allora diceva: “Parrinu, guardacci la missa e rumpicci lu schinu” . I criticati, assistevano alla manifestazione apparentemente divertiti. Qualcuno si divertiva a portare in giro “lu cantaru” o “lu rinali” pieno di spaghetti al sugo e a mangiare con le mani. Quando un mascherato incontrava un conoscente, lo spingeva, gli ballava attorno e gli chiedeva con la voce artefatta: “Cu sugnu?”. Generalmente era una donna che, protetta dall’anonimato si divertiva a stuzzicare un uomo. L’uomo, invece, per non farsi riconoscere si metteva le scarpe da donna e si aggiungeva un petto rigonfio di stracci all’interno di un reggiseno riciclato. (i ruoli invertiti dei Saturnali). In una civiltà ancora maschilista, i petardi erano lanciati abitualmente in direzione delle donne, procurando spesso bruciature alle calze e alle gambe; la gioia di chi lanciava i botti era quello di sentire le donne gridare di spavento. Ma, spesso avvenivano fra squadre rivali delle vere battaglie con lanci di petardi. Purtroppo qualcuno si procurava danni anche gravi, come la perdita di un occhio, per un petardo esploso sul viso. I ragazzi si consolavano con “l’assicuta fimmini” e “li sparapauli” innoqui; i secondi erano delle cartine rosse con tanti piccoli rigonfiamenti, contenenti polvere da sparo; esse si facevano esplodere picchiandovi sopra con un sasso o un martello. “Li piticchi” (coriandoli) e le stelle filanti c’erano anche allora; molto in voga era “lu fetu” (la puzzolina), a volte buttata in classe dagli alunni, per far sospendere la lezione. Gli scherzi praticati venivano accettati senza offesa. Un proverbio diceva “Carnevali ogni scherzu vali, cu s’affenni è un gran maiali”. Fra gli scherzi che ricordo, ne cito qualcuno: Dei ragazzi si mettevano d’accordo di “salari” un altro ragazzo, perché troppo presuntuoso. Alcuni lo tenevano fermo, mentre un altro gli abbassava pantaloni e mutande, buttandogli addosso sul suo attributo, ufficialmente del sale, ma all’occorrenza, terriccio, cenere o gli si sputava. Un altro scherzo consisteva nell’appendere con una spilla un foglio di carta con un messaggio scritto o una figura burlesca stampata. L’ignara persona, generalmente ben vestita, andava camminando per il paese fra le risate degli astanti. Il messaggio più noto era “Cerco moglie anche usata”. A proposito di proverbi, uno diceva: “cu è fissa Carnevali o cu ci va appressu?”, un altro diceva: “Pi Sant’Antoniu (17 gennaio) mascari e soni; pi San Bastianu (20 gennaio) mascari ‘n chianu”. I cinque giovedì antecedenti al Carnevale erano molto attesi da quegli innamorati che, con i consensi dei rispettivi genitori, avevano le buone intenzioni di fidanzarsi. E’ giusto in merito aggiungere che in quegli anni è avvenuto un capovolgimento riguardo al fidanzamento. Infatti, negli anni precedenti erano i genitori a organizzare il fidanzamento con la ragazza scelta a loro insindacabile giudizio, ora era il ragazzo che sceglieva la sua fidanzata e dava comunicazione ai genitori. per averne il consenso. – Così, Il primo giovedì veniva chiamato “di li vicini”, in quel giorno si organizzavano dei balli in casa della ragazza e fra gli invitati c’era anche il ragazzo pretendente e i relativi familiari. - Nel secondo, detto “degli amici”, si ballava di nuovo; ma, se tutto procedeva bene fra le due famiglie, avveniva anche la “spiegazione” cioè l’intesa per un fidanzamento ufficiale. - Il terzo, detto “dei parenti”, in occasione del ballo si poteva festeggiare anche l’entrata ufficiale al fidanzamento (si era già parenti).- Nel quarto, detto “delle comari”, i consuoceri diventavano automaticamente anche compari e comari; ormai i due fidanzati potevano stringersi (si fa per dire, ma entro certi limiti) fra le braccia durante il ballo. - Il quinto era il “giovedì grasso”, il più conosciuto e atteso, perché dava inizio alla baldoria di piazza. In questo giorno, appunto perché grasso, si consentiva anche alle donne di parlare in maniera poco pulita. Quindi avveniva l’inversione dei ruoli secondo la consuetudine dei saturnali. Infatti, in una società maschilista le donne, anche se sposate, per Carnevale potevano permettersi certe libertà, come fare scherzi agli uomini, ballare con un altro uomo o parlare in maniera volgare (appunto grasso); esse potevano giocare agli indovinelli in dialetto “nniminagghi”, ricchi di doppi sensi e parolacce, ma che spesso avevano una soluzione più ingenua di quello che poteva sembrare. Ma c’erano anche gli scioglilingua apparentemente perfetti, che recitati in maniera svelta diventavano “vastasi”. In quel periodo, la festa era molto attesa anche per fare grandi abbuffate. Le carni di maiale e di tacchino, cucinate al ragù con la “sarsa sicca” e la “pasta di casa” fatta a “tagghiarini” o “maccarruna busiati” erano i piatti più consumati. Allora la carne di maiale conteneva uno strato considerevole di lardo che si cucinava e si mangiava assieme alla carne e alla cotenna, tagliati a pezzetti. In merito un proverbio diceva: “Pi cannalivaru si sì manciuni, mancia sosizza e maccarruni”, pietanze invece vietate il giorno di Capodanno; infatti, secondo le consuetudini, le cose rotonde, compresi cannoli e involtini, in quel giorno portavano male. Per portare allegria, il vino si consumava a fiumi. Ricordo che dal Giovedì Grasso e per sei giorni, una gran folla si riversava per le strade vestita in maschera e si divertiva a più non posso con scherzi e balli; nell’aria si sentiva un continuo frastuono, vociare, ridere, frammisto da scoppi di petardi. Qualcuno delle maschera girava con l’asinello, che quando era stanco si coricava per terra o incominciava a tirare calci. Altri portavano la scritta: “cerco moglie anche usata, non importa se bucata”; una battuta provocatoria per quegli anni. Si ballava presso tutti i circoli ricreativi e culturali, come il Circolo della Gioventù, la Società Operaia, il Circolo Pirandello, il Circolo Cacciatori, il Motoclub, ai cinema: Capitol, Palme, Marconi, al Dopolavoro Ferroviario (detto il Pirocchino), alla sala bigliardi (in via Marconi), ma si ballava anche “a lu chianu” (Piazza Garibaldi, piazza per antonomasia), con l’orchestrina che suonava. Si ballava pure “a parti di casa”. Sembrava proprio che tutti dicessero: “Chi vuol esser lieto sia di doman non c’è certezza”. Parallelamente agli amori umili e sinceri dei giovani popolani, che aspettavano il Carnevale per la realizzazione dei propri sogni, c’erano gli amori clandestini fra uomini maturi sposati, con altrettante donne compiacenti che, approfittando dell’anonimato garantito dalla maschera, realizzavano i loro sogni illegittimi. “Li sdirri” erano chiamati i tre giorni più caldi del Carnevale, ma anche gli ultimi. Gianni Diecidue asserisce che il vocabolo “sdirri”, gli ultimi giorni del Carnevale, derivi dal francese dernier. Secondo una mia interpretazione “sdirri” in siciliano significa ultimi; infatti, se analizziamo il vocabolo, questo si divide in sdi + irri, dove il prefisso “sdi” dà un significato inverso della parola che segue: (es. sdari = non dare), mentre “irri” significa irritare, arrabbiare, rabbia; quindi “sdirri” significa il contrario di rabia, cioè gioia, festa. Sdirriduminica, sdirrilunniri, sdirrimartiri”, cioè domenica, lunedì e martedì prima delle Ceneri, rappresentavano il culmine della festa. Un proverbio siciliano dice in merito: “tuttu l’annu cu cu voi e li sdirri cu li toi”. Il proverbio aveva delle fondamenta, perché il “sdirri martiri” c’era una grande abbuffata in casa del capo famiglia, con la presenza di tutti i figli e nipoti. Possibilmente si mangiava “pasta a scannaturi” con maccheroni fatti in casa con stufato di maiale, e, come caratteristica mangiata con le “forchette d’Adamo” (con le mani), seguiva la salsiccia arrostita o la carne di maiale cucinata a stufato, “vinu di utti” (genuino) in abbondanza e a volontà per creare allegria e per ultimo “lu scacciu” frutta secca, ceci e fave abbrustoliti. Nel corso dell’abbuffata, qualcuno che sapeva poetare improvvisava il brindisi. Fra i miei ricordi di un lontano passato, In questi tre giorni di baldoria in Piazza Garibaldi c’erano dei contadini - poeti, posti su dei carri, si prendevano in giro improvvisando discorsi in rima baciata. Infatti, nella scomparsa civiltà contadina analfabeta, nella cultura popolare c’erano molti contadini che sapevano verseggiare in rima baciata, improvvisando e conversando in rima. Di questo lontano passato ci sono rimaste bellissime poesie d’amore, ricche di sentimenti.