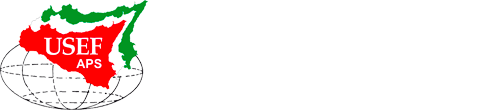Se si volge lo sguardo all’indietro, a rintracciare le radici della lingua italiana, ci si accorge di come esse affondino in un terreno variegato ma unitario, quello conquistato e governato dai Romani fino alla caduta definitiva dell’Impero d’Occidente (476). Tuttavia, per oltre mille anni, fino a quando,
Se si volge lo sguardo all’indietro, a rintracciare le radici della lingua italiana, ci si accorge di come esse affondino in un terreno variegato ma unitario, quello conquistato e governato dai Romani fino alla caduta definitiva dell’Impero d’Occidente (476). Tuttavia, per oltre mille anni, fino a quando, nel 1861, fu sancita l’unità d’Italia, la penisola italiana è stata terra politicamente e linguisticamente frammentata. Infatti, dopo il crollo di Roma, la frantumazione politica e sociale, il riemergere delle parlate preesistenti al latino (lingue di substrato), che si mescolavano alle nuove lingue dei popoli invasori, l’analfabetismo e la separazione tra regione e regione, fecero sì che il latino parlato si trasformasse in tante lingue diverse: i cosiddetti volgari italiani (dal latino vulgus, popolo), mentre invece la lingua latina scritta rimase quasi immutata e riservata all’alta cultura. Nel Medioevo, dunque, l’Italia era un mosaico di lingue localmente diverse. Dopo l’anno Mille ci fu una ripresa dei commerci e la rinascita delle città, successivamente, dalla realtà comunale si passò alle Signorie, su basi regionali e poi anche interregionali che, tuttavia, non assicuravano un’autorità centrale né, quindi, l’unità linguistica. La spinta in tal senso venne dalla letteratura e in quell’ambito rimase confinata ancora per secoli. Iniziarono a scrivere in volgare San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi in ambito religioso, per essere compresi anche da chi non conosceva il latino. Proseguirono i poeti siciliani, Guittone d’Arezzo e poi gli stilnovisti in Toscana. Furono però le tre corone trecentesche, Dante, Petrarca e Boccaccio che, scrivendo i loro capolavori in tosco-fiorentino, nobilitarono tale volgare, consacrandolo come lingua ufficiale della cultura al di là del latino. L’Umanesimo quattrocentesco, con la rivalutazione dei classici e quindi del latino, fece passare in secondo piano l’uso del volgare, ma fu solo una parentesi. Nel Cinquecento, infatti, venne riconosciuta definitivamente la dignità letteraria della lingua volgare e nell’accesa discussione su di essa ebbe la meglio la proposta di Pietro Bembo, che indicava, come modello di lingua, Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. Dunque, il fiorentino si affermava unitariamente sul piano letterario, grazie all’impegno e all’entusiasmo degli intellettuali di tutta la penisola, ma era parlato solo a Firenze. Nonostante le premesse fossero state gettate in ambito culturale, le dominazioni straniere, che si susseguirono in Italia dall’ XI al XIX secolo, ancora una volta non favorirono l’unificazione linguistica italiana. La situazione mutò nel corso dell’Ottocento. La classe borghese che andava affermandosi avvertiva l’esigenza di una lingua di tono medio, che sostituisse il dialetto nell’ambito professionale e nella conversazione quotidiana. Gli intellettuali romantici se ne fecero portavoce chiedendo una lingua italiana unitaria comprensibile per tutti. Manzoni rispose scrivendo I Promessi sposi nel fiorentino vivo colto e proponendolo quale lingua della futura nazione italiana. Con le lotte e le guerre risorgimentali l’Italia raggiunse l’unità politica e il neonato Regno d’Italia adottò la soluzione linguistica manzoniana: si avviava il lento processo che avrebbe portato l’Italiano a diventare patrimonio di tutti gli strati sociali. L’analfabetismo, però, era la piaga che affliggeva il popolo italiano, ostacolando l’affermazione di una lingua d’uso unitaria. Furono i fenomeni migratori interni alla penisola, l’estensione dell’obbligo scolastico, la leva obbligatoria e l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa nel Novecento a favorire la diffusione della lingua italiana e dell’italianità in tutto il Paese, relegando i dialetti a un uso quasi esclusivamente locale e familiare. Il processo di italianizzazione è ancora in atto e l’Italiano, pur avendo raggiunto un alto livello di standardizzazione, conserva varietà regionali e locali, specchio della sua storia. (fonte: echo - Martina Buccione)
 Se si volge lo sguardo all’indietro, a rintracciare le radici della lingua italiana, ci si accorge di come esse affondino in un terreno variegato ma unitario, quello conquistato e governato dai Romani fino alla caduta definitiva dell’Impero d’Occidente (476). Tuttavia, per oltre mille anni, fino a quando, nel 1861, fu sancita l’unità d’Italia, la penisola italiana è stata terra politicamente e linguisticamente frammentata. Infatti, dopo il crollo di Roma, la frantumazione politica e sociale, il riemergere delle parlate preesistenti al latino (lingue di substrato), che si mescolavano alle nuove lingue dei popoli invasori, l’analfabetismo e la separazione tra regione e regione, fecero sì che il latino parlato si trasformasse in tante lingue diverse: i cosiddetti volgari italiani (dal latino vulgus, popolo), mentre invece la lingua latina scritta rimase quasi immutata e riservata all’alta cultura. Nel Medioevo, dunque, l’Italia era un mosaico di lingue localmente diverse. Dopo l’anno Mille ci fu una ripresa dei commerci e la rinascita delle città, successivamente, dalla realtà comunale si passò alle Signorie, su basi regionali e poi anche interregionali che, tuttavia, non assicuravano un’autorità centrale né, quindi, l’unità linguistica. La spinta in tal senso venne dalla letteratura e in quell’ambito rimase confinata ancora per secoli. Iniziarono a scrivere in volgare San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi in ambito religioso, per essere compresi anche da chi non conosceva il latino. Proseguirono i poeti siciliani, Guittone d’Arezzo e poi gli stilnovisti in Toscana. Furono però le tre corone trecentesche, Dante, Petrarca e Boccaccio che, scrivendo i loro capolavori in tosco-fiorentino, nobilitarono tale volgare, consacrandolo come lingua ufficiale della cultura al di là del latino. L’Umanesimo quattrocentesco, con la rivalutazione dei classici e quindi del latino, fece passare in secondo piano l’uso del volgare, ma fu solo una parentesi. Nel Cinquecento, infatti, venne riconosciuta definitivamente la dignità letteraria della lingua volgare e nell’accesa discussione su di essa ebbe la meglio la proposta di Pietro Bembo, che indicava, come modello di lingua, Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. Dunque, il fiorentino si affermava unitariamente sul piano letterario, grazie all’impegno e all’entusiasmo degli intellettuali di tutta la penisola, ma era parlato solo a Firenze. Nonostante le premesse fossero state gettate in ambito culturale, le dominazioni straniere, che si susseguirono in Italia dall’ XI al XIX secolo, ancora una volta non favorirono l’unificazione linguistica italiana. La situazione mutò nel corso dell’Ottocento. La classe borghese che andava affermandosi avvertiva l’esigenza di una lingua di tono medio, che sostituisse il dialetto nell’ambito professionale e nella conversazione quotidiana. Gli intellettuali romantici se ne fecero portavoce chiedendo una lingua italiana unitaria comprensibile per tutti. Manzoni rispose scrivendo I Promessi sposi nel fiorentino vivo colto e proponendolo quale lingua della futura nazione italiana. Con le lotte e le guerre risorgimentali l’Italia raggiunse l’unità politica e il neonato Regno d’Italia adottò la soluzione linguistica manzoniana: si avviava il lento processo che avrebbe portato l’Italiano a diventare patrimonio di tutti gli strati sociali. L’analfabetismo, però, era la piaga che affliggeva il popolo italiano, ostacolando l’affermazione di una lingua d’uso unitaria. Furono i fenomeni migratori interni alla penisola, l’estensione dell’obbligo scolastico, la leva obbligatoria e l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa nel Novecento a favorire la diffusione della lingua italiana e dell’italianità in tutto il Paese, relegando i dialetti a un uso quasi esclusivamente locale e familiare. Il processo di italianizzazione è ancora in atto e l’Italiano, pur avendo raggiunto un alto livello di standardizzazione, conserva varietà regionali e locali, specchio della sua storia. (fonte: echo - Martina Buccione)
Se si volge lo sguardo all’indietro, a rintracciare le radici della lingua italiana, ci si accorge di come esse affondino in un terreno variegato ma unitario, quello conquistato e governato dai Romani fino alla caduta definitiva dell’Impero d’Occidente (476). Tuttavia, per oltre mille anni, fino a quando, nel 1861, fu sancita l’unità d’Italia, la penisola italiana è stata terra politicamente e linguisticamente frammentata. Infatti, dopo il crollo di Roma, la frantumazione politica e sociale, il riemergere delle parlate preesistenti al latino (lingue di substrato), che si mescolavano alle nuove lingue dei popoli invasori, l’analfabetismo e la separazione tra regione e regione, fecero sì che il latino parlato si trasformasse in tante lingue diverse: i cosiddetti volgari italiani (dal latino vulgus, popolo), mentre invece la lingua latina scritta rimase quasi immutata e riservata all’alta cultura. Nel Medioevo, dunque, l’Italia era un mosaico di lingue localmente diverse. Dopo l’anno Mille ci fu una ripresa dei commerci e la rinascita delle città, successivamente, dalla realtà comunale si passò alle Signorie, su basi regionali e poi anche interregionali che, tuttavia, non assicuravano un’autorità centrale né, quindi, l’unità linguistica. La spinta in tal senso venne dalla letteratura e in quell’ambito rimase confinata ancora per secoli. Iniziarono a scrivere in volgare San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi in ambito religioso, per essere compresi anche da chi non conosceva il latino. Proseguirono i poeti siciliani, Guittone d’Arezzo e poi gli stilnovisti in Toscana. Furono però le tre corone trecentesche, Dante, Petrarca e Boccaccio che, scrivendo i loro capolavori in tosco-fiorentino, nobilitarono tale volgare, consacrandolo come lingua ufficiale della cultura al di là del latino. L’Umanesimo quattrocentesco, con la rivalutazione dei classici e quindi del latino, fece passare in secondo piano l’uso del volgare, ma fu solo una parentesi. Nel Cinquecento, infatti, venne riconosciuta definitivamente la dignità letteraria della lingua volgare e nell’accesa discussione su di essa ebbe la meglio la proposta di Pietro Bembo, che indicava, come modello di lingua, Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. Dunque, il fiorentino si affermava unitariamente sul piano letterario, grazie all’impegno e all’entusiasmo degli intellettuali di tutta la penisola, ma era parlato solo a Firenze. Nonostante le premesse fossero state gettate in ambito culturale, le dominazioni straniere, che si susseguirono in Italia dall’ XI al XIX secolo, ancora una volta non favorirono l’unificazione linguistica italiana. La situazione mutò nel corso dell’Ottocento. La classe borghese che andava affermandosi avvertiva l’esigenza di una lingua di tono medio, che sostituisse il dialetto nell’ambito professionale e nella conversazione quotidiana. Gli intellettuali romantici se ne fecero portavoce chiedendo una lingua italiana unitaria comprensibile per tutti. Manzoni rispose scrivendo I Promessi sposi nel fiorentino vivo colto e proponendolo quale lingua della futura nazione italiana. Con le lotte e le guerre risorgimentali l’Italia raggiunse l’unità politica e il neonato Regno d’Italia adottò la soluzione linguistica manzoniana: si avviava il lento processo che avrebbe portato l’Italiano a diventare patrimonio di tutti gli strati sociali. L’analfabetismo, però, era la piaga che affliggeva il popolo italiano, ostacolando l’affermazione di una lingua d’uso unitaria. Furono i fenomeni migratori interni alla penisola, l’estensione dell’obbligo scolastico, la leva obbligatoria e l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa nel Novecento a favorire la diffusione della lingua italiana e dell’italianità in tutto il Paese, relegando i dialetti a un uso quasi esclusivamente locale e familiare. Il processo di italianizzazione è ancora in atto e l’Italiano, pur avendo raggiunto un alto livello di standardizzazione, conserva varietà regionali e locali, specchio della sua storia. (fonte: echo - Martina Buccione)