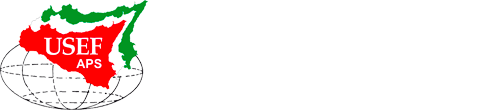LU STAZZUNI L’argilla è la materia prima di cui l’uomo può disporre in maniera più abbondante e gratuita; la sua lavorazione risale ai primi albori della civiltà. “Li stazzunara” erano gli abili artigiani che lavorando l’argilla ottenevano tutti quegli oggetti di terracotta sotto descritti,
LU STAZZUNI L’argilla è la materia prima di cui l’uomo può disporre in maniera più abbondante e gratuita; la sua lavorazione risale ai primi albori della civiltà. “Li stazzunara” erano gli abili artigiani che lavorando l’argilla ottenevano tutti quegli oggetti di terracotta sotto descritti,
 considerati indispensabili alla sopravvivenza umana fino a mezzo secolo fa. Merito dei reperti archeologici in terracotta recuperati, si è ricostruita parte della storia dell’umanità, già dimenticata. Fra i miei ricordi della vecchia Castelvetrano, offuscati dal tempo rivedo "stazzuna" (fabbrica di vasellami e vari) in Via XX Settembre, di fronte della chiesa della SS.Annunziata di proprietà della famiglia Filardo, in Via Scinà della famiglia Gino; c'era anche la famiglia Giancontieri, che continua ancora l'attività e le famiglie Giglio e Leone, stazzunara di cui ho sentito parlare. Purtroppo, gli articoli di plastica e di ceramica, provenienti dall’Italia Settentrionale, hanno soppiantato con la loro praticità e concorrenza sul prezzo, i nostri prodotti artigianali di terracotta; il terremoto del '68, che ha danneggiato le strutture dei numerosi “stazzuna” esistenti nella valle del Belìce, ha scagliato il colpo di grazia, facendone cessare ogni attività. La lavorazione dell'argilla era lunga e laboriosa; siccome richiedeva molta mano d'opera, si utilizzava il lavoro minorile a basso costo e quello di tutti i propri familiari, comprese le donne. Chi praticava questo mestiere aveva delle possibilità di buoni guadagni; ma tutto dipendeva dalla sua perizia e dagli eventi eccezionalmente favorevoli delle condizioni atmosferiche. In merito un antico proverbio siciliano diceva: -
considerati indispensabili alla sopravvivenza umana fino a mezzo secolo fa. Merito dei reperti archeologici in terracotta recuperati, si è ricostruita parte della storia dell’umanità, già dimenticata. Fra i miei ricordi della vecchia Castelvetrano, offuscati dal tempo rivedo "stazzuna" (fabbrica di vasellami e vari) in Via XX Settembre, di fronte della chiesa della SS.Annunziata di proprietà della famiglia Filardo, in Via Scinà della famiglia Gino; c'era anche la famiglia Giancontieri, che continua ancora l'attività e le famiglie Giglio e Leone, stazzunara di cui ho sentito parlare. Purtroppo, gli articoli di plastica e di ceramica, provenienti dall’Italia Settentrionale, hanno soppiantato con la loro praticità e concorrenza sul prezzo, i nostri prodotti artigianali di terracotta; il terremoto del '68, che ha danneggiato le strutture dei numerosi “stazzuna” esistenti nella valle del Belìce, ha scagliato il colpo di grazia, facendone cessare ogni attività. La lavorazione dell'argilla era lunga e laboriosa; siccome richiedeva molta mano d'opera, si utilizzava il lavoro minorile a basso costo e quello di tutti i propri familiari, comprese le donne. Chi praticava questo mestiere aveva delle possibilità di buoni guadagni; ma tutto dipendeva dalla sua perizia e dagli eventi eccezionalmente favorevoli delle condizioni atmosferiche. In merito un antico proverbio siciliano diceva: -
"Arti di crita misira e minnica, ma si ti 'nzerta ti vesti di sita". (l'arte dell'argilla è povera e mendica, ma se ti vabene ti veste con vestiti di seta).
Un bravo “stazzunaru" doveva essere "mastru di crita", cioè un bravo cononoscitore dell'argilla, doveva conoscere bene l'arte della costruzione di mattoni e tegole e poteva essere anche "mastru di torniu", cioè un bravo artigiano capace di creare recipienti vari e utensili con l'ausilio del tornio. Egli faceva girare il tornio spingendo, con il piede, una ruota posta in basso. Questo artigiano, inconsapevolmente, nella sua materia era anche un chimico, poiché, sfruttando la sua lunga esperienza, al fine di renderne la qualità più fine, doveva “cunzari” l’argilla con l’aggiunta d’acqua, sabbia, sale ed altri materiali dimagranti nelle giuste proporzioni; inoltre, senza strumenti scientifici, doveva saper graduare di volta in volta la temperatura del forno e la durata di cottura. Questa esperienza si incominciava ad acquisire da bambini, lavorando l'argilla a stretto contatto con i genitori. Così, passo dopo passo, essi imparavano i trucchi del mestiere. L'argilla prelevata dalla cava era lasciata a mucchi sul piazzale, e lì si lasciava da due a quattro giorni, secondo gli oggetti da lavorare, al fine di farla stagionare al contatto con l'aria. Quindi, si metteva in una vasca circolare chiamata “màuta” (fango) e, dopo avere aggiunto acqua e altri materiali dimagranti, il giorno dopo s’impastava con i piedi e con l'ausilio del cavallo per circa quattro ore. I materiali aggiunti andavano dalla "rrina di mari" (sabbia), con una percentuale che andava dal 3 al 20%, sale 1%, e concime stallatico di cavalli e muli, essiccato e polverizzato; solo per la costruzione di tegole e mattoni, si aggiungeva paglia tritata o "ciusca" (pula). Con questa materia prima si preparavano dei blocchetti "badduna"; da ognuno di essi uscivano, dopo la lavorazione con il tornio o con gli stampi, gli oggetti voluti. I prodotti lavorati così ottenuti si mettevano ad asciugare al sole. Qui iniziavano i forti rischi, che potevano compromettere tutta la lavorazione: un sole troppo forte, un vento di scirocco, sbalzi di temperatura, pioggia e "acquazzina e sirenu" (umidità della notte). Tutti i pezzi, quando erano veramente asciutti, si passavano nel forno per la cottura. Qui il vasellame restava dalle 14 alle 18 ore, mentre per gli altri prodotti dalle 28 alle 30 ore. Nella cottura era necessaria un’abilità e perizia non comune. Chi era addetto alla cottura, in mancanza di strumenti tecnici di misurazione, si affidava alla sua lunga esperienza in materia; costui, attraverso il colore assunto dai manufatti, dalla fiamma e dall’odore della combustione si accorgeva se tutto andava per il meglio ed eventualmente interveniva per aumentare o diminuire la caloria. Per venti ore si doveva alimentare il fuoco mantenendo la temperatura sui 1000 gradi circa, con una fiamma sempre viva alimentata da un combustibile locale a base di segatura, legna d'ulivo, "nozzulu" (sansa), vinaccia. Un minimo errore di cottura o un piccolo difetto del forno, poteva compromettere tutta la produzione. La fornace aveva una forma cilindrica verticale con la “vucca di l’arsu” (bocca per il fuoco) a piano ribassato, mentre il vasellame era posto nel “furnu” (camera di cottura) a due metri d’altezza sistemato sopra il “dammusu”, traforato per far passare il calore. La parte superiore terminava con la “cubbulina” un tetto a cupola con un foro al centro terminante con la “ciminia” (canna fumaria). Nella camera di cottura si praticava ogni volta un varco per permettere il carico del materiale; al momento della cottura veniva chiuso. Queste notizie sono frutto di tanti mie ricordi accumulati nel tempo; inoltre ho appreso molto nel 1963-64, parlando con “li stazzunara” che lavoravano, presso "La Fornace S. Nicola", una fabbrica di laterizi dove ero impiegato come ragioniere; inoltre mi sono documentato su libri e documenti vari che ho consultato. Un proverbio siciliano sull’argilla dice: “Lu ‘ncritatu è lu patruni di lu sceccu”; mentre un altro dice: “Arti di focu, cu ni sapi assai ni sapi pocu”. I prodotti più comuni lavorati negli “stazzuna” erano:
- Canali = tegole per la copertura di tetti; quelle che poggiavano direttamente sul tetto si chiamavano “currenti” e su di esse scorreva l’acqua piovana; esse erano più strette e più lunghe delle altre che andavano a coprirle. Con le tegole sostenute da "cascavadduzzi” si ottenevano le linee di gronda "canalati".
- Maruna = mattoni per pavimenti; potevano essere normali o "stagnati" (smaltati).
- Parmarizza = mattoni rettangolari per copertura di solai; detti così, perché misuravano “due palmi” per la lunghezza e “un parmu” per la larghezza.
- Pantofuli = mattoni per rivestire l'interno dei forni e per l’edilizia.
- Maruna di scala = mattoni più larghi per i gradini delle scale.
- Cascavadduzzi = mattoni rettangolari usati come sostegno dei “canalati” (canali di Gronda). Collocati di taglio, servivano per ammattonare stalle e scalini d'ingresso.
- Dubbuluna = mattoni quadrati per ammattonare il piano di cottura dei forni.
- Catusa = tubi per condotte d'acqua potabile e d'irrigazione, per fognature o per lo scolo delle acque piovane e per fumaioli; le misure variavano secondo l'uso di destinazione.
- Catusa a vuvitu = tubi con curva a gomito.
- Giarrotta a mutu = raccoglitore d'acqua piovana dai tetti, a forma d'imbuto.
- Giarrotta a tianu = raccoglitore d'acqua con uscita di davanti. - Giarrotta pi jisterna = raccoglitore d'acqua con due uscite: consentiva di deviare l'acqua piovana proveniente dai tetti, in maniera alternata fra la strada (dopo le prime piogge, che lavavano i tetti) e una cisterna di raccolta. L'acqua di "cota" era indispensabile per l’uso domestico.
- Quartara = contenitore per acqua potabile. Chiamata così perché misurava ¼ di barile. Altri contenitori per acqua potabile, con forma e dimensioni diverse si chiamavano: Nziru, bummulu, bummuliddu, lancedda, giarrotta.
- “Ciascu e bburraccia” = piccolo contenitore per vino.
- “Giarra” (orcio, giara) = grosso contenitore per graminacei; “giarra stagnata” per contenere olio.
- “Tianu, cazzalora e pignata” = pentole, recipienti per cucinare.
- Carruseddi = salvadanai. Per estrarne il contenuto si dovevano rompere.
- Murtara = mortai con il fondo robusto e pestello di legno.
- Cannata = boccale per vino. - Cupuni = tappo per grosse botti con cappello traforato. Durante la fermentazione permetteva di arieggiare bene il mosto evitando una fermentazione tumultuosa.
- Mutu = grosso imbuto per il travaso del vino (i piccoli imbuti per la cucina erano fatti di latta).
- Agghialoru o ugghialoru = contenitore per olio da tavola. Oliera.
- Sculapasta = scolapasta.
- Cuscusera = pentola speciale per la preparazione del cuscus.
- Bburnia = vaso con due manici, smaltato all'interno, usato per tenervi sale, conserva di pomodoro, olive schiacciate o salate, sottaceti.
- Rasta (o grasta)= vaso per fiori (nel trapanese viene chiamato "casaria").
- Lemmi = cestello a quattro manici ad orecchiette, per lavare e candeggiare i panni.
- Spicchiu = lucerna ad olio (con stoppino di cotone).
-Cannila cu li peri = portacandela.
-Trappitara = da “trappitu” (frantoio) era una lucerna a forma piramidale con circa 30 “spicchi” disposti su tre ordini.
-Cannileri = porta candela.
-Mariteddu o scrafamanu = scaldino senza manici, rotondo, alti cm. 30 e del diametro di cm. 20, contenente carbonella accesa, usato per riscaldare le mani.
-Tannura = piccolo fornello a carbone a forma troncoconica con due manici. Sull'orlo robusto, dalla parte interna, c’erano tre sostegni per reggere una pentola per la cottura dei cibi.
-Càntaru = pitale smaltato bianco a forma cilindrica, con quattro manici; era usato, quando ancora non esisteva il bagno moderno.
-Rinali = orinale smaltato.
- Cuvecchiu = coperchio per giare e pentole varie.
- Burraccia = borraccia, contenitore portatile per acqua potabile o altri liquidi.
- Raffìa = bacinella smaltata per lavare verdura e stoviglie.
- Picciunara = bevino per colombi. -Vasu di purpa = “ciappula” (trappola) per polipi.
-Pupidda = statuette sopramobili. -Friscaletti = fischietti per giocare i ragazzi.