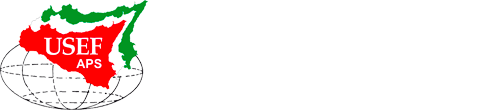(SA) - Continua la serie delle antiche lavorazioni legate alla civiltà contadina, che contribuiscono a darci uno spaccato della vita dei nostri antenati, una vita che portò le proprie usanze fin dopo la seconda guerra mondiale, quando le cose cominciarono a cambiare. Eravamo entrati nel periodo del boom economico che vide le trasformazioni della società e dei sistemi di vita,
(SA) - Continua la serie delle antiche lavorazioni legate alla civiltà contadina, che contribuiscono a darci uno spaccato della vita dei nostri antenati, una vita che portò le proprie usanze fin dopo la seconda guerra mondiale, quando le cose cominciarono a cambiare. Eravamo entrati nel periodo del boom economico che vide le trasformazioni della società e dei sistemi di vita,
dovuta alla comparsa di tanti oggetti che da un lato facilitavano e rendevano meno pesante la v ita delle massaie e dall’altra portavano a superare le vecchie usanze. Periodo in cui comincia lo spopolamento delle compagne caratterizzato dalla fuga dei contadini verso le città e verso la grande industria. Però non possiamo e non dobbiamo dimenticare da dove veniamo e la storia della vita della nostra società. Oggi, il nostro collaboratore Vito Marino ci porta a conoscere come nasceva l’olio, estratto dalle olive a prezzo di una grande fatica, poiché tutto avveniva in maggior parte utilizzando il lavoro manuale con l’aiuto anche delle bestie, fedele compagne dei contadini. Quello che oggi Vito ci presenta è appunto “lu trappitu” , antico frantoio dove avveniva la lavorazione delle olive e la produzione di quel prezioso liquido che si chiama olio.


IERI OGGI
LA MOLA O TRAPPITU (FRANTOIO)
Intorno agli anni ’40 del secolo scorso, le olive raccolte venivano portate al “trappitu” o “mola” (frantoio), a dorso di mulo o col carretto, per la molitura e l’estrazione dell’olio Nel frantoio allora c’erano diversi contenitori in muratura dove ogni cliente versava le sue olive. Oppure lasciavano le olive dentro i sacchi di iuta. Allora non c’erano ancora le cassette o i cassoni di plastica che lasciano traspirare il contenuto e, purtroppo, i tempi di lavorazione nel frantoio erano troppo lunghi e bisognava aspettare molti giorni, prima che arrivasse il proprio turno; nel frattempo le olive fermentavano e si ammuffivano ottenendo un olio d’infima qualità. I proprietari aggiungevano anche del sale per far deporre l’acqua contenuta nelle olive e per non farle fermentare. L’olio certamente aveva una forte acidità ed un gusto non tanto gradito al palato, ma ci si era abituati e non ci si faceva più caso. Allora tutto il ciclo della lavorazione avveniva manualmente. La macina o “mulazza” era composta da una base “scudedda” o “mola suttana”, una vasca rotonda del diametro minimo di due metri, all’altezza di 80 cm. dal pavimento, sulla quale giravano da una a quattro grosse ruote di pietra molare poste in verticale: “mola suprana”, azionate da un asino. Le olive, sotto il peso delle ruote, si schiacciavano grossolanamente. La pasta delle olive uscita dal frantoio si metteva in grosse "coffi d’ogghiu” (contenitori fatti di giunco) e si procedeva alla torchiatura. La pressa era formata da due travi robuste verticali più due trasversali fra le quali era ancorata una grossa vite elicoidale (il tutto in legno); sotto si sistemavano sette od otto "coffe" e si stringeva il tutto facendo girare la vite con una lunga trave spinta a mano da quattro persone: due spingevano e due tiravano per avere maggiore effetto. Da questa prima spremitura usciva un liquido composto da acqua e poco olio. Le “coffe” quindi si “scuffavanu”, cioè si svuotavano del contenuto, e la pasta si rimetteva nella macina e, quindi, di nuovo sotto la pressa. Questa operazione si ripeteva per tre volte. Durante la spremitura, tutto il liquido fuoruscito scolava dentro una o più vasche, quindi si versava nelle tini, per la decantazione e si aspettava che l’olio, più leggero dell’acqua affiorasse per processo naturale. Dopo alcune ore l’olio affiorato si raccoglieva e si versava in contenitori, per portarli a casa; l’ultimo strato sottile di olio affiorato si raccoglieva con una “piattina”, piatto piano di zinco. I contenitori per portare l’olio a casa potevano essere: “l’utri” (otri fatti di pelle di capra), barilotti di legno di circa 10 litri e i “cafisi”, contenitori che, secondo l’usanza locale potevano avere una capienza di 5 – 7 – 8 litri; a Castelvetrano erano considerati di sette litri. Questi contenitori si portavano a casa col carretto. Qui l’olio si versava nelle “giarrotte” di terracotta di circa 25 litri, oppure nei grossi “stagnuna” capienti anche 300 litri. Nel corso dell’anno l’olio si “tramutava”, si travasava anche due volte per togliere i fondi “la muria”,(la murga), che si utilizzava nelle lucerne “spicchiu” o per la saponificazione. Siccome una volta tutti i lavori (anche quelli relativi all’olivo) erano eseguiti a mano occorreva molta mano d’opera. La ciurma numerosa di persone che lavoravano nel frantoio erano chiamati “trappitara” Tutto il lavoro del frantoio e la “ciurma” (i lavoratori) erano sotto la direzione del “mastru di chianca”. Intanto nel frantoio tutto il liquido che restava, dopo aver tolto l’olio si versava in una grande vasca “la morta”, dove affiorava ancora dell’olio, che a fine campagna olearia poteva essere consistente. Siccome la vasca non era mai sufficiente a raccogliere tutto quel liquido, periodicamente si faceva uscire una parte da un buco alla base che comunicava con la fognatura; l’olio essendo leggero restava sempre in superficie. Purtroppo quest’olio era di pessima qualità e si usava per la saponificazione o si regalava alle varie chiese, per accendere “lu spicchiu o la lampa” (lucerna). Si racconta che la vasca “la morta” venisse chiamato da qualcuno anche “priatoriu” perché l’olio veniva ceduto per accendere una lucerna per le anime del purgatorio. Ho sentito raccontare da diverse fonti che abusivamente il padrone del frantoio praticava un foro nel tubo che trasportava il liquido, che lasciava gocciolare in un recipiente per tutta la campagna olearia. Questa goccia veniva chiamata “allammicu”. Quelle gocce, durante tutto il periodo della campagna olearia diventavano olio di una certa quantità. Una curiosità: grazie alla facilità di trovare olio sul posto, prima dell’arrivo della luce elettrica (inizi 1900), l’illuminazione del “trappitu” era assicurato da “lu spicchiu trappitaru”. Si trattava di una grossa lucerna formata da trenta “spicchi” disposti su tre ordini; invece, per l’illuminazione delle abitazioni c’era “lu spicchiu” (la lucerna) di terracotta, che bruciava olio o “muria” (morchia) tramite “lu mecciu” (stoppino di cotone). Tante volte, per non aspettare la decantazione dell’olio nel frantoio, il liquido ottenuto era portato a casa, con “l’utri” (otri di pelle di capra) e versato nelle “giarre” (giare di terracotta smaltate) o dentro “li stagnuna” (contenitori di lamiera stagnata). Qui decantava nel corso di diversi giorni; l'olio, più leggero dell'acqua, affiorava e si toglieva con una “cannata” (brocca). Quando incominciava ad affiorare meno olio, il liquido rimasto si metteva in recipienti più stretti e l’olio si raccoglieva con la “piattina”, un piatto metallico poco concavo. Tempi che furono! Oggi l’oliva si raccoglie ancora verde e “l’ogghiu novu”, un olio extra vergine, ha un gusto eccezionale un po’ piccante che sa di peperoncino. A Castelvetrano c’è ancora l’usanza di gustare l’olio nuovo subito con il pane nero di frumento tumminia, appena uscito dal forno. Questa specialità viene chiamata “pani cunzatu”. I residui liquidi finivano nella fognatura. Nelle fogne che scorrevano fuori del paese a cielo aperto, in certi posti dove la melma ristagnava, affioravano in superficie ancora piccole quantità d’olio; qualcuno li recuperava come materia prima per ottenere il sapone. “Lu nozzulu”, (la sansa, i residui solidi della molitura) erano lavorati ulteriormente dalla distilleria “S.P.E.R.O.” di Castelvetrano, ottenendo olio di sansa. La parte secca rimasta veniva ulteriormente utilizzata come ottimo combustibile nelle calcare; a sua volta, dopo spento, “lu nozzulu” veniva riutilizzata nei bracieri per il riscaldamento domestico. (VITO MARINO)